25 aprile 2025, giorno della Liberazione italiana. Per raggiungere l’Ucraina, dove io e la curatrice e ricercatrice Sofia Baldi Pighi siamo ospitati dal programma di ricerca della Vidnova Placements, abbiamo dovuto volare verso Varsavia. Poi, da lì, un treno notturno e infinito verso Kiev che ci ricorda quanto poco fluida e robusta possa essere una frontiera… tra militari che salgono di notte e passaporti portati via per ore… abbiamo una lettera di invito, recita così "Al Capo del Servizio di Frontiera di Stato dell'Ucraina, Tenente Generale… l'organizzazione pubblica Insha Osvita si rivolge a Lei con la richiesta di facilitare il passaggio delle frontiere ucraine ai due intellettuali stranieri affinché la comunità artistica ucraina possa stabilire legami con loro per future collaborazioni e mostrare il contesto in cui vivono gli ucraini affinché possano comprendere e raccontare le nostre vicende nei loro Paesi”.
Prima di arrivare scarichiamo un'applicazione sullo smartphone: abituati come siamo a scaricarle per incontrare gente, oppure ordinare del cibo sul divano, prenderne una che si chiama “Air Alert” e ci comunica tutte le volte che le zone dove siamo vengono bombardate è abbastanza straniante. Dalla nostra comoda prospettiva europea sembra un videogioco. Il telefono comincia a vibrare ogni tot, tra droni e missili balistici che sorvolano Kiev… sembrava un film, invece è reale. Tremendamente reale. La frontiera è varcata, dietro di noi l’Europa… davanti a noi, ora con noi, un territorio in cerca di pace. Pace che rischia di trovare per le ragioni sbagliate. La borsa di studio che abbiamo vinto ci porta a conoscere e intervistare artisti, scrittori, intellettuali del luogo che raccontano il mestiere di pensare mentre dal cielo piove la disperazione della guerra.
Abituati come siamo a scaricarle per ordinare del cibo dal divano, prendere un'app, “Air Alert”, che ci dice che le zone dove siamo vengono bombardate è abbastanza straniante
Qui il “privilegio” di cui spesso si parla, quello che si deve dichiarare come una sorta di conflitto di interessi quando si fanno i progetti artistici un po’ borghesi, è abbastanza palese: troppo palese. Per ragioni diverse, entrambi crediamo nelle nostre rispettive pratiche come “incarnate”, una filosofia e una pratica curatoriale che facciano uso del corpo per “dimostrare” o sperimentare le proprie teorie. Siamo venuti qui, con delicatezza e umiltà, perché la Storia ci sta passando vicino ed è irrispettoso parlare delle cose senza farsi attraversare da esse. A furia di dichiarare i problemi della cosiddetta appropriazione culturale, nessuno ha fatto più niente per raccontare condizioni che non gli appartengono. Eppure, proprio questa ci appartiene. Qui, a Kiev, sembra tutto normale e anormale insieme. Qui, a Kiev, forse rischia di morire per sempre l’idea di Europa di cui parlava Immanuel Kant: il luogo della “pace perpetua”. Le contraddizioni, adesso, come spirito del tempo. La guerra forse sta finendo, anche se non come desideravano gli ucraini: quindi sono gli ultimi colpi, i più feroci, quelli in cui anche noi rischiamo di morire decine di volte ogni giorno. La morte, quella vera, che Yulia Alenina, che ci ha invitati, definisce “notte rumorosa”.

Siamo partiti con un concept da portare a termine: provare a invertire la narrazione dei luoghi di guerra come “zoo”, nel senso in cui ne parla John Berger – luoghi in cui guardiamo le forme di vita che li abitano solo perché, paradossalmente, non possono più essere quelle stesse forme di vita che erano prima della trappola. Ci siamo dedicati a invertire questo concetto, usando quello del filosofo Ralph Acampora, che parla di “ooz”: intervistare non gli intellettuali locali perché c’è la guerra, ma farlo al di là della guerra.
Essere ciò che si era prima, che si è provato a essere durante, che dovrebbero provare a essere anche nell’avvenire (se l’avvenire, come diceva Leonardo Sciascia, avesse un futuro). Ma i concept, quando non si lavora nella stanzetta di un bel museo occidentale, si devono spesso confrontare con la realtà: in Ucraina, in questo momento, la guerra è ovunque anche quando te la dimentichi. La guerra, in Ucraina, è come l’aria che si respira: è dentro ogni volto intorno a noi, ogni secondo qui è davvero l’ultimo potenziale… il “qui e ora” non è uno statement curatoriale ma una condizione di vita. Una cosa che non ci diciamo mai è ben chiara: NOI SIAMO VIVI QUI, ADESSO. Di questo strano “ooz” adesso facciamo parte anche noi due, e i giorni che seguiranno avranno la guerra non come oggetto di interesse o studio ma come piano d’esistenza.

Solo quando si è dove gli altri parlano si capisce quanto i giornali dicano cose che non esistono da nessuna parte
Il nostro viaggio è serrato: le interviste sono tante, saltano di continuo per colpa di imprevisti. Appena arrivati visitiamo, al piano sotterraneo, il rifugio del nostro hotel: qualche sedia e coperta per ripararsi dal freddo. Non sapremo ancora che in realtà sarà questo spazio, e non le nostre belle camere al settimo piano, a ospitare le nostre notti. Un’amica attrice e regista, Fyokla Fortel, ci porta a conoscere la sua famiglia nella loro casa in campagna fuori Kiev e inizia a farci da guida tra attori, poeti e scultori. Proprio ieri, la casa accanto è saltata in aria per colpa di un drone russo. Lo stesso farà Stefano Moser, dell’Istituto Italiano di Cultura, che ci accoglie nell’Ambasciata Italiana per raccontare cosa siamo venuti a fare, ma è una strana sensazione di ansia perenne che ci perseguita. Il cielo, abituati come siamo a guardarlo con naturalezza, qui diventa uno sfondo inesistente (d’altronde è sempre dal cielo, o dalla ripresa del cielo, che nascono e muoiono le guerre e sorgono le paci). Da questo cielo può arrivare di tutto… “il cielo è aperto a qualsiasi cosa” ci dice Fyokla. Nikita ci porta a vedere la sua mostra personale al Museo Nazionale di Arte Ucraina, e nel tragitto racconta amareggiato di sua figlia di nove anni, di come spesso faccia lezione nei rifugi sotterranei e di come questa sia la sua normalità. Parliamo della sua rabbia nei confronti dei saggi che recentemente hanno scritto sull’Ucraina, Giorgio Agamben e Paul B. Preciado, che normalmente legge e stima: “Come possono dire certe cazzate sulla guerra senza venire qui a vedere cosa succede? Come pensano possa finire senza che ci aiutino militarmente? Come fa Preciado a scrivere seriamente che dobbiamo occupare con i nostri corpi queer il porto di Odessa? È allucinante”. La sua è una mostra particolare: racconta la guerra qui e ora, ma senza i compromessi tipici del mondo dell’arte contemporanea.
Le sirene della guerra, ora reinterpretate nell’installazione sonora che apre la prima sala della mostra da cantanti lirici, quasi provano a ribaltare quello strano paradosso che del contemporaneo racconta proprio Agamben… magari, se è già nel museo e se ne è fatta un’archeologia, forse la guerra fuori non esiste più. Non è così, ovviamente, e Donald Trump continua a dire a ogni giornale, in questi stessi giorni, che “siamo vicini alla pace”… beh, solo quando si è dove gli altri parlano si capisce quanto i giornali dicano cose che non esistono da nessuna parte. La gente è solo stanca, gli ucraini vogliono la tregua ma non possono pensare che i loro figli, mariti, fidanzati, siano morti per nulla. Non facile da risolvere, ma certo non difficile da capire: il padre di Fyokla, un uomo ucraino di sessant’anni che, come molti, qui parla solo russo, mi dice: “Voi avete a cuore più la Palestina che noi perché la cosa non vi scomoda… questa è la vostra guerra e dunque non volete prendere posizione”. Difficile dargli torto, difficile non sentirsi in colpa. Difficile non notare la polizia ucraina che ferma i maschi della mia età per la strada e li costringe ad andare sul fronte mentre stavano svolgendo le loro attività ordinarie. Certo che qui, di intellettuali europei a vedere cosa succede, ne sono davvero venuti pochissimi.

Visitiamo Santa Sofia: chiesa capitale della cristianità dell’Est Europa, simbolo della sapienza divina. Per i russi è la loro chiesa madre, gli ucraini la reclamano legittimamente come simbolo della indipendenza spirituale da Mosca. Qui, al suo interno, la guerra sembra sospesa. Incontriamo Kateryna Hryhorenko allo Yaroslava Café dopo aver sentito almeno due allarmi e altrettante esplosioni, causate dall’ingresso di missili balistici in città. “Qui sembra che il teatro non serva più a nulla: la gente vuole solo ridere ma io la notte dormo per terra chiusa in bagno perché ho paura…”ci porta a casa sua, durante l’intervista mi dice una cosa che difficilmente dimenticherò: “Mi sento più al sicuro qui sotto le bombe che in Europa, dove la gente di sinistra fa stupide mostre sul disarmo e pensa che la guerra si fermi coi fiori”. Stanislav, che ci mostra l’Institute of Automatics, non pensa tanto diversamente… qui, un edificio sovietico dedicato alla produzione tecnologica del regime, oggi è un immenso spazio occupato da studi di artista. L’energia è potentissima e la frizione tra guerra e creatività è evidente.
“Anche se vorremmo” – ci dicono gli artisti qui – “che smetteste di osservarci come interessanti solo perché c’è la guerra. Questa è davvero una perversa forma di pornografia del dolore”. Hanno ragione, a proposito di zoo. “È fondamentale tenerci occupati, non pensare”. Nel Teatro Black Square, in centro città, dove lavora Slava Nikonorov, per esempio, si fanno soprattutto spettacoli comici. “Qui possiamo anche non interromperli durante le bombe perché siamo nei sotterranei”: così si crea un paradosso difficile da comprendere per noi, in cui decine di persone provano a ridere mentre fuori gli stanno bombardando macchine, scuole e case. Ma in effetti, ciò che è sottoterra sopravvive, e così i ristoranti si spostano verso il basso, i bar, le attività ludiche: i russi hanno rubato la pace, il cielo e la notte di una delle città più belle che abbia mai visto. Attraversandola in lungo e in largo, dal panorama del ponte di vetro recentemente ricostruito dopo una bomba che lo aveva fatto saltare per aria, Kiev sembra la metafora di ogni altra città europea: bella, perché fragile.
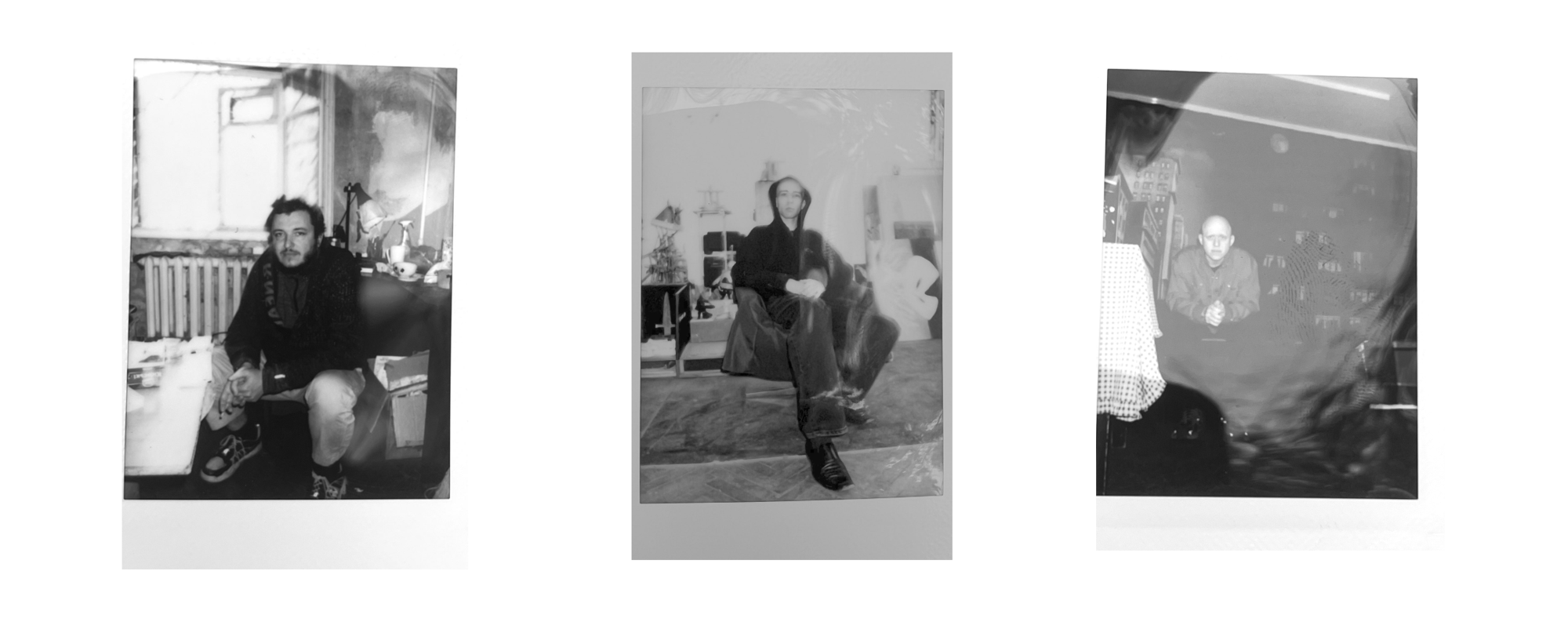
È ovvio che questa è anche la nostra guerra
Ci si abitua a tutto. Questa è la specifica forma di intelligenza della nostra specie. Adesso, dopo qualche giorno, spesso sento l’allarme missilistico ma continuo a fare la doccia: “Se succede, succede”. Solo la notte continua a farmi più paura: l’idea di non rendermene conto mi lascia attonito. Intanto oggi, 29 aprile, la giornalista ucraina Victoria Roshchyna – rapita dai servizi segreti russi e, come noto, poi morta in carcere – è stata riconsegnata alla Croce Rossa di Kiev in un sacco di plastica bianco, con la testa completamente rasata e decine di ustioni sul corpo, alcuni segni evidenti delle scosse elettriche. Mancavano tre organi: il cervello, gli occhi e la laringe. L’ipotesi – mentre in Europa, intanto, la gente si sciacqua la bocca dicendo che Volodymyr Zelenskyy dovrebbe accettare qualsiasi condizione imposta da Putin per riportare la pace – è che queste parti le siano state asportate per cancellare ulteriori segni delle torture subite in cella. Alla Naked Room, un bookshop specializzato in editoria creativa ucraina e internazionale proprio nel centro di Kiev, veniamo invitati a un evento commemorativo per ricordare una famosa artista che aveva scelto volontariamente il fronte di guerra, ed è stata uccisa: Margarita Polovinko. Aveva solo trent’anni. La sua morte è stata annunciata l’8 aprile da sua sorella, che ha scritto in un post su Instagram: “Margarita è morta difendendo l’Ucraina”. Sono storie che ci riportano, a noi europei mediterranei, ai racconti dei nostri intellettuali al fronte durante la Prima e la Seconda guerra mondiale, e che oggi ci sembrano impossibili. Una delle ultime opere di Margarita, Dream in Landing, è uno scheletro dipinto con sottile inchiostro nero mentre offre una pistola a una figura ormai prona… l'intera pagina è macchiata di rosso.

Mentre scrivo, nel maggio 2025, fonti ucraine confermate dall’Unione Europea stimano che più di 75.000 ucraini siano stati uccisi e oltre 500.000 feriti a causa delle azioni dell'esercito russo. L’invasione, che ha ucciso anche Margarita e molti altri artisti e artiste andati sul fronte – spesso volontariamente – ha avuto un costo elevatissimo per il panorama culturale ucraino. La stima per la sola ricostruzione ammonta a circa dieci miliardi di dollari, oltre alla perdita irreparabile (nonostante eventuali programmi di restauro) di monumenti e musei. Secondo l’UNESCO, almeno 670 siti sono stati danneggiati in modo permanente, tra cui 145 siti religiosi e 238 strutture di “interesse storico e/o artistico”. Quando, grazie all’intercessione di Galleria Continua, incontriamo Zhanna Kadyrova – una delle più famose artiste ucraine viventi, vincitrice nel 2025 dell’Her Art Prize, – lei descrive tutto ciò con poche parole: “Dobbiamo trovare ogni modo per raccontare ciò che sta succedendo qui, senza paraocchi. Anche ciò che sta succedendo nell’arte, attraverso l’arte”. Per una delle sue ultime opere, Mia casa, mia fortezza, Zhanna ha raccolto centinaia di foto scattate in diverse città e villaggi dell’Ucraina, inclusi i territori liberati e quelli ancora occupati, come la Crimea ormai annessa. Il risultato – decine di case distrutte accompagnate dai testi che raccolgono le parole di chi le abitava – è straziante. Lo studio di Zhanna si trova in un posto incredibile: una sorta di magazzino dismesso, parte di un complesso di altri magazzini ora riconvertiti in club di musica elettronica, laboratori di artigianato, ristoranti spontanei. Qui si suona, si vive, si canta… proprio dove la gentrificazione, poi bloccata dalla guerra, avrebbe dovuto abbattere tutto per costruire l’ennesimo grattacielo (uno strano paradosso, in effetti). “Ci godiamo ogni secondo — ci dice — perché qui è anche l’ultimo.”
Come si vince una guerra senza avere più una casa?
Nessuno lo racconta, ma la vera forza e resistenza dell’Ucraina consiste nel continuare a vivere, fare arte, aprire librerie e gallerie di design
Il primo maggio è la Festa del Lavoro. In Ucraina, ovviamente, tutte le “feste” sono state abolite per rispetto dei militari al fronte. Su consiglio di Gianluigi Ricuperati — un caro amico e forse l’unico intellettuale italiano ad essersi davvero occupato di questa guerra in modo serio — incontriamo Andrii Ushytskyi, che coordina una rivista meravigliosa: Solomiya. Il loro ultimo numero è dedicato alla decostruzione della mascolinità e del mito della forza in guerra. Andrii definisce Kiev “la città in fiore di castagno”, e la sua scena editoriale effettivamente pullula di indipendenza e qualità invidiabili. Visitiamo la libreria Zbirka, in un quartiere interessante, con un’atmosfera europea più marcata che altrove in città. Qui recupero una serie di libri fotografici chiamati Living the War, che raccontano la guerra su larga scala dal 2022, attraverso immagini e testi che mi aiutano a comprendere meglio il mio stesso lavoro qui. Alona Karavai, direttrice dell’organizzazione che ci ha invitati, ci accompagna all’inaugurazione della mostra di Barbara Kruger nella Red Hall della Stazione Centrale (la stessa in cui siamo arrivati col treno notturno). Nessuno lo racconta, ma la vera forza e resistenza dell’Ucraina consiste nel continuare a vivere, fare arte, aprire librerie e gallerie di design — proprio durante il conflitto — mostrando come la forza della vita si manifesti piena e possente, davanti alla tristezza e mediocrità di una morte imposta dalla vigliaccheria dei droni sparati da lontano. Altre notti in rifugio passano in fretta. Le giornate qui sono intense: paurose, ma bellissime e piene di energia come da noi europei mediterranei non lo sono più da molto tempo.

Quando chiediamo a Oleksii Havryliuk, giovane ricercatore locale che ci racconta come, anche durante questa guerra, sia nato il primo festival dedicato alla cultura queer, cosa spera per il futuro, la risposta è spiazzante: “Sopravvivere, o almeno farlo avendo ancora tutti i miei arti attaccati al corpo”. Parlando con Yelyzaveta Korneichuk, straordinaria intellettuale e giornalista, mi dice una cosa che forse dovremmo ricordare più spesso: “Quando l’Italia doveva essere liberata dal fascismo, noi eravamo lì a combattere con i vostri partigiani. Insieme ai russi, certo, ma noi c’eravamo. Voi?” In centro inaugura un nuovo negozio di abbigliamento, tema “sindacare ottimismo”: anche qui, come un po’ ovunque in città, domina la musica elettronica. Non a caso, la storia di questa “disciplina” sembra essere intimamente legata alle energie generate dall’idea della fine del mondo. “Non potete capire nulla però se restate qua e non andate sul confine…” una frase che forse era meglio non sentire. Così proviamo a prendere al volo un treno per la frontiera con la Russia, destinazione Charkiv, dove dovremmo riuscire a curare la nostra mostra di arte contemporanea. Sono le cinque del mattino, direzione stazione, ed ecco suonare l’allarme antimissile: siamo costretti a tornare nel rifugio. Treno (e soldi) persi. Forse non è poi così vero che non si capisce da qui cosa sia l’Ucraina… come ci ha detto oggi l’artista Alina Zamanova: “Qui, nel nostro paese, nessun posto è più sicuro di un altro”.
Festa underground in un club accanto all’ascensore sul lungofiume di Kiev: ancora una volta, alla guerra diffusa corrisponde una forza uguale e contraria. Gli ucraini non ballano, muovono la terra con la forza dei loro passi. Al Pinchuk Art Centre, la mostra di Yevhen Korshunov — basata sulle sue memorie da militare — è la più raffinata forma di introduzione poetica alla guerra che io abbia mai visto. Come dice Sofia, qui con me: “Questo lavoro è struggente”. Le vite di artisti spezzate e condotte con forza alle armi: qui, di nuovo, come da noi non lo è più da anni, l’arte torna utile a capire la condizione delle nostre esistenze. Anton Shebetko espone nello stesso museo una lunga ricerca su come la comunità LGBTQIA+ ucraina sia stata devastata dal conflitto su vasta scala, e su come le identità non etero-normative abbiano messo in crisi la rigida distinzione maschile/femminile che ogni guerra impone agli Stati. Si dice spesso che Putin abbia attaccato l’Ucraina per impedire l’allargamento della NATO a est. Ma stando qui si capisce qualcosa di molto più profondo: Putin voleva impedire l’allargamento di un’idea di diritti civili, sogni e speranze, che stavano avanzando verso il suo ovest. Ripeterlo è necessario: questa è la nostra guerra. Incontriamo Yarema Malashchuk e Roman Khimei, un duo di registi, nel loro bellissimo studio in Bulvarno-Kudriavska. È la nostra ultima giornata piena a Kiev. Ieri hanno bombardato fino alle sei del mattino, e ho completamente dimenticato cosa significhi dormire: dopo qualche giorno si diventa un fascio di nervi, talvolta zombie assonnati.

Yarema e Roman, come se niente fosse, mi dicono mentre ci preparano il pranzo che è talmente tanto tempo che non possono più uscire dall’Ucraina, che ormai pensano che tutto il mondo funzioni così: sirene, bombe, rifugi. Partiamo nel pomeriggio dalla stazione dei bus di Kiev, arrivo previsto in Polonia il mattino seguente. Vedo tanti papà in divisa militare salutare donne e bambini. Mi rendo conto che per loro può essere davvero l’ultimo saluto, eppure ridono, scherzano, si dicono Slava Ukraini (“Lunga vita all’Ucraina”). Dopo un numero incredibile di ore in autostrada — droni visti da lontano, stop in mezzo al nulla per le ragioni più varie — arriviamo a una frontiera ottocentesca da attraversare a piedi per motivi di sicurezza. Io, uomo, sarò trattenuto molto più a lungo da un sergente dell’esercito che non si capacita del perché io sia venuto qui “senza nessun motivo”. Poi capisce, mi dice: “Grazie”. Ci sono decine di ucraini in attesa, una stanzetta gelida e piena di speranze, e poi dall’altro lato le bandiere polacche ed europee ad accoglierci. Le ho viste anche in centro a Kiev, queste bandiere blu con le stelle che richiamano la corona della Vergine Maria… ma la stella mancante era proprio l’Ucraina. In Polonia quella bandiera significa “siete salvi”, in Ucraina un più speranzoso “vogliamo esserlo anche noi”.
Io sono qui, nel mezzo tra due mondi che forse sono uno solo, pronto a tornare alle mie preoccupazioni borghesi: inutili problemi legali, bollette da pagare, il mutuo, annaffiare le piante e provare a lavorare ancora in un sistema culturale italiano che si è totalmente bevuto il cervello, non occupandosi più di nulla che non sia ovvio o irrilevante. Eppure, quando finalmente riesco a passare e risalgo sul bus che mi porterà attraverso l’Europa, non posso non pensare che questo suolo polacco è lo stesso che Hitler invase, e da cui iniziò un inferno che conosciamo tutti benissimo. Una storia simile, temo, ma che proviamo a ignorare a ogni costo. Non sono felice. Il senso di colpa per poter finalmente riposare, o fissare degli inutili appuntamenti a Milano, mi lascia indifferente. Dò un’occhiata a Instagram, dopo settimane di disinteresse, e vedo amici e nemici parlare del “loro nulla” facendone qualche meme. In qualunque modo stiamo usando il nostro privilegio — che, posso assicurare, ha i minuti contati se non ci occuperemo dell’Ucraina seriamente — lo stiamo facendo in modo profondamente sbagliato. L’odore di Kiev è l’odore di casa nostra. Non permettiamo a nessuno di trasformare la pace in guerra senza aver lottato fino alla fine: al di là della pace a ogni costo, esiste la dignità. Slava Ukraini, Slava Europa.
[la versione originale in inglese di questo reportage è stata commissionata e pubblicata dal Modern Times Review. Si ringraziano il Vidnova Placements e la Fondazione Insha Osvita per aver sostenuto la ricerca]



