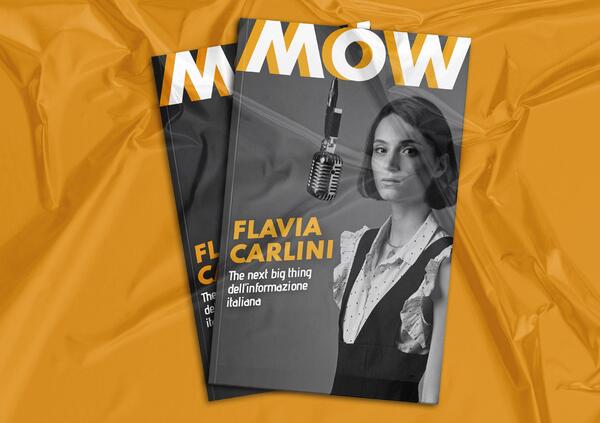Chi c’è c’è, non gliene frega. Lui si cala i pantaloncini e resta nudo. Ha l’accortezza minima di dare le spalle, anche se sarebbe più corretto dire il culo. Poi si infila i pantaloni della tuta e come se niente fosse si rigira. I pochi presenti, tra cui una donna, fingono di guardare il cellulare ma sono basiti. Alessandro Botturi fa un mezzo sorriso e dice: “Scusate, ma questo è un po’ lo spirito del fuoristrada, del bivacco, ai corsi lo dico sempre mentre ci vestiamo: oggi non esistono ingegneri, architetti, oggi tra i sassi e i rovi e i rami e le buche, ci siamo solo noi. Se non sali in moto ti prendi le parole dietro. Se non vai ti prendi le parole dietro. Bisogna arrangiarsi. E soffrire”. Signore e signori, l’enduro condensato in due parole: arrangiarsi e soffrire. Un modo di vivere. Alessandro Botturi.

Alessandro Botturi, un gigante buono, piazzato, tosto, un fisico da muratore bresciano (troppo facile la metafora, è di Lumezzane), bicipiti e polpacci così grossi che gli sponsor fanno fatica a fargli l’abbigliamento su misura, una forza esagerata tanto che una volta, pedalando, ha spezzato la catena di una bici. E se guardiamo indietro: 8 Parigi-Dakar, nazionale Enduro e vincitore con la squadra italiana alla Sei Giorni del 2005 e 2007, un passato da rugbista. E, soprattutto, Alessandro l’Africano, perché ha vinto le ultime due Africa Eco Race, le uniche, per ora, a cui ha partecipato. Perché lui sa cosa ci vuole, l’ha interiorizzato da sempre: arrangiarsi. E soffrire. Adesso è uomo Yamaha. Colline piacentine, sul Tidone, pausa del servizio fotografico con la sua WR 450 F e il nuovo Ténéré 700 Rally Edition, due moto della stessa colorazione e della stessa natura, una che l’Africa la fa davvero e l’altra destinata a chi la sogna. Davanti un piatto di ravioli, salumi, crostini. E un registratore.

Partiamo dall’inizio, le origini.
“Mia mamma è due anni che non c’è più ma alla fine è sempre stata lei quella che mi ha spinto, mi ha sempre dato carta bianca in tutto. Esilde, nome strano e donna molto moderna. Nonostante io lavorassi già, quando c’è stata la possibilità di trasformare il motociclismo in una professione, mi ha detto: provaci, tanto per tornare a lavoro c’è tempo. Mio babbo, tornitore e fresatore, invece non mi ha mai spinto. Ma è lui l’appassionato. Ancora oggi conserva le sue moto: Gilera 175 4 tempi, vecchie KTM”.
Tutte da fuoristrada…
“Sì sì, perché a Lumezzane l’enduro è lo sport ufficiale, una tradizione, quando ci sono le gare si ferma tutto il paese. Il motorclub del paese è prestigioso, ci hanno corso anche Giovanni Sala, Passeri, Rinaldi. Ci sono legato. Infatti mi conoscono tutti, sono un po' la celebrità. Lumezzane ha prodotto anche dei calciatori di serie A, ma quelli non vengono quasi mai in città, io invece ci vivo e sono sempre stato cosi come sono, saluto tutti. Sono tutti miei amici e tifosi”.
Il tuo primo ricordo legato alle moto e a tuo padre qual è?
“Io a bordo strada con la bandierina a segnare il percorso delle gare regionali”.

E il rugby?
“Altro sport di Lumezzane. Ero robusto, mia mamma aveva un negozio di alimentari e abbigliamento, i dirigenti passavano e le chiedevano: perché non lo fai giocare a rugby? Ho giocato dall’età di 12 fino ai 22. Ho fatto 3 o 4 anni nel giro nella nazionale, primi 90. Ma da quando ho 13 anni corro anche in moto. Però l’impegno con il rugby era davvero tanto perché mi allenavo 3 volte a settimana più le partite, dalla C all’A2. Ma poi ho vinto l’italiano junior in enduro e da lì è partita la mia carriera motociclista”.
Ruolo nel rugby?
“Pilone e tallonatore, quello di mischia, il primo che va a contatto con l’altro. Testa bassa, spingere di spalle e via. Ma io ero un pilone e tallonatore moderno, quando prendevo la palla alzavo la testa e avevo la visione di gioco. Come diceva il mio allenatore, ho sempre guardato lontano”.
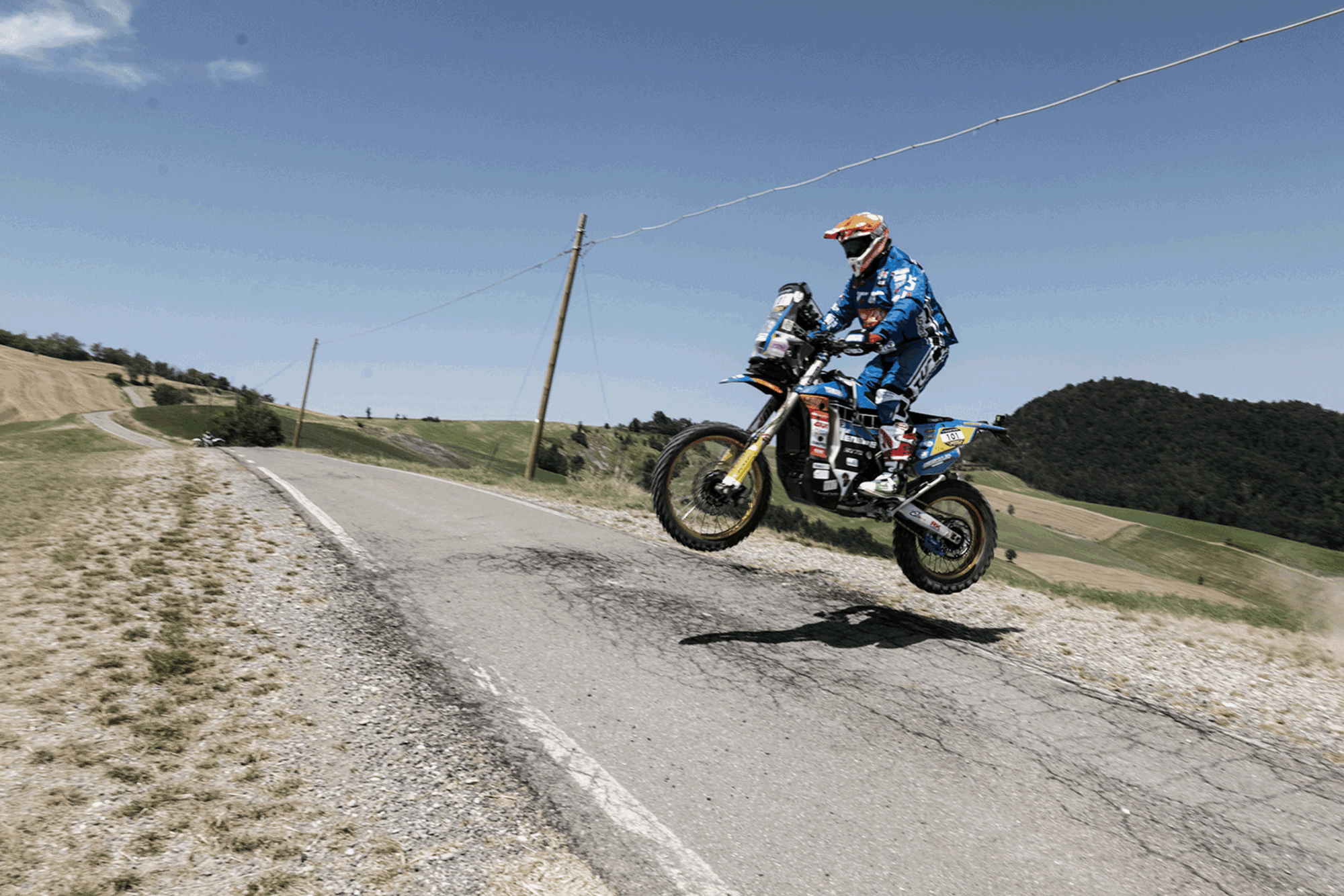
Una caratteristica che ti sei portato dietro anche nelle moto. Perché uno potrebbe pensare che hai una guida molto irruente e invece è pulita e impostata sul lungo periodo…
“L’endurista vero guarda avanti. Deve avere il colpo d’occhio in qualsiasi situazione. Infatti il passaggio nei Rally per me ha significato tanto, tutto, perché devi avere una visione, devi calcolare molto, in una Dakar di 7/8 mila chilometri non puoi pensare di partire e girare il gas. Devi pensare che i km sono tanti e che il primo obiettivo è fare meno errori possibili. Anche una caduta stupida può pesare, perché prendi delle botte che poi ti fanno male per tutta la competizione”.
Perché hai preferito l’enduro al rugby?
“L’anno che ho smesso avevo la proposta di andare a Calvisano, in serie A, ma la condizione era che dovevo smettere di andare in moto. Non me la sono sentita perché in moto vincevo, vincevo quasi sempre. Ero più forte. Ho fatto 7 anni in KTM con Farioli, ho vinto titoli italiani, la Sei giorni e due volte terzo nel campionato mondiale individuale, conquistando varie tappe del mondiale. E poi 27 podi, podi in tutti gli indoor di Europa, a Barcellona, Genova, Lione, secondo all’Hell’s Gate, il miglior risultato di un italiano, e quarto all’Erzbergrodeo. Ero competitivo ovunque”.
Cos’è l’enduro?
“Come lo interpreto io, è tanta passione innanzitutto. È il mio spirito di vita, anche se, ti confesso, i primi anni dell’enduro non è stato facile”.
Motivo?
“Con il rugby ero abituato al terzo tempo: botte in campo e poi a bere tutti insieme. In enduro molte volte i miei avversari invece di salutarmi mi guardavano storto. Rivalità, ma per me è un cosa che non è mai esistita fuori dalla gara”.
Infatti tutti dicono: non si può non voler bene ad Alessandro Botturi.
“Io ho corso con team ufficiali come KTM, Honda, Aprilia, Gas Gas, Husqvarna ma mi sono lasciato in bellissimi rapporti con tutti, spiegando perché li lasciavo. E se ricevevo una proposta interessante non la nascondevo”.
Cosa ti porta l’enduro nella vita quotidiana?
“Insegna a gestire la paura dei cambiamenti. Sono sempre stato convinto di quello che andavo ad affrontare e non ho mai rimpianto quello che ho fatto prima. Sentivo piloti che dicevano: cavolo però con quella moto mi trovavo meglio. Per me ogni moto su cui salivo era il top. Dovevo essere io bravo ad adattarmi, non il contrario. E poi lo spirito di libertà, di aggregazione. A me piace stare con la gente, con il gruppo. Io organizzavo delle feste, prima e dopo la Dakar, invitavo più di 500 persone e il ricavato lo davamo in beneficienza al reparto oncologico pediatrico civile di Brescia. E se mi invitano a cena in qualche motoclub non vado a fare la comparsata istituzionale, alla fine sono sempre uno degli ultimi che esce dal locale. Mia moglie impazzisce, le dico che torno a casa presto e a volte torno anche il giorno dopo”.
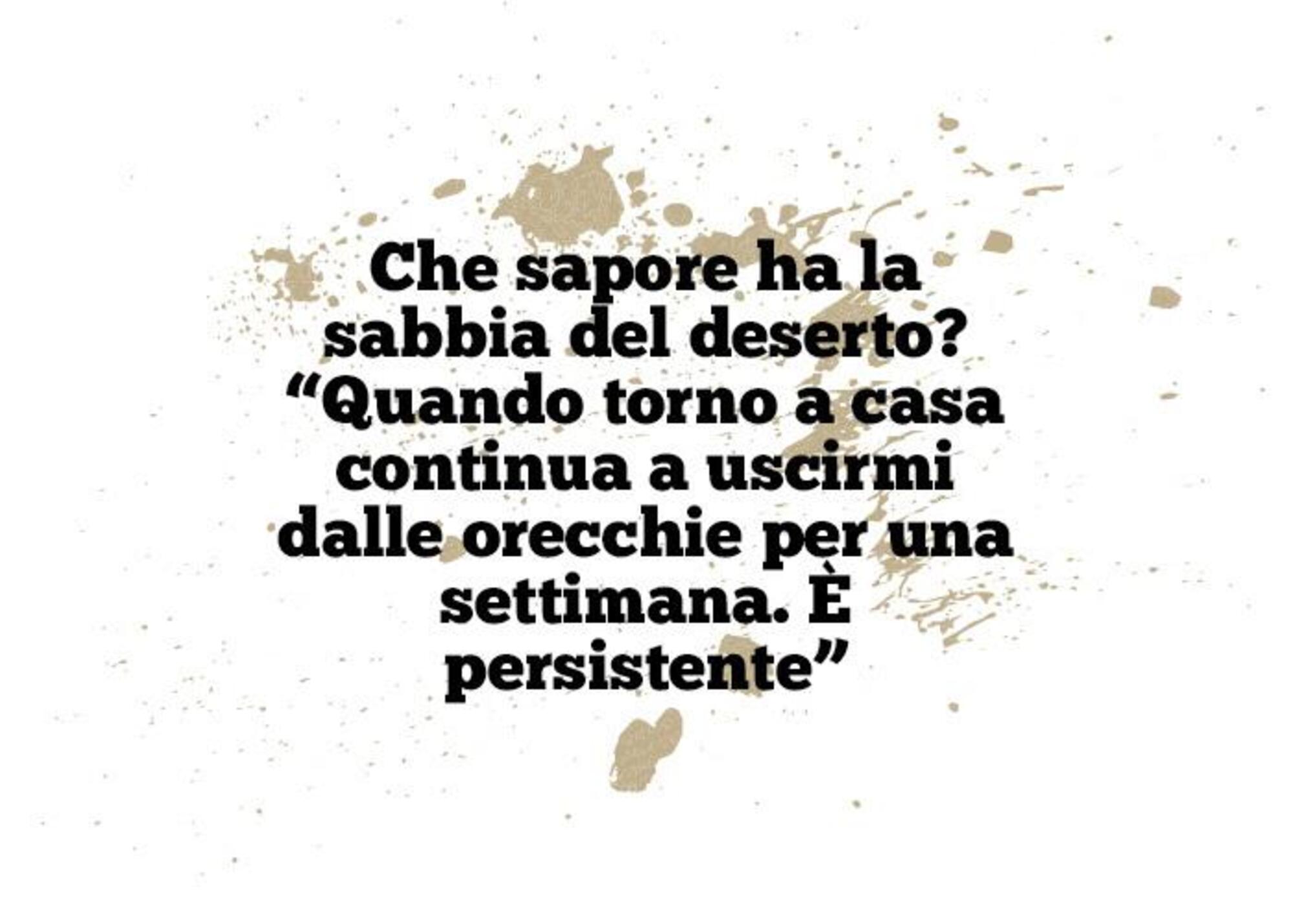
Che rapporto hai con il dolore?
“Forse ho una soglia del dolore molto alta. In una Dakar ho rotto il polso il secondo giorno, la moto all’undicesima tappa e poi mi sono ritirato. Quando ho fatto la lastra il dottore mi dice: non ci credo che hai fatto 10 giorni con un polso cosi, hai le ossa in giro”.
Come è avvenuto il passaggio dall’enduro ai rally?
“Avevo il sogno della Dakar, da ragazzino. E la prima l’ho fatta nel 2012 perché dopo una gara di enduro stavo mangiando con gli amici e parlavamo proprio di lei. C’era pure l’architetto Ferrari, che mi fa: se la fai l’iscrizione te la pago io. Quindicimila euro. Una settimana dopo mi ha chiamato dicendo che faceva il team e da lì siamo partiti”.

Quanto costa fare una Dakar?
“In totale? 100 mila euro e rotte. Ma le mie sono state tutte sfortunate. La seconda ero quinto fino alla penultima tappa, mi stavo giocando il podio e avevo le carte per farlo, ma ho rotto a 60 km dalla fine della penultima tappa. L’anno dopo ho rotto il secondo giorno. Nel 2015 passo in Yamaha, moto sperimentale. Pioveva. Il 2016 è stata quella del polso e anche nel 2017 e 2018 ho tirato due belle botte”.
Hai corso con Paulo Goncalves, che a gennaio è morto proprio durante la Dakar.
“Mi è arrivata proprio qualche giorno fa una foto di noi due insieme. Una persona correttissima, un ragazzo meraviglioso. Nel 2013 ho rotto il penultimo giorno ma sono arrivato al traguardo lo stesso, e quando c’era da salire sul palco mi ha caricato Paulo sulla sua moto. Questo è il ricordo più bello che ho di lui”.
Pensi spesso a lui?
“Sinceramente? No. E quando ci penso cerco di evitare. Una sorta di protezione. Troppe volte te la vedi brutta. Troppe volte ti giochi un jolly. Magari non sei così attento, fai un salto, voli via con i piedi in aria e poi riatterri. In quel momento lì, mentre cadi in avanti e stai andando a 100 all’ora, imprechi, preghi, e poi ti accorgi che è andata bene un’altra volta. All’ultima Africa Eco Race, quando sono caduto, tutti mi guardavano male, volevo vedere in che stato fossi e mi sono fatto un selfie”.

Differenze tra Dakar e Africa Eco-Race?
“La prima è davvero dura ma perché ci sono tutte le case ufficiali. L’Africa Eco Race è lo spirito della vecchia Dakar, l’obiettivo degli organizzatori è di portare più gente possibile. In Sud America, poi, la Dakar è dura perché passi attraverso condizioni climatiche completamente differenti fra loro. In Argentina ad esempio c’erano 50 gradi, in Bolivia sotto zero e 5000 metri di altitudine. La sera sei veramente stremato. L’Africa mi si addice di più, il terreno è sassoso, le piste più veloci, faccio le prime due settimane in Europa, da Monaco fino al Marocco, e quando arrivo nella sabbia vera ho sempre un po’ di vantaggio. Poi nel deserto, Mauritania e Senegal, riesco ad amministrare. In Sud America invece la sabbia la fa da padrona, se non sei un pilota bravo su quel terreo è impossibile che riesci a stare in piedi”.
Che sapore ha la sabbia del deserto?
“Quando torno a casa dall’Africa, per una settimana o 10 giorni, mi esce dalle orecchie. È persistente”.

Ci sono posti dove hai corso e in cui vorresti tornare?
“Non in Bolivia. La odio. Perché quando ci passi con la Dakar piove, è freddo, non respiri perché manca l’ossigeno. Ma forse proprio per questo, con un gruppo di amici, dovrei andarci. Però l’Africa… L’Africa è un’altra cosa”.
Detto popolare: l’Africa non si racconta, si vive.
“Guarda che è incredibile. Io dico sempre. Sei in mezzo al niente per chilometri infiniti, incontri sei caprette con 2 bambini al pascolo, e poi altri chilometri infiniti senza vedere altro. Ti chiedi: ma come fanno questi qua a stare così soli? Tirano su un po' di latte, sanno dove sono i pozzi e vivono. In Tunisia ho visto la scena che mi è rimasta più impressa. Intorno solo deserto e a un certo punto vedo delle pecore. Mi guardo intorno e sotto l’unica pianta che faceva un po’ d’ombra c’era una famiglia nomade, con le pentole attaccate ai rami. Vivevano lì. Un bambino avrà avuto 5 anni, l’altro forse uno”.
Ti rendi conto che la resilienza è una caratteristica dell’essere umano: riesce ad andare avanti sempre e comunque.
“La forza dell’essere umano è riuscire in qualsiasi caso a uscire dai problemi. Anche con un pezzo di pane si può vivere. Invece il nostro stile di vita ci ha portato a volere troppo e a sentirti inferiore se ti manca qualcosa. Lì eravamo nel deserto del Sahara, mi sono dovuto fermare per riparare il piantone con un po’ di plastica e fascette. Ma l’Africa ti mette davanti a ste scene. Una volta un taxista, in Marocco, mentre ci stava portando in aeroporto si è dovuto fermare 3 volte per riparare qualcosa. E alla fine siamo arrivati dove dovevamo arrivare. Tutte le volte che torno dall’Africa rimango 15 giorni con la testa un po’ così e mi scontro sempre con mia moglie perché alla fine cerchi di non far mancare niente a nessuno però spesso ti rendi conto che la nostra impostazione è sbagliata. Ogni volta che torno mi prometto che dovrei spiegarlo ai miei figli che si può vivere senza niente”.
Cos’è il sacrificio per te?
“Divertimento”.
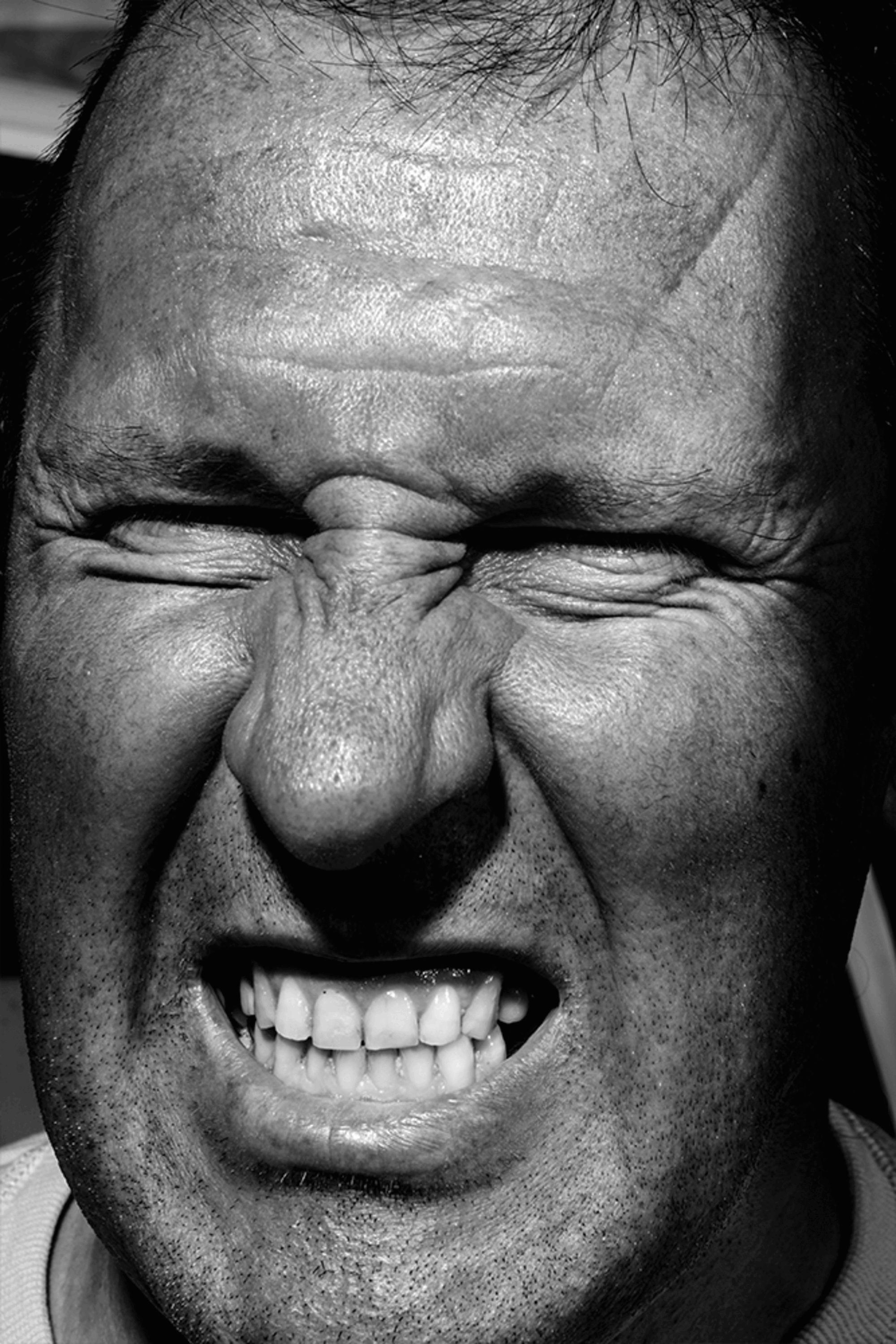
Soffrire di solito non diverte.
“Raggiungere un risultato mi rende contento. Quando ottieni qualcosa con l’impegno capisci che nessuno e niente ti può frenare. È qualcosa che mi è stato trasmesso. A casa mia, anche sul mangiare, è valsa sempre la regola del più veloce: mia mamma portava il vassoio di pasta, e tra lei, mia sorella e mio papà chi era più veloce prendeva la porzione più grande. Mi sono adeguato. E cerco di insegnare tutto questo anche i miei figli”.
Quanti anni hanno?
“Giorgio dieci, Daniele 7. L’altra sera siamo andati a camminare in montagna, a vedere un santuario, a fare il bagno nel fiume. Spesso vengono con me alle gare. Giorgio va in moto, ma non gli sto addosso. A Daniele invece le moto fanno schifo”.
Altra cosa che tutti dicono di te: hai una famiglia bellissima.
“Loredana, mia moglie, lavora in un supermercato, ci conosciamo da ragazzini, io avevo 24 anni, lei poco meno. Era la fidanzata di un mio amico poi si sono lasciati e dopo un po’ ci siamo incontrati in un locale e abbiamo passato la sera a parlare. È scoccata la scintilla”.
Hai il fisico da Tyson ma sei agile come Yuri Chechi.
“Ho sempre impressionato tutti da questo punto di vista perché sono grosso ma faccio la verticale”.
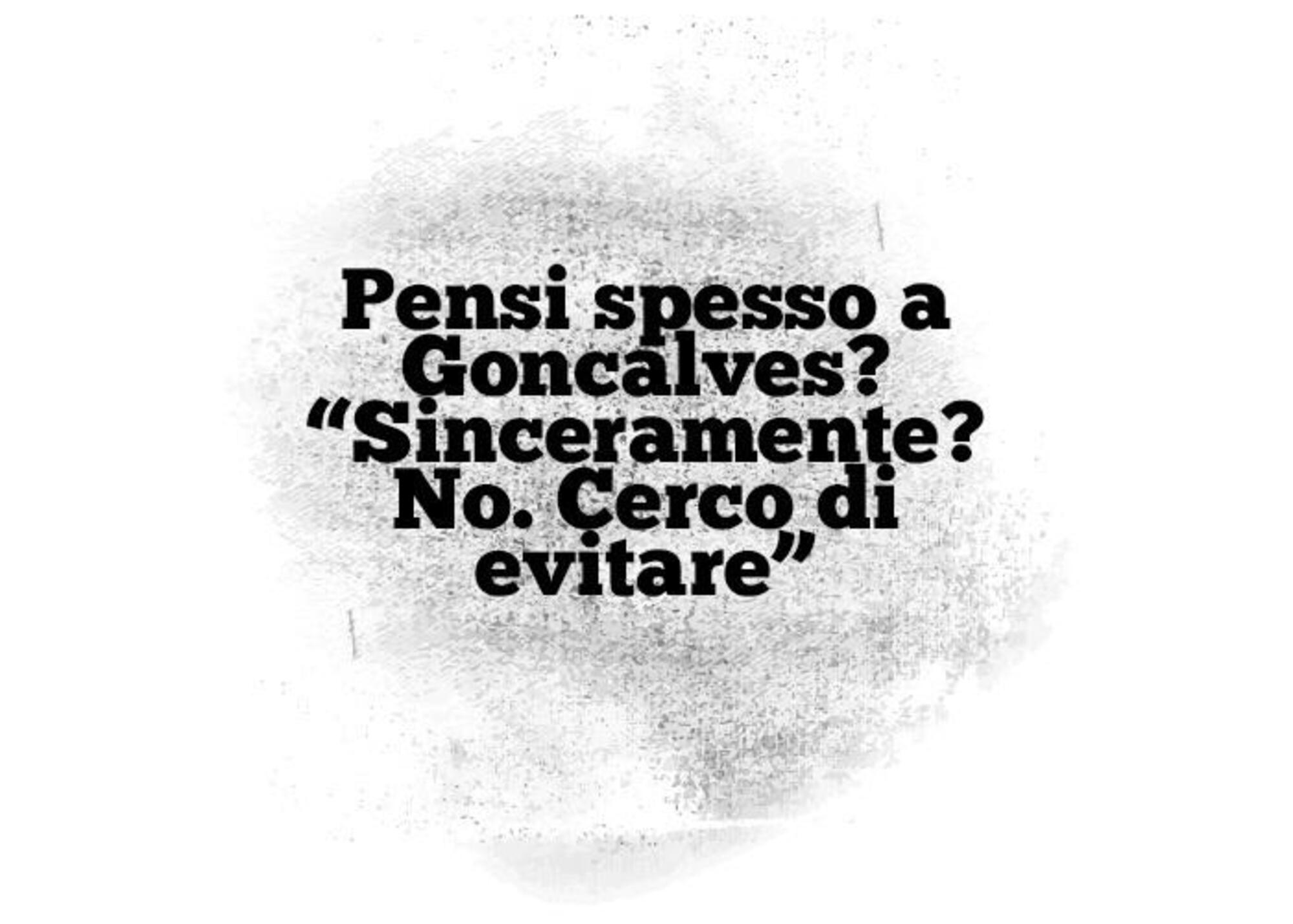
Non ci credo.
“Sì sì, adesso è un po' che non la faccio. Forse è stata anche la mia fortuna questa cosa qua: la mia stazza è la mia corazza, mi protegge; l’agilità invece mi serve nei momenti più pericolosi”.
Brescia, Bergamo uguale emergenza Covid. Come l’hai vissuta?
“Vedere un paese come Lumezzane, fermo e in silenzio, mi ha fatto effetto. L’unico rumore era quello delle ambulanze”.
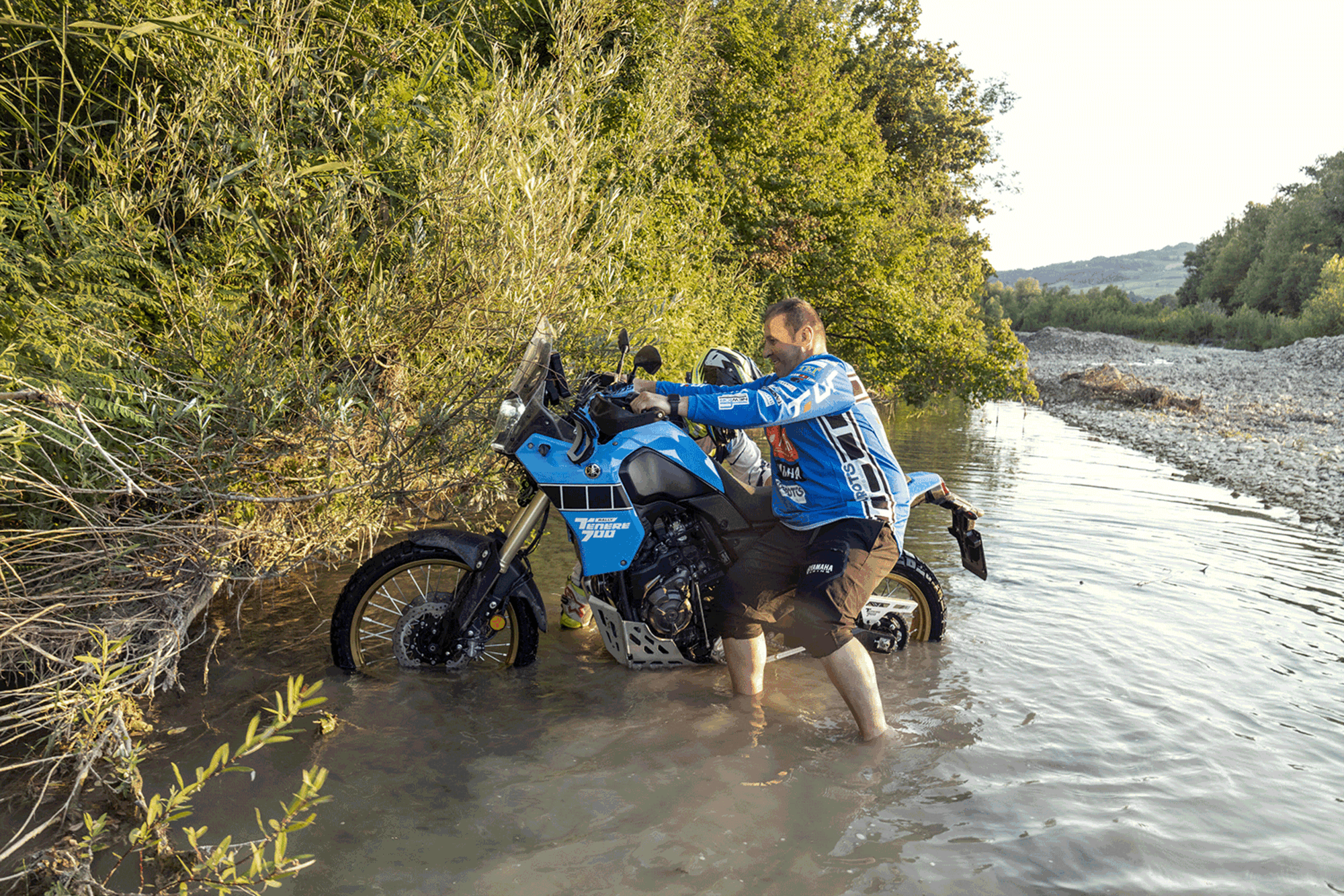
Tu hai avuto qualche parente che si è ammalato?
(mi guarda, alza l’indice destro) “Io. Ma non me ne sono neanche accorto. L’ho scoperto dal test sierologico, un mese fa. E ho capito anche quando. Tornato dall’Africa Eco Race a gennaio sono andato in vacanza a Sharm El Sheik. Rientrato in Italia non sono stato bene, ho avuto due giorni di 37.5 e non sentivo più i sapori. Qualche giorno e mi è passato tutto. Nessuno della mia famiglia l’ha preso, per fortuna”.
Hai il debole per la buona cucina.
“Mi alleno tutti giorni, due ore al giorno: bici, palestra, circuiti tipo crossfit. Non posso privarmi anche del mangiare, è il piacere della vita”.
Bevanda alcolica preferita?
“Io sono più da limoncelli”.
C’è chi racconta di sbronze epocali all’Eicma?
“Con Debora di Forma Boots, i miei stivali. Passo a trovarla prima che chiuda e facciamo l’aperitivo. Il problema è che non la finiamo più, tra spritz, spumantini, salami, siamo uno peggio dell’altro. Un’altra sbronza l’ho presa con il giornalista vostro, di Moto.it, Andrea Perfetti, e Matteo Viviani de Le Iene la sera della presentazione del nuovo Ténéré. Abbiamo finito una bottiglia di Jegermeister. Era il compleanno di mia moglie, l’ho chiamata per gli auguri e lei mi dice: guarda che me la lego al dito che tu sei in giro anche il giorno del mio compleanno. Allora con Andrea e Matteo le abbiamo cantato una canzone di auguri. Lei si è calmata e noi siamo andati a far serata”.

Dolci?
“Questa è la mia pecca. Il tiramisù mi fa impazzire proprio”.
Moto elettriche?
“Evitiamo… è meglio”.
Segui la MotoGP?
“Mmm.. non mi dice nulla”.
Però molti piloti ti ammirano.
“Il Dovi lo sento, Vale lo sento quando faccio la serata per il reparto di oncologia pediatrica perché manda il presidente del fan club a portare le magliette. Sa che se gli rompo le scatole è per qualcosa di buono. Petrucci è un endurista e quando lo incontro mi chiede sempre: ma quando mi porti in Africa? Adesso ti faccio vedere una foto, vediamo se lo riconosci". Prende il cellulare, cerca nell’archivio e clicca su un’immagine: lui a colloquio con un altro pilota e dietro di loro, un bambino. "Guarda chi è questo bambino, lo riconosci?”.

Nooooo Marc Marquez…
“Sì, con la maglia dei tifosi, guarda come mi guarda! Ci siamo rivisti a Valencia nel 2015 e abbiamo ricordato questa foto”.
Ma tu ci parli con la moto?
“No. La moto è la moto. È un mezzo che ti dà tante soddisfazioni ma non deve essere trattata come una persona. Però la gente ha bisogno delle moto, è una passione che non morirà mai. E soprattutto la gente ha bisogno dell’avventura, anche solo di sognarla. Ecco perché la Ténéré andrà bene, perché ti fa sentire nella Dakar anche se sei su una strada bianca”.
Qual è la cosa più bella che ti è mai capitata nella vita?
“I figli. Non c’è vittoria che tenga”.

Motociclisticamente?
“L’arrivo della prima Dakar. Non pensavo che fosse veramente così dura. Io ero abituato a fare gare di enduro, difficili ma dalla durata ridotta. Anche la Sei giorni era dura ma partivi alle 8 e alle 4 avevi finito. Alla Dakar, in alcune tappe, partivamo alle 4 di mattina e dopo aver fatto 800/900 chilometri mi dicevo: ma chi me l’ha fatto fare di soffrire così”.
La rifaresti?
“Adesso no… Ho visto piloti arrivare poco prima dell’alba alla fine di una tappa, perché una delle regole è che devi arrivare prima del tuo orario di partenza, poi fare colazione, timbrare, prendere la tabella e ripartire subito, e che poi magari, dopo 50km, si fermavano sotto a una pianta per dormire un po’. È durissima. Però, dopo un mese che sei tornato a casa, io sogno di essere lì. La Dakar è così: quando la stai facendo sogni di arrivare al traguardo, quando sei in Italia sogni di rifare la gara”.
Il tuo motto?
“Nell’ambiente dell’enduro mi chiamano zio, e quando devo soffrire per arrivare a un risultato mi ripeto: lo zio è ancora duro da piegare”.
Rimpianti?
“Niente. Potevo vincere di più nell’enduro ma ci ho sempre messo il 120%. Per riuscire a competere con i primi dovevo tirare fuori qualcosa dal cilindro, mettevo il pelo via”.
E quando sarai vecchio?
“Avrò tante cose da raccontare”.