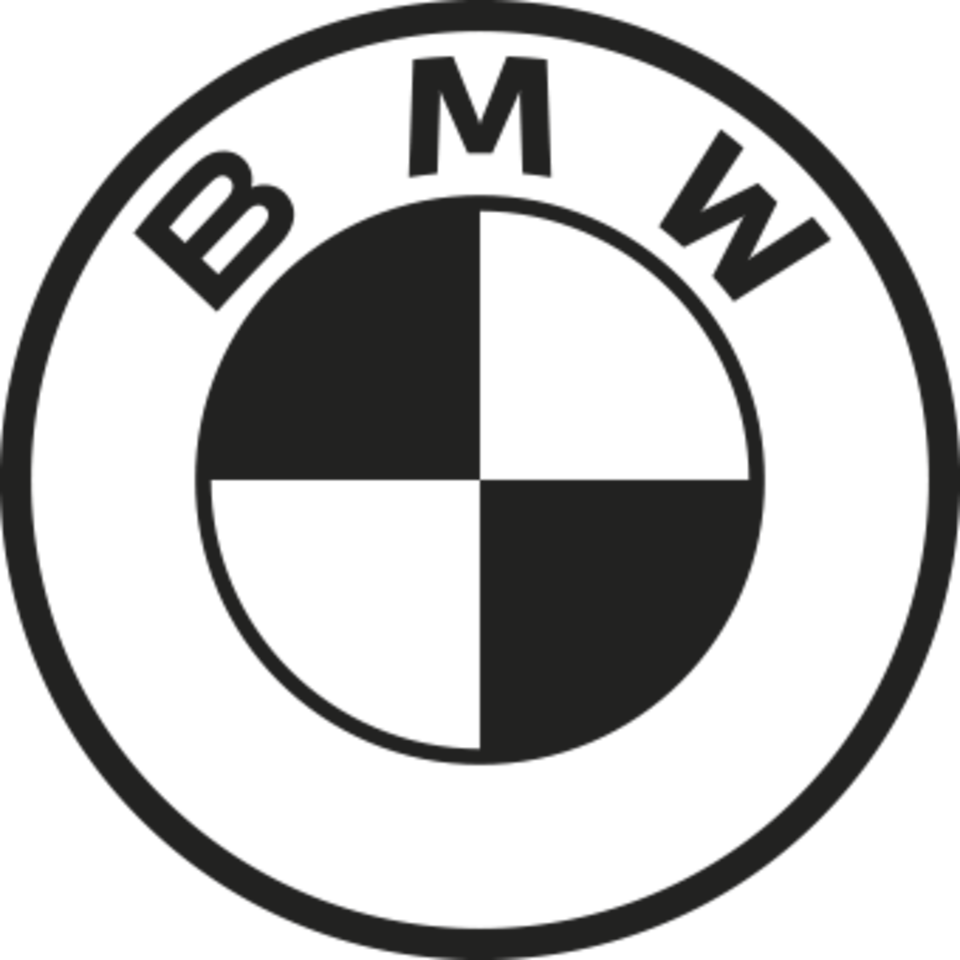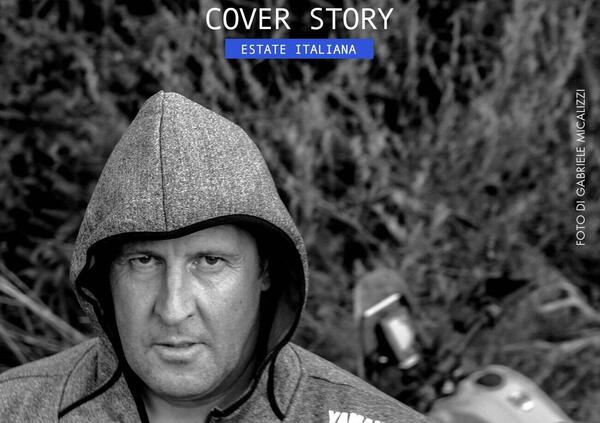L’inizio è una scena. L’azienda è vuota. Sono le 5 del mattino. Un ragazzo di 18 anni e sua madre fanno le pulizie, il ragazzo tira fuori dalla zaino un copione e utilizza la fotocopiatrice dell’ufficio per stampare le copie da distribuire a tutta la sua compagnia teatrale. La macchina restituisce i fogli, il ragazzo li prende, li compatta, li rimette nello zaino. E poi ricomincia ad aiutare la madre. Stacco. Quel ragazzo, anni e anni dopo, è seduto accanto a me con una busta in mano che contiene il suo pranzo fatto di finocchi e insalata («scusa, ma sono in un regime alimentare ferreo»). Siamo nel bar del Novotel Eur di Roma, la sua Roma, la Roma che lo ha reso noto con il ruolo de Il Freddo in Romanzo Criminale - La serie. Vinicio Marchioni. Insieme a noi c’è Ernesto D’Argenio, di una generazioni diversa rispetto a Vinicio, ma anche lui attore, chiamato per andare più in profondità a uno degli argomenti dell’intervista, quello relativo alla loro professione che in questi tempi bastardi fa fatica a essere legittimata come tale. Marchioni in questi giorni sta girando la serie su Alfredino, il bambino che 40 anni fa cadde dentro un pozzo vicino a Frascati e morì poco dopo. È uno dei vigili del fuoco che provò a salvarlo, andrà in onda nella primavera del 2021. «È un caso tremendo, il primo vissuto in diretta tv».


E tu che bambino sei stato?
«Sono cresciuto in un quartiere periferico, una vecchia borgata di Roma costruita negli anni 50-60 che prima si chiamava Montesecco e adesso è Fidene. Mio nonno, il padre di mio padre, si fermò lì per costruire una casa. Ma nel terreno trovò una vena d'acqua, che si rivendette al mercato nero e con i soldi guadagnati, al posto di un appartamento solo, ne costruì due. La nostra era una famiglia di contadini, vivevamo in una fattoria, in aperta campagna, ma dopo la morte di mio padre è crollato tutto».
Ahia.
«Sì, per un male. A 15 anni sono rimasto con mio fratello e con mia madre, e ho cominciato a fare tutti i mestieri del mondo, mia mamma era un operaia, faceva le pulizie e io spesso la accompagnavo».
So che può sembra brutto, ma ti voglio chiedere una cosa: cosa ti ha insegnato questo evento?
«Per 10 anni non ho ricordato assolutamente nulla, come se avessi delle zone di vuoto. Poi ho pensato che, crescendo, non ho avuto bisogno di “ucciderlo”, metaforicamente parlando, per esempio con lui non ho mai avuto gli scontri adolescenziali, e ho sempre potuto apprezzare tutti gli sforzi di mia madre. È stata brava, mi ha dato fiducia, perché quando stai a Fidene e ritorni tutte le sere alle 3 de mattina puoi fa’ qualsiasi cosa, te po’ succede qualsiasi cosa. E io, invece, a causa della mancanza di mio padre sono sempre stato responsabile».
Quanto invece ti è mancato?
«Mio padre non mi ha potuto insegnare nulla sul rapporto con le donne visto dalla parte maschile, ed è anche per questo forse che sono un po’ anomalo rispetto alla media, non ho mai avuto il calcetto o altri hobby maschili, sicuramente essere cresciuto con mamma e nonne, con un punto di vista femminile sul mondo, mi ha influenzato, e sono molto orgoglioso dell’uomo che sono. Oggi sono consapevole che ai miei bambini posso far capire che anche io posso piangere ed essere debole, posso non sapere cosa fare, non so se è giusto, però cerco di fargli vedere tutto ciò che non ho fatto in tempo a vedere del mio, di padre. Ma questo, come quasi tutto, lo devo al teatro, che mi ha salvato la vita».
Spiega meglio.
«La formazione classica, dove studi tutti i miti greci che hanno a che fare con le figure di padre e figlio, mi hanno chiarito tante cose di quello che mi era successo, mi hanno dato l’opportunità di rimettere insieme il puzzle che sono io. Al teatro rimarrò fedele per sempre perché mi ha veramente aperto la testa, mi ha fatto entrare dentro cose di cui non sapevo molto, ha messo in ordine tutto, ché fino ai 23 anni la mia vita era un casino».
Come ci sei arrivato al teatro?
«Negli ultimi anni delle superiori il mio prof di italiano, quando leggeva la Divina Commedia, si metteva a piangere, e mi arrivava qualcosa che non capivo. Lui era un illuminato, ogni tanto 4 o 5 di noi li invitata la sera da lui per fare le cene con i suoi figli e la moglie e poi giocavamo a Risiko, e anche se avevamo 17 anni, se ti volevi fumare una sigaretta o berti un bicchierino di grappa, con lui lo potevi fare. Mi ha regalato 1984 di Orwell, mi ha fatto conoscere Bukowski, De André, il cantautorato degli anni 60».
Una magia…
«Io credo che la nostra natura, quello che siamo, le nostre cellule, le nostre predisposizioni caratteriali esistano realmente da quando nasciamo, dal primo respiro, poi ci sono padre, madre, l’educazione, ma quello che sei tu, unico e irripetibile nel mondo, sta nel dna, nelle cellule. E poi c’è il culo, fa sì che tra persone ci si scelga per un periodo della vita, per aiutarsi a crescere. Non so se i miei figli avranno la fortuna di incontrare un prof o una prof che gli apre una porticina e li fa restare stupiti dalla meraviglia, ma questo attiene, come hai detto tu, anche alla magia».
E dopo le superiori?
«Mi ero iscritto all'università, poi ho provato a entrare come regista al centro sperimentale ma non mi hanno preso, perciò mi sono iscritto alla facoltà di Lettere, indirizzo spettacolo, qui ho studiato cinema, teatro e si è aperto un mondo».
Cosa ricordi di quegli anni?
«Lo studio, l’infiammazione. Ero acceso, stavo 10 ore al giorno a scuola e la sera si facevano le feste, si stava sempre insieme, parlavamo continuamente di ciò che facevamo, e tutto questo mi aiutava a resistere ai professori che per tutto il primo anno mi hanno ripetuto: lascia perdere, fai altro».
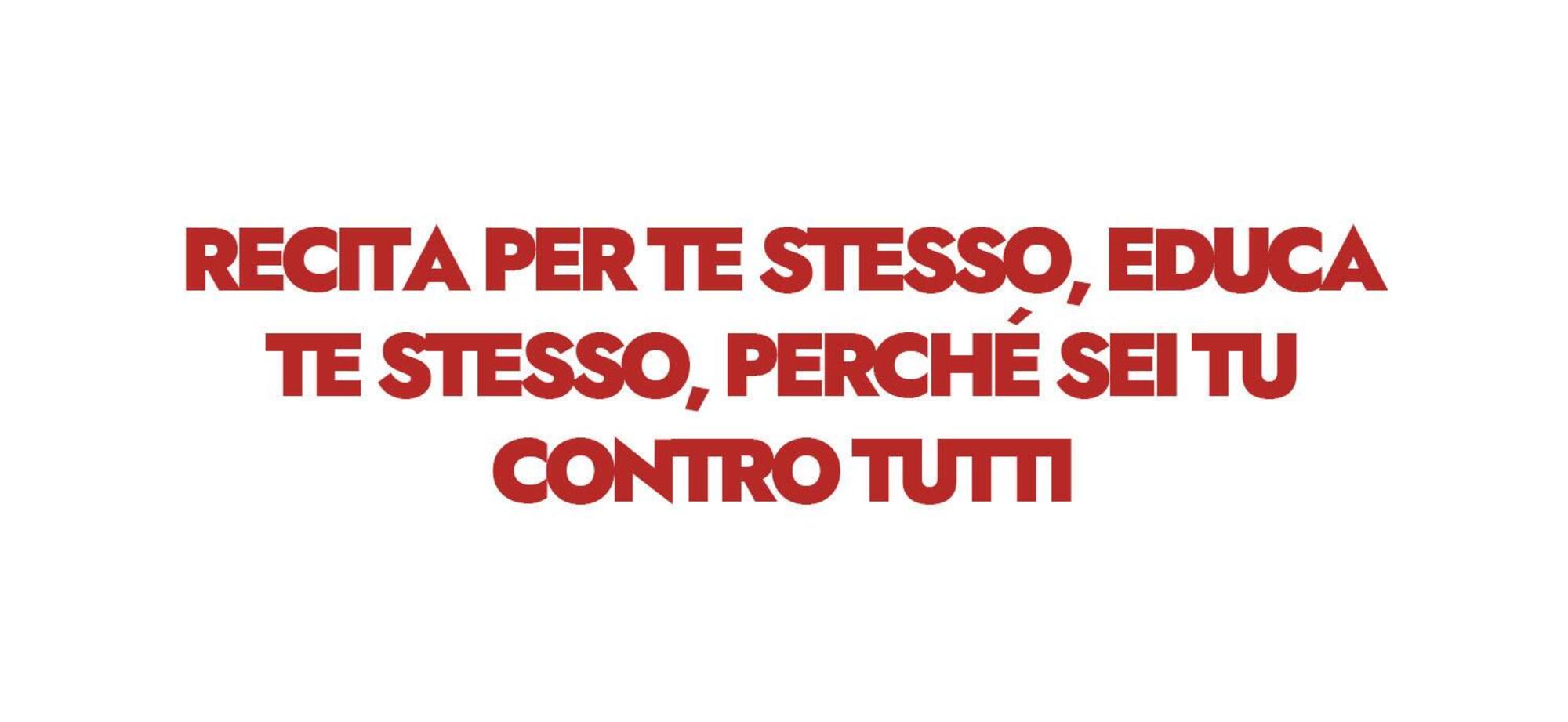
Interviene Ernesto D’Argenio: ti volevo chiedere, come ci si sente ad essere uno dei pochi che ce l’ha fatta rispetto al tuo gruppo di studi, sei un po’ il superstite di un’isola dove gli altri sarebbero voluti approdare ma non ci sono arrivati.
«Non lo so, non me la sono mai posta sta domanda, perché alla fine conta trovare un posto dentro alla propria anima, e molti di quelli che studiavano con me magari hanno capito che non volevano fare veramente gli attori. Io sono un uomo realizzato di 45 anni che vive della sua passione, e questa cosa cerco di guadagnarmela ogni giorno, perché nulla è scontato, nulla. Negli anni ho imparato a coltivare il mestiere dentro di me e non me dentro il mestiere, questa è una cosa importantissima. Bisogna sempre porsi la domanda: ami te stesso nell’arte o ami l’arte in te stesso?».
Ti sei mai chiesto: e se non mi avessero scelto per Romanzo Criminale come sarebbe andata?
«Avrei fatto teatro, come già facevo e come sto continuando a fare, poi io dico anche che se fra 5 anni non mi chiama più nessuno non è che mi suicido, l’attore è un mestiere che va fatto se hai la fortuna di farlo, se ti fa crescere come persona, se ti trasmette degli stimoli, perché può diventare il mestiere più orribile del mondo. Ti dico un’esperienza mia».
Vai.
«Il weekend prendevo il motorino e andavo a fare il cameriere dalle 7 di mattina alle 3 di notte per guadagnarmi 100 euro al giorno, il lunedì mattina non camminavo, avevo i piedi che erano sfondati, ma andavo a scuola lo stesso. E il sabato, quando osservavo la gente dentro le macchine in coda per il fine settimana, io mi sentivo che stavo meglio di loro perché ero libero e stavo provando a fare qualcosa che mi facesse stare bene, anche se dovevo sacrificare il mio tempo libero. D’altronde tu non puoi pretendere di fare Amleto o di arrivare a vincere un premio importante e non mettere in conto che questa roba abbia una contropartita. Il teatro nel quarto secolo si faceva in gruppo, tutti indossavano una maschera, poi qualcuno ha detto: “Ma vogliamo fare che dal gruppo si stacca uno e parla a nome di tutti?”. Così è nato il protagonista, e se pretendi di aspirare a questo ruolo devi lavorare di più e hai più responsabilità degli altri».
Ernesto D’Argenio: tu una volta sei stato mio insegnante in un laboratorio e mi hai dato questo consiglio: recita per te stesso. Vale anche e ancora per te? C’è una cosa che tu fai ancora per te stesso?
«Il nostro un mestiere che si fa in solitudine. Recitare per se stessi e in se stessi significa che se ci chiamano per lo stesso ruolo, tra di noi ci sarà sempre una differenza di interpretazione, e non c’entra chi è più o meno bravo, c’entra come risuona in te la battuta, come risuona in me, come la vivi tu e come la vivo io, in base ai nostri vissuti, alle nostre esperienze. Ancora oggi dico: recita per te stesso, esercitati per te stesso, educa te stesso, ché sei tu contro tutti. Perché quando fai il primo piano principale di un film e hai 4 milioni di euro della produzione sulle spalle mentre un tizio batte un ciak, e lui non sa niente di te e tu niente di lui, e magari sono le 7:30 di sera e lui pensa solo ad andarsene, in quel momento devi essere consapevole che il ruolo del protagonista sta sulle tue spalle e ti stai giocando anche il suo stipendio. Ed è qui che la solitudine di questo mestiere la senti tutta, ed è difficilmente spiegabile a chi non è dentro le dinamiche dell’attore».
In te, nei tuoi ruoli, questa solitudine si vive, si vede.
«Sai che c’è? Che non c’è un segreto, per la recitazione devi lasciare dentro al tuo camerino quello che non serve di te, quello che un attore deve fare è studiare il personaggio e vedere ciò che quel personaggio ha di sé e ciò che l’attore ha di quel personaggio, e poi deve togliere quello che non serve e quello che elimina non devo portarlo né sul palco né sul set».

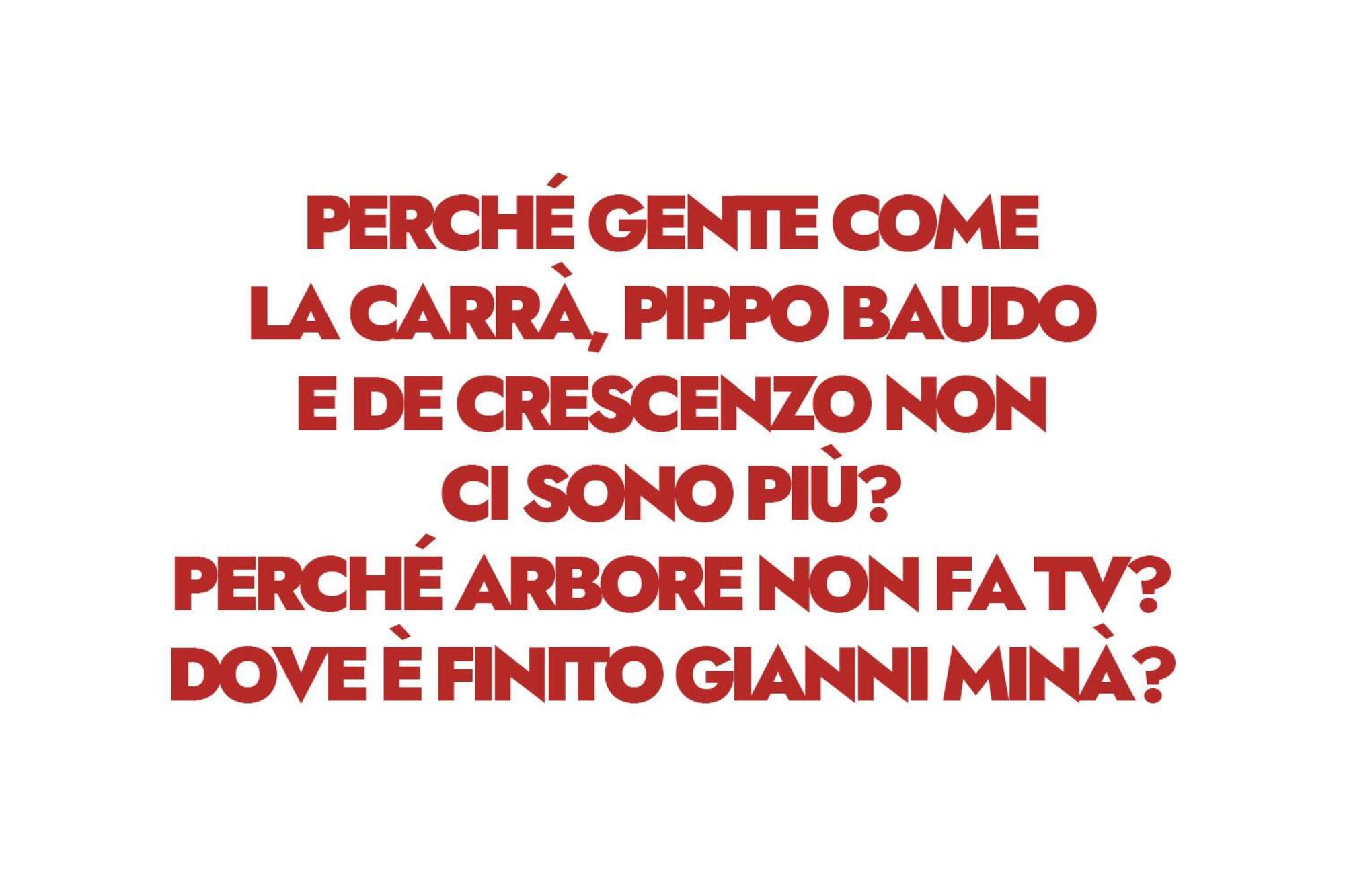

Ernesto D’Argenio: una domanda mi viene naturale, perché noi non siamo in grado di produrre dei prodotti come The Crown? O, per esempio, La regina degli scacchi?
«Primo, i soldi, per fare quella roba lì ce ne vogliono un sacco, poi serve un sistema produttivo, che in Italia tendiamo a direzionare verso prodotti dal tema sicuro, vedi Suburra o Gomorra, e poi c’è un altro problema, fondamentale, il livello di scrittura. Noi non abbiamo una scuola di sceneggiatori. Oggi non scriviamo più pensando ai protagonisti. La regina degli scacchi è una storia semplice: una ragazza sfigata, abbandonata in un orfanotrofio, con problemi di relazioni esterne, che però cresce e rompe il culo a tutti. Finito, facile. Però è scritta da dio. I primi due episodi li avete visti? Sembra un thriller psicologico, le scene in cui gioca a scacchi in una cantina pensi che sia un horror, poi cambia la fotografia, cambia lei, diventa attraente, la colonna sonora è incredibile».
Ernesto D’Argenio: se la proponevi qui in Italia ti dicevano, “ma che, gli scacchi? ma chi se ne frega degli scacchi!”. Invece è la serie più vista di Netflix ovunque.
«Oppure prendi il film Quasi amici. Prova ad andare a proporre la storia di un paraplegico portato in giro da un nero che insieme scherzano su Hitler. Qui ti guarderebbero come se fossi un alieno. Il problema è che nessuno si chiede il come si fanno le cose, non è mai il cosa, cazzo, è il come. È già stato fatto tutto, non c’è niente da inventare. Possiamo raccontarlo meglio, questo è il punto. Invece le storie che scriviamo in Italia sono sempre in relazione al che cosa va e alla tendenza del momento. Adesso va il crime? E via col crime. Adesso va il family? E via col family. Non pensiamo più a creare un personaggio e la colpa è del sistema. Perché se tu sceneggiatore per 20 anni hai provato a proporre una roba folle e diversi produttori te l’hanno bocciata, ognuno con una scusa diversa, il tuo immaginario giocoforza scende, va al ribasso, ti autocensuri. Io ho avuto la fortuna di parlare con gli sceneggiatori degli anni Sessanta e mi raccontavano che loro scrivevano i copioni sopra i comò durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale in case abitate da sette persone e già allora dicevano che il cinema era finito per colpa della tv, della radio, della guerra e poi però si so’ magnati tutti».
Come è stato possibile?
«Hanno fatto squadra. Sceneggiatori, registi, attori. Ma è durato poco. Non possiamo dimenticarci di essere figli del Rinascimento, quando c’erano i Gonzaga e i Medici ogni famiglia aveva la propria compagnia dell’arte e tendeva a giocare per sé e a competere con gli altri per dimostrare di essere il più figo. Dal 500 a oggi questa mentalità non è cambiata, ognuno appartiene a una famiglia, di qualsiasi genere, produttiva, anagrafica, di provenienza, l’unica cosa che è cambiata è chi ci governa e chi produce, per il quale non sei più figo se produci più bellezza ma se fai più soldi. E negli anni la qualità e l’economia si sono separati: se fai cose che funzionano economicamente devono essere brutte».
Quando si è staccata la qualità dall’economia?
«È stato un processo. Se tu oggi, 2020, vai nel posto più sperduto del mondo e parli de La dolce vita, la gente ride, perché quel film ha comunicato al mondo stile, sogno, ricchezza e l’Italia, dopo 62 anni, è riconosciuta per quel film. La potenza comunicativa, politica, sociale di un film ce la siamo dimenticata».
Alberto Sordi.
«Ha trasformato l’Italia in quello che descriveva lui, era talmente inarrivabile, talmente italiano che lui riusciva ad incarnare il peggio del peggio italico e ha fatto credere che noi siamo cosi. Ma anche Totò».

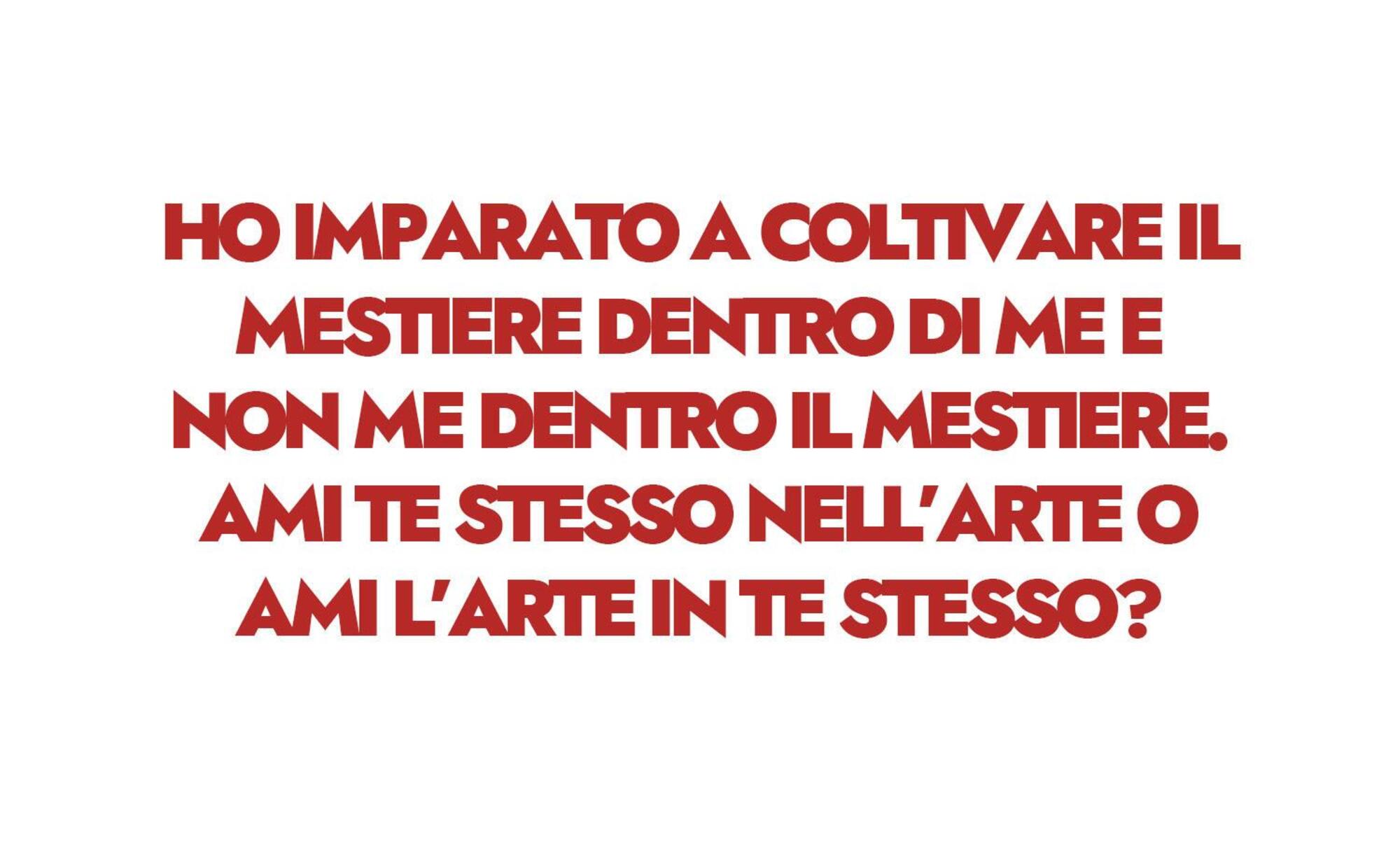
Una salvezza però c’è sempre, e voi di Romanzo criminale - La serie ne siete stati una prova: quattro sconosciuti che fanno un prodotto di qualità.
«Per fortuna c’è sempre chi fa di tutto per cambiare il meccanismo. Pensa a Matteo Rovere e alla serie Romulus, una serie tv in proto latino. Ha speso una fracca di soldi e ha provato a fare una cosa diversa. Ci sono alcuni progetti che stanno alzando tantissimo la qualità, ma è un discorso di sistema, ripeto. Io faccio sempre due esempi. Il primo: nell’ultimo anno di Obama presidente, la consegna del premio al miglior attore degli Oscar l’ha fatta Michelle Obama in collegamento dalla Casa Bianca, e questo significa che c’è una nazione dietro al sistema cinema».
E il secondo?
«L’altra sera, in prima serata sulla BBC, di sabato alle 21, c’era una sfilza di attori, quello più scarso avrà avuto 3 candidature all’Oscar, entravano in scena uno alla volta per dire soltanto To be or not to be: William Shakespeare, teatro, cinema e televisione tutto insieme. Questo è fare cultura, portare avanti le tradizioni, innovare ed educare».
La mia domanda è: chi in Italia avrebbe l'autorevolezza di chiamare te e altri attori per farvi fare una roba del genere sulla Rai il sabato sera?
«È per questo che ti dico che ci vuole una rivoluzione di chi governa, di chi decide che la tradizione culturale italiana può essere sia spettacolo sia educazione. Eduardo De Filippo, l’attore italiano più glorificato al mondo, su Rai 1 si metteva davanti a una lavagna e spiegava il plot di quello che il pubblico avrebbe visto. Ai tempi eravamo un popolo di analfabeti e in questo modo cercavamo di innalzare il livello culturale. Ma ce lo siamo dimenticati che siamo tornati a essere uno dei popoli più ignoranti d’Europa?».
Permettimi la domanda: se fai questi discorsi come fai a votare? O meglio, cosa voti?
«Mi tappo il naso e voto, voto il meno peggio, voto per ideali o il politico che mi dà più affidabilità al di là degli slogan, però è tosta».
La soluzione è l’integralismo culturale?
«Perché gente come la Carrà, Pippo Baudo e Luciano De Crescenzo non ci sono più? Perché gente come Arbore non fa tv? Dove è finito Gianni Minà? Basterebbe poco. Basterebbe fare studiare i giovani con Minà, con Arbore, con i vecchi direttori della Rai. Questo Paese i vecchi li accudisce, li sopporta, gli dà la pensione, ma non li usa e io se a 25 anni avessi avuto la possibilità di parlare con Gassman, Mastroianni, con Manfredi e Visconti, forse qualcosa in più saprei».
La responsabilità è anche degli attori, che si tengono lontani da molti programmi televisivi?
«Io ci andrei in un programma televisivo se solo sapessi che non fa intrattenimento per narcotizzati. Ecco perché molta gente di cinema non si mette in mostra, perché si protegge. In Italia ancora oggi mi chiedono: Vinicio Marchioni, nel 2020 cosa preferisci fare, teatro o cinema? Ma vallo a chiedere ad Al Pacino cosa vuole fare, vedi che ti risponde: ma che domanda è. Negli altri Paesi non c’è la differenza tra cinema e teatro. In America Michael Fassbender fa i film della Marvel, fa la commedia strappalacrime, fa l’opera da premio Oscar e poi tutti dicono che è un attore straordinario, qui se tu fai una cosa che esce dal seminato non ti calcola nessuno, ma non a livello di pubblico, ma produttori, distributori, il sistema cinema stesso. Abbiamo perso completamente il concetto che l’attore è schizofrenico per natura, perché io non posso fare una cosa che fa soldi, una commediola, che magari poi mi permette di stare 6 mesi a studiare per realizzare un film considerato più difficile sul mercato?».
Pierfrancesco Favino è diventato noto a tutti dopo Sanremo…
«Stiamo parlando del più grande attore che abbiamo in Italia. Lui, Toni Servillo, Tommaso Ragno, Valerio Mastandrea, Elio Germano, gente che fa questo lavoro da 30 anni e se tu fai una cosa da 30 anni vuol dire che sei bravo, ti può andare bene una volta, la seconda, ma se continui sei bravo, punto».
Ernesto D’Argenio: spesso la gente ci vede solo come delle star…
«Però per ogni attore che sta sulla copertina di un giornale ce ne sono mille che sono alla fame, che non lavorano da febbraio scorso e che hanno una famiglia da mandare avanti e non esistono dal punto di vista professionale. Per il ministero del nostro lavoro, la figura professionale dell’attore non esiste, per nessuna legislazione e per nessuna legge, siamo equiparati a spettacolo, arte varia, alle sale bingo. Per il pubblico noi siamo quelli con le ville, con la piscina, che non fanno niente, ma costruire un ruolo è un lavoro enorme, ogni personaggio lo devi costruire dentro di te come mio nonno faceva con le case, capire che musica avrebbe ascoltato, che scelte avrebbe fatto, che psicologia avrebbe avuto. Prima hai citato Favino, per Hammamet hai presente quante ore di trucco al giorno ha dovuto fare? Quanta roba ha dovuto vedere e quanto ne ha dovuta studiare? Ma questa cosa dobbiamo spiegarla meglio noi attori, perché teatro e cinema andrebbero insegnati nella scuola dell’obbligo: mettersi nei panni dell’altro è il più grande esercizio di democrazia al mondo, se tu insegni la storia del teatro, insegni anche quella dell’uomo, perché il teatro è nato quando è nato l’uomo, la storia del teatro è sopravvissuta all’Olocausto, il cinema ha partecipato alla costruzione di una nazione, inconsapevolmente o no».
Tu sui tuoi social lo fai.
«Io ho l’ossessione di risolvere un problema ai nuovi talenti, perché se un ragazzo è il nuovo Kubrick ed è nato nella provincia di Pavia, dove va, a chi bussa? Questa cosa mi fa diventare pazzo. Così ho deciso di aprire una casa di produzione con l’obiettivo di far debuttare gli attori sconosciuti, di usare il mio nome per tirare fuori opere coraggiose, anche piccole, ma sento la mancanza delle origini, il tempo dello studio, il tempo di farsi delle domande, il tempo di sbagliare, perché adesso se tu come regista sbagli un film hai finito di lavorare. Ma dai, non va bene così».
Una scelta rischiosa.
«Eh ma se suicidio professionale deve essere, almeno me suicido contento».
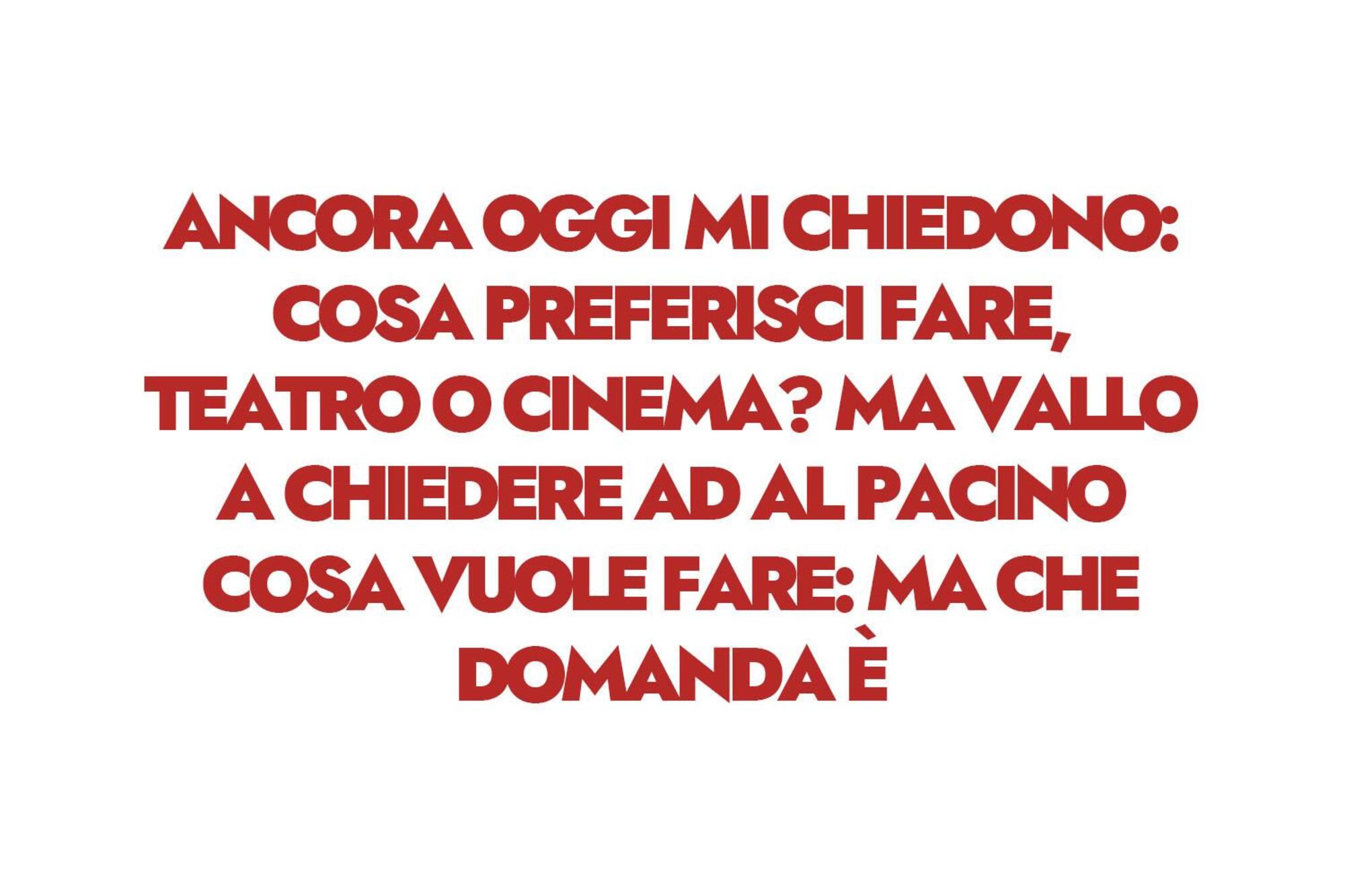

Ultime due domande. La prima, in un’Italia dove le opinioni sono sempre più omologate e qualsiasi voce fuori dal coro è vista malissima, come coltivare il coraggio?
«Coltivando l’individualismo. Nel senso che bisogna lavorare su se stessi e non avere paura di esprimere ciò che solo tu pensi. Il coraggio è fottersene dei meccanismi comunemente intesi come adeguati e accettati».
L’ultima, tra tutte le persone che hai citato e anche quelle che non ha citato chi ti manca di più?
«Mi manca San Francesco, mi manca l’umanesimo, mi manca la rivoluzione che ha fatto quell’uomo nel 1200: era ricco, stava bene, era nel sistema di allora e ha detto: “Signori, mi fa schifo…”. Lascia stare Dio, il Papa, quel contesto. Mantieni il coraggio, appunto. Mi manca Carmelo Bene, non come irripetibile genio di questa professione, ma come spirito. Mi manca, adesso, Diego Armando Maradona. Mi mancano quelli che se ne fregano, anche di essere coerenti, e che davanti a chi gli dice “devi fare così”, si girano dall’altra parte e rispondono: “No, io lo faccio in un altro modo”. Io continuo a chiedermi sempre due cose».
Quali?
«Voglio ancora fare l’attore? Sì. Ok, ma che attore vuoi essere, una figurina o vuoi fare qualcosa che resti? La rivoluzione più importante è quella dentro di noi. Avere il coraggio di essere ciò che vogliamo essere».
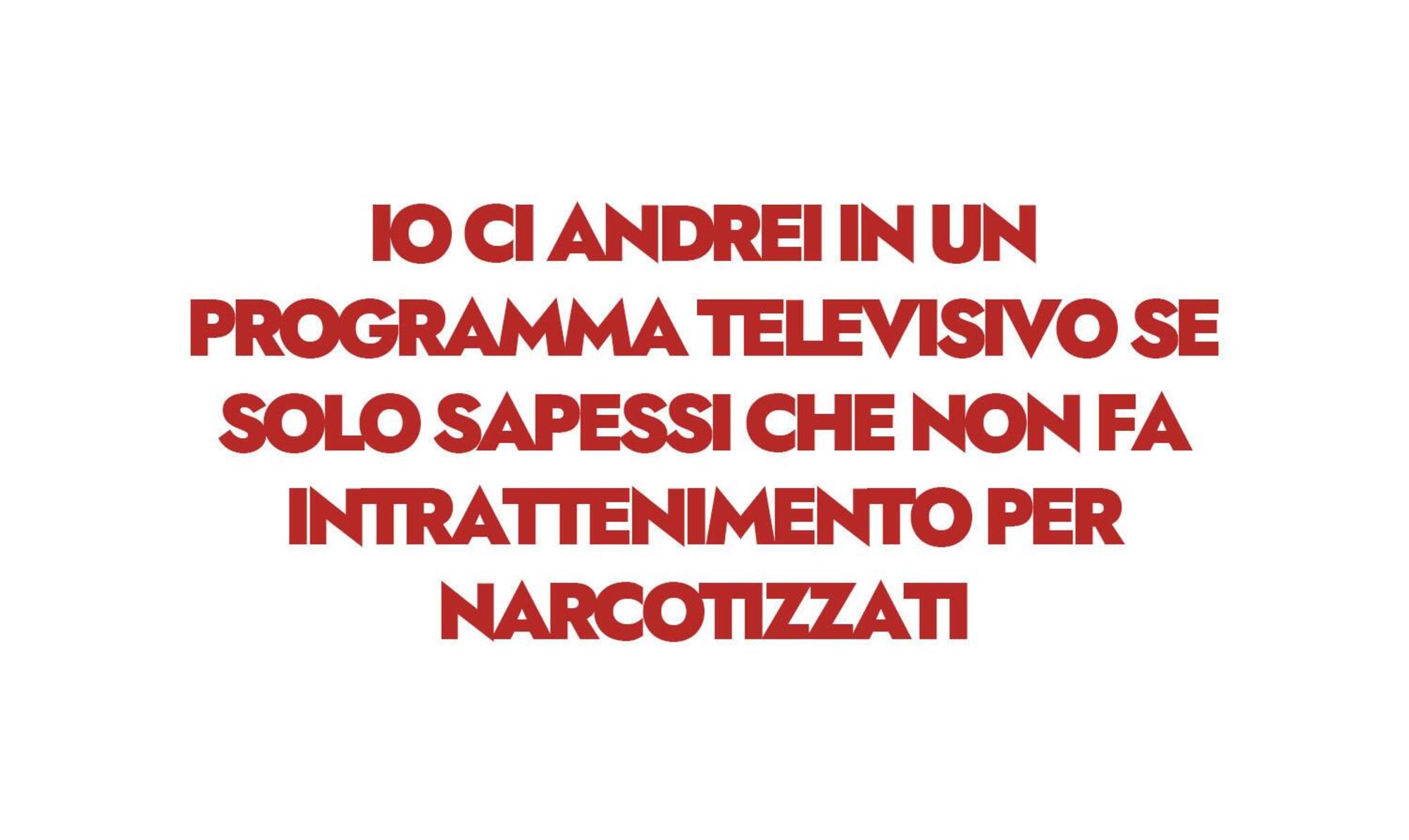

Credits
Special guest intervista: Ernesto D'Argenio / Styling: Stefania Sciortino / Grooming: Maria Esposito per Simone Belli Agency
La produzione ringrazia Novohotel Roma Eur