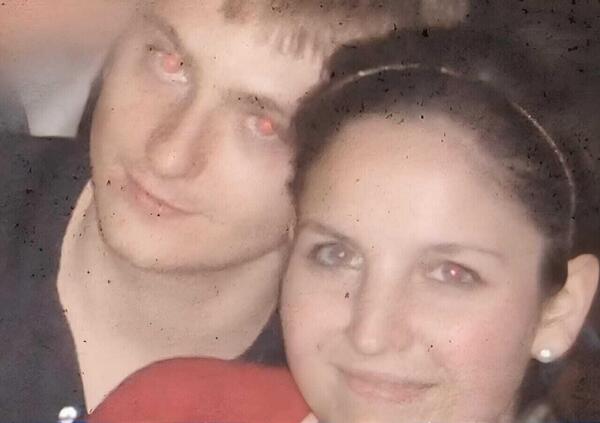Un uomo, Vincenzo Lanni, accoltella una manager di Finlombarda, Anna Laura Valsecchi, a Milano, in piazza Gae Aulenti, e dice di averlo fatto per colpire il “potere economico”. Nel film Bugonia di Lanthimos, due complottisti rapiscono una CEO — Emma Stone, con lo sguardo di chi ha già capito tutto — convinti che sia un’aliena intenzionata a distruggere la Terra. La rinchiudono, la interrogano, le infliggono la violenza della loro fede paranoica. Non lo fanno per soldi o per rancore: lo fanno “per il bene del pianeta”. Esattamente come l’uomo che ha accoltellato “il potere”, scegliendo a caso una donna che camminava in una piazza simbolica. Il confine tra Bugonia e la cronaca sfuma in questi tempi distopici.
Viviamo in un tempo in cui la distopia è diventata la forma più onesta di realismo. Se il verismo e il neorealismo sono state correnti letterarie e cinematografiche delle quali, giustamente, noi italiani andiamo fieri, adesso il “canone” per raccontare il mondo diventa la fantascienza, la pre-apocalisse, la distopia. Non è più il “cinema” a copiare la realtà, ma la realtà a copiare un “genere”. La celebre “imitatio” ha cambiato verso.
Il realismo presupponeva ancora un ordine del mondo, un legame fra causa ed effetto. Ma oggi il mondo è un caos di contraddizioni, di notizie-meme, di teorie senza verifica. L’uomo che “colpisce il potere” non è un mostro: è il prodotto coerente di un’epoca che ha sostituito la conoscenza con la sensazione di sapere. Sì, Vincenzo Lanni era “disturbato”, ma il suo “profilo” sembra molto simile a tanti influencer che si muovono nelle “badlands” della frustrazione e del complottismo.

Lanthimos non è più un regista visionario, ma un cronista anticipato. Non l’unico, ci mancherebbe. Ogni distopia è una grande metafora, e le due realtà — quella della finzione, della fiction, e quella della realtà (mai così surreale) — stanno arrivando a coincidere, come quelle piantine in translucido che, nei film di genere, restituiscono la piantina del reale sommerso.
Basta aprire un social per trovare teorie secondo cui l’acqua è controllata dalle multinazionali, i vaccini dagli alieni e il traffico da un algoritmo di Davos.
Il complotto non è più un margine della realtà: è il suo linguaggio ufficiale.
Quando un uomo qualunque si sente investito della missione di “colpire il potere”, la distopia si è già realizzata.
Non è più un genere. Ma quanti “credibilissimi” uomini “del destino” abbiamo visto in questi ultimi decenni? Quanti “profeti” mainstream hanno declamato i loro sermoni dalle televisioni generaliste? Perché l’uomo comune, l’uomo della strada, dovrebbe essere "in sé" e non "fuori di testa" come i potenti della Terra?
Premetto: credo poco alle teorie sociali dei disturbi mentali, e mi convince (e mi conforta, in maniera contorta, lo so) sapere che il delirio dipende dalla chimica dei processi mentali. Detto questo: le forme del delirio che appaiono in superficie, volenti o nolenti, sono sempre “letterarie”, sono sempre “fiction”. Voglio dire: viviamo in un mondo in cui stampare la moneta è un atto svincolato dalle riserve auree; la quantità di moneta circolante è pura fantasia. Come possiamo essere certi che questa “fantasia” economica sia, per dirla con Spinoza, “adeguata” e non un altrettanto delirio? Fosse “adeguata”, il mondo andrebbe un po’ meglio. O mi sbaglio?
Non giustifico nessuno, e l’assassino è un assassino, e come tale va giudicato, infermità, seminfermità o tutto quello che volete. Sto solo dicendo che, oramai, le categorie con le quali “leggere” la realtà sono quelle dell’horror e della fantascienza, dei “mostri” e delle realtà “immaginarie” (immaginarie come la cartamoneta che tenete in mano, ça va sans dire). Lanthimos lo mostra con l’eleganza della metafora; la cronaca italiana lo replica con la brutalità di un coltello. Ma il gesto, l’idea, la frase — “ho colpito il potere economico” — appartengono alla stessa grammatica delirante: quella in cui il “simbolo” sostituisce il reale, e non esiste altro “reale” se non quello simbolico. Che è più o meno la descrizione del delirio schizofrenico paranoide o, per dirla in altra maniera, il mondo in cui viviamo.