Stavo lavorando a un testo che nella mia mente doveva avere il titolo “Codice Heidegger”. L’idea di fondo è che, in questo caos che chiamiamo postmoderno, la domanda delle domande resta sempre quella: perché c’è l’Essere e non il Nulla? O: perché esiste la Materia? Da dove salta fuori? Il Mistero della Materia è ben più, come dire, misterioso del Mistero di Dio.
L’Essere non è una cosa scontata. Lo dovrebbe essere di più il Non Essere. Eppure l’Essere è. Non come concetto astratto, ma come il tavolo sul quale poggia il mio computer e come le mie stesse dita. Chi è autorizzato a rispondere a questa domanda?
Ragionavo su questo quando è arrivata la notizia della morte di Giuseppe Tratteur. Fisico.
Avevo circa ventidue anni e stavo passeggiando per il corso Umberto di Catania con Manlio Sgalambro, il mio maestro di teologia (o di controteologia, come la chiamava lui).
Avevo appena scoperto la Letteratura. Non che non avessi già letto tutto quello che c’era da leggere, ma fino a quegli anni la Letteratura era un passatempo. Non che non avessi capito che dietro Kafka c’era molto di più (per fare un esempio), comprendevo poco perché dovessi perdere tempo dietro alle metafore e alle allegorie, quando potevo direttamente leggere i Saggi. E poi, un sabato sera, in una libreria che chiudeva a mezzanotte, mi capitò tra le mani Luce virtuale di William Gibson. Fu come una liberazione. Quella stessa esplosione di colori e vettori che compongono l’orizzonte metafisico messo lì, sulla pagina.
Volevo davvero passare la vita a pitillare sui codici linguistici canonici dell’università? E quale “codice” avrei dovuto scegliere? La fisica teorica? La matematica? La geometria? La controteologia eretica che praticava Sgalambro? O tuffarmi nel mondo e fare il giocoliere con tutti quei codici insieme, aggiungendo i fumetti, il cinema, i romanzi di genere, la musica, i videogiochi: la cultura pop, in altri termini.
Sgalambro fu lapidario, tendeva sovente a esserlo: “Studi il tedesco e si attenga ai codici”. Di lì a poco Manlio Sgalambro, il mio inflessibile Virgilio che mi insegnò a trattare il concetto di Dio come un ente qualunque buttato sul tavolo di dissezione, iniziò a scrivere canzonette per Franco Battiato. Facendo precedere questa sua 'nuova' attività da un libretto, Contro la musica (edito da una piccola casa editrice di Catania, la De Martinis & Co., e poi ripubblicato da Adelphi all’interno di De Mundo Pessimo, e infine ripubblicato singolarmente da Carbonio), che significava “Contro il mondo”, ma in codice musicale. Siamo sempre stati un po’ Catari.

Anche Sgalambro, via via che la nostra epoca scivolava verso la confusione dei ruoli, andava codificando il suo pensiero, lo andava mascherando. Da un lato l’Accademia restava custode dei linguaggi, rinchiudendoli nei corridoi restaurati come nei conventi medievali; dall’altro la cultura pop poteva affrontare quegli stessi temi, o quello stesso tema (l’Essere, la Materia), ma senza utilizzare i linguaggi, per così dire, canonici. Non è che uno arriva e dice: ho scoperto tutto, ho la soluzione per tutto. Anche se Sgalambro – che meraviglia – lo fece: “Su Dio ho scoperto due o tre cose che gli altri non sanno” e “Non affaticatevi a pensare: ho già pensato tutto io”.
La domanda sull’Essere (o sulla Materia) non è peregrina. Non soltanto perché alcuni caratteri non riescono proprio a sopravvivere se non risolvono la questione (era il mio caso), ma anche perché alla Domanda delle Domande (Grundfrage) ne conseguiva un’altra: sapere tutto può servire a rendere il mondo un posto più confortevole? Un certo pessimismo, o meglio disfattismo di fondo, è necessario: non dobbiamo aspettarci dal mondo più di quello che il mondo può darci – più o meno disperazione, inferno e tragedia. Ma sapere tutto riuscirebbe quantomeno a lenire le ferite? A inumidire le labbra secche di un morente? (Non si chiede e non si dice di più).
E se sì, perché diamine dobbiamo tenere chiuso il sapere (che orribile parola: io, dopo attenta meditazione, preferisco chiamarlo il “saputo”) nei linguaggi accademici o nelle metafore e nelle allegorie della Letteratura? Perché non dire le cose come stanno e vedere che succede?
A Giuseppe Tratteur dobbiamo un’operazione di questo genere. La sua Biblioteca scientifica di Adelphi è un tentativo di rendere in qualche maniera pop il linguaggio accademico: una maniera di restituire alle cose il loro nome – particelle, quanti, stringhe. E Carlo Rovelli nella classifica dei bestseller (io aspetto che ci arrivi anche Paolo Zellini).

Senz’altro un atto liberatorio di Roberto Calasso, questa Biblioteca scientifica: lui stesso costretto per tutta la vita in tutte le metafore di questo dannato pianeta (metafore che spesso si sono chiamate “religioni”). Catene della metafora e dell’allegoria dalle quali Calasso ha tentato di liberarsi in due esatti momenti: la creazione, appunto, della Biblioteca scientifica diretta da Giuseppe Tratteur e Opera senza nome, il suo ultimo libro: “Ci sono mille buone ragioni per non fare quello che sto facendo. E una sola per farlo: dire con la massima precisione certe cose su alcuni libri che ho scritto”.
Le “mille buone ragioni” sono presto dette: i mille “codici” che usiamo per parlare dell’Essere. E dell’ulteriore domanda: ma cosa c’era PRIMA del Big Bang? A questa necessaria domanda chi è chiamato a rispondere? In che termini? E la risposta, ove vi fosse (c’è, c’è, vi ho detto che c’è), va tenuta segreta? Tramandata sottovoce?
Voglio dire: certo, coloro i quali si mettono sulla pubblica piazza a urlare di verità (altra parola oscena: qui si tratta di realtà, la verità la si lasci pure agli esaltati) sono pazzi.
Ma quelli che pensano ai Segreti della Materia e dell’Essere (e in ultimo ai Segreti di Dio) come qualcosa di destinato a un’élite di sapienti, non sono pazzi anch’essi? Chi si credono di essere? I Napoleoni del saputo?
(E quei molti che ancora si attardano perpetuando domande su domande, come se invece non sapessimo già tutto, non sono forse anche ignoranti, oltre che pazzi?).
Giuseppe Tratteur e Roberto Calasso questo fecero: assaltare le mura del sapere accademico e farlo tracimare all’esterno. Sì, in maniera “elegante”, “alta”. E mi ha fatto non poco sorridere come tutti quelli che stanno ricordando in questi giorni Tratteur ne sottolineino gli abiti. I gilet, le scarpe, persino i calzini.
Io accarezzo la mia copia sgualcita di un libretto e recito ad alta voce: “Oggi arrivano i barbari / e i barbari disdegnano eloquenza e arringhe”.


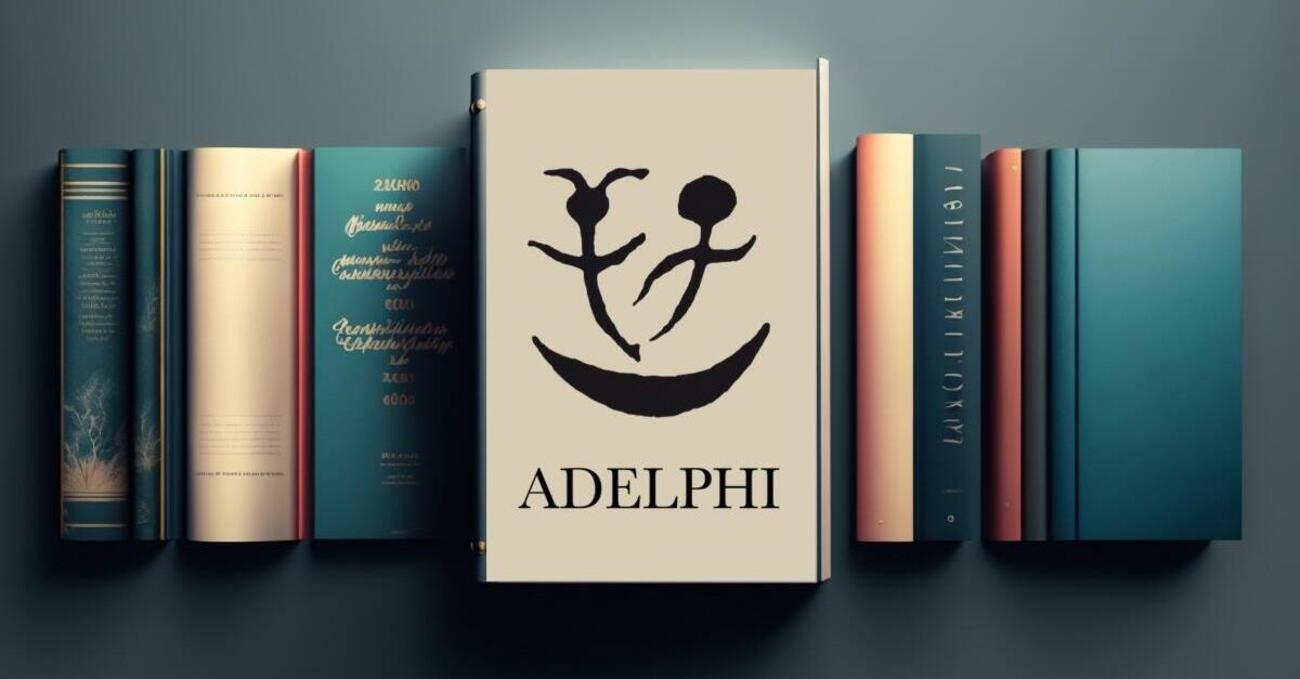





![[VIDEO] Delitto di Garlasco: “un avvocato è propenso a far confessare” Stasi e “Marco sapeva di un filmato”. Ok la guerra dei “poveri” scontrini di Sempio, ma le “nuove” intercettazioni?](https://crm-img.stcrm.it/images/49138193/HOR_STD/600x/img-4939.jpg)
