Non serve chiudere la bocca a qualcuno per metterlo a tacere. Basta chiudere l’account. Basta far sparire i suoi contenuti da un feed. Basta farlo affogare nell’irrilevanza. In un mondo in cui il dibattito pubblico passa quasi interamente da piattaforme private, dove l’informazione si muove dentro griglie invisibili, la censura non è più un atto violento, è un gesto amministrativo. Una notifica. Una policy. Un click. Strike! bum, bam. Fabrizio Corona è stato oscurato da Instagram e il suo account, oltre un milione di follower, cancellato da Meta con la motivazione di “violazioni ripetute degli standard della community”. Colpa della serie “Falsissimo” e di una causa per diffamazione. Il processo ancora non c’era. La sentenza nemmeno. Ma il silenzio era già esecutivo. Nessuna piattaforma pubblica. Nessun contraddittorio. Solo una porta chiusa da cui si esce senza nemmeno sapere bene chi l’ha chiusa. ByoBlu, il canale storico di Claudio Messora, è stato rimosso da YouTube dopo quattordici anni di attività. Tre strike per disinformazione medica e il canale sparisce, insieme a mezzo milione di iscritti. Nessuna possibilità di replica, nessuna revisione trasparente. È la piattaforma che decide cosa è vero e cosa no. Ma chi controlla la piattaforma? CasaPound e Forza Nuova bannate da Facebook e Instagram nel 2019 per “incitamento all’odio”. Decisione sacrosanta? Forse. Ma anche in questo caso, niente processo. Niente giustificazione pubblica. Un’azienda privata ha stabilito che certi contenuti non potevano più esistere. E un tribunale italiano, poco dopo, ha ordinato il ripristino di quelle pagine. A dimostrazione che perfino il diritto è rimasto fuori dal perimetro digitale. E non è solo un problema di periferia dell’impero. Trump bannato. Bolsonaro silenziato. David Icke rimosso. Andrew Tate oscurato. Alex Jones deplatformato. Kennedy Jr. cancellato da Instagram.
Una lunga lista di personaggi controversi quanto volete, molti tossici, altri solo scomodi. Alcuni pericolosi, altri solo fuori protocollo. Ma il punto non è il contenuto. La discussione sui contenuti sarebbe infinita, spostiamo la nostra attenzione sull'infrastruttura. È l’architettura della piattaforma che plasma la libertà, non la legge. E l’architettura è privata. Quello che accade in questi casi non è censura nel senso classico. È “content enforcement”. È “disattivazione per policy”. È “non conformità agli standard”. È un eufemismo dopo l’altro per dire che se non stai nel perimetro, sei fuori dal campo. Ma se il campo è tutto, se è lì che si costruisce la visibilità, la reputazione, la cittadinanza mediatica, allora l’esclusione diventa una condanna. Diventa silenzio coatto. La libertà di parola oggi non viene più negata in modo frontale. Le grandi piattaforme digitali hanno smesso da tempo di essere semplici strumenti di comunicazione. Sono diventate infrastrutture cognitive, luoghi in cui si forma l’opinione pubblica e si orienta il senso comune: i Ceo di queste aziende vanno a fare i Red Carpet con i politici, si fanno i selfie, fanno patti con il sistema. Lo fanno attraverso criteri opachi, regolamenti privati, policy che cambiano senza preavviso. Non rispondono a un elettorato, non sono vincolate da costituzioni, ma governano di fatto lo spazio pubblico.
È un potere enorme, tanto più pericoloso perché non viene mai nominato come tale. Il punto non è stabilire se le Big Tech siano buone o cattive. Il punto è che una concentrazione così estrema di utenti, dati, relazioni e attenzione produce inevitabilmente un’oligarchia del pensiero e non c’è Digital service act che tenga. Quando miliardi di persone comunicano all’interno di poche piattaforme centralizzate, chi controlla quelle piattaforme – direttamente o indirettamente – acquisisce un peso politico sproporzionato. Un peso che fa comodo anche alla politica, perché è più semplice dialogare, influenzare o fare pressione su pochi grandi attori che confrontarsi con una rete realmente distribuita e ingovernabile. Eppure non era questo il progetto originario del web. Ripetiamolo come un mantra: Internet nasce come non-territorio, come spazio senza centro, come ambiente punk e refrattario al controllo. Un ecosistema fatto di nodi, non di troni o tronisti. Un luogo dove il potere non poteva accumularsi facilmente perché l’architettura stessa lo impediva. Nel tempo abbiamo rinunciato a questa complessità in cambio della comodità, accettando che il web venisse progressivamente ricondotto dentro recinti proprietari. Abbiamo scambiato l’apertura con l’usabilità, la libertà con la semplificazione sempre per questa nostra tendenza ad essere umani, troppo umani.

Oggi dobbiamo però essere un pelo più consapevoli visto che viviamo immersi in questa grande rete e capire che esistono alternative concrete che non sono un salto nel vuoto, ma un ritorno a quella logica originaria. Il Fediverso (nome orrendo) non è un’utopia né un club per nostalgici. È un insieme di piattaforme federate, spesso open source, che comunicano tra loro senza un centro unico. Il principio è semplice: nessuna piattaforma possiede la rete, nessuno può spegnere tutti. Ogni comunità è un nodo autonomo, ma interoperabile con gli altri. Immagina il web centralizzato, quello che bazzichi quotidianamente, come un gigantesco centro commerciale. Tutti i negozi sono belli, colorati, funzionali — ma appartengono alla stessa catena. Le regole le decide una direzione unica. Se non piaci alla sicurezza, ti cacciano. Se chiude il centro, sparisce tutto. Non importa quanti follower avevi: eri in affitto. Il Fediverso, invece, è un arcipelago di villaggi indipendenti. Ognuno ha la sua piazza, le sue usanze, la sua lingua. Alcuni sono più piccoli, altri più vivaci, altri ancora più sperimentali. Ma tutti parlano una lingua comune per comunicare: puoi scrivere da un villaggio e farti leggere in un altro. Se un villaggio ti caccia, puoi trasferirti altrove senza perdere tutto. Nessuno controlla il mare che li unisce. È un ecosistema, non un recinto. E nell’ecosistema non c’è un tasto “spegni tutto”. Tutta questa pappardella non è utopia da nerd in pensione, puoi andare ora a registrarti su Mastodon o su PeerTube per capire come funziona. Mastodon, per esempio, viene spesso liquidato come “il Twitter alternativo”, ma in realtà è molto di più. È un social basato su istanze indipendenti, ognuna con le proprie regole, che però dialogano tra loro.
Non esiste un algoritmo centrale che decide cosa devi vedere. Il feed è cronologico, le interazioni sono dirette, la visibilità non è una moneta. Questo cambia radicalmente il rapporto tra chi parla e chi ascolta: non sei ospite di una piattaforma, sei parte di una rete. Friendica riprende invece la struttura più classica dei social network: profili personali, gruppi, discussioni articolate. È, di fatto, ciò che Facebook era prima di trasformarsi in una macchina di profilazione. Diaspora segue una filosofia simile, puntando su comunità storiche, meno rumore, più testo, meno performance e più contenuto. Per chi ha sempre usato Facebook come spazio di confronto e non come vetrina, queste piattaforme sono alternative reali, non surrogati. Per la parte visuale esiste Pixelfed, che restituisce alla fotografia e al racconto per immagini una dignità ormai persa su Instagram. Nessuna pubblicità, nessun shadowban, nessun incentivo a produrre contenuti pensati solo per piacere all’algoritmo. Anche qui il feed è pulito, cronologico, governato dalle relazioni e non dall’ottimizzazione commerciale. Per i video, PeerTube offre un modello altrettanto radicale: hosting distribuito, canali indipendenti, nessun centro che accumula tutto il traffico e il potere di moderazione. Il punto cruciale non è scegliere una piattaforma invece di un’altra. È comprendere che il potere nel web è sempre stato bottom-up. Le piattaforme centralizzate sono forti perché concentrano masse enormi di utenti nello stesso luogo. Se quelle masse fossero distribuite, anche solo in parte, su più reti interoperabili, il peso politico e culturale delle Big Tech si ridurrebbe drasticamente. Non per ideologia, ma per matematica esattamente come piace a loro, esattamente ciò che capiscono. Una rete distribuita è più difficile da controllare, da orientare, da usare come leva di pressione politica. Non perché sia caotica, ma perché non ha un centro unico su cui intervenire.
È questo che rende il Fediverso interessante dal punto di vista democratico: non promette una verità migliore, ma rende più difficile che qualcuno controlli tutta la conversazione. John Perry Barlow che purtroppo ci ha lasciati nel 2018, è stato un poeta, saggista, attivista per la libertà digitale e co-fondatore della Electronic Frontier Foundation (EFF), una delle principali organizzazioni per i diritti civili nel cyberspazio, lo aveva intuito con largo anticipo. Nel 1996, nella sua A Declaration of the Independence of Cyberspace, scriveva che il cyberspazio non apparteneva ai governi del mondo industriale, che non aveva confini, che non poteva essere governato con le stesse logiche del territorio e della coercizione fisica. Rivendicava uno spazio fatto di relazioni, transazioni, pensiero, un mondo “both everywhere and nowhere”, dove il potere non derivava dalla forza ma dall’etica condivisa, dall’interesse illuminato, dall’azione collettiva. Parlava di un luogo in cui non esisteva una sovranità centrale, in cui l’ordine sarebbe emerso non dall’imposizione, ma dalla responsabilità diffusa. All’epoca sembrava un sogno libertario, forse ingenuo, figlio di un internet ancora giovane. Oggi, a distanza di trent’anni, quelle parole suonano meno come un’utopia e più come una risposta possibile a un web sempre più normalizzato, regolato, addomesticato, riportato dentro recinti proprietari e logiche di controllo che assomigliano sempre meno a una rete e sempre più a un’infrastruttura di potere, controllo, sorveglianza e censura.
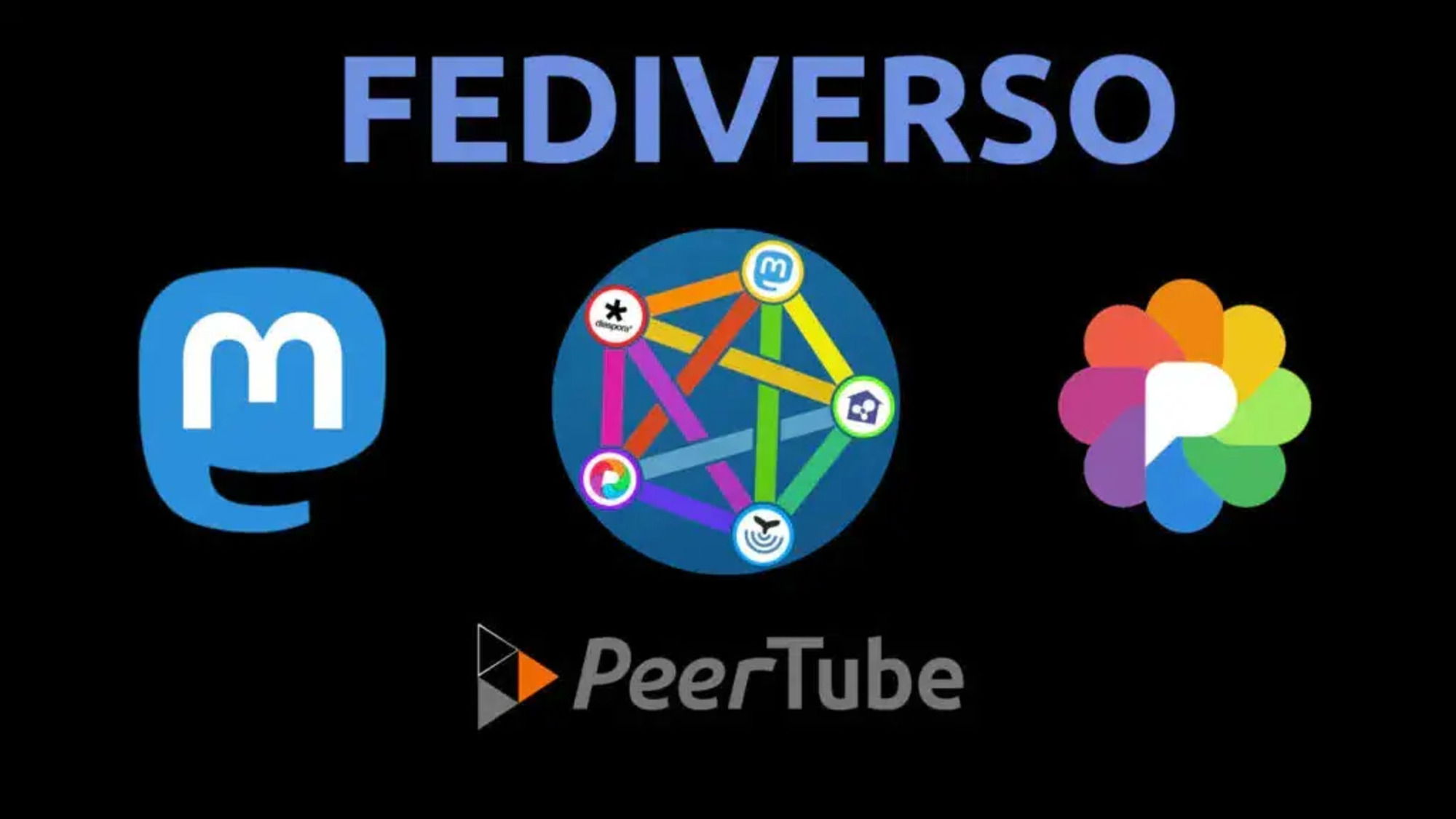
In Cina, Germania, Francia, Russia, Singapore, Italia e Stati Uniti, state cercando di respingere il virus della libertà erigendo posti di guardia ai confini del Cyberspazio. Queste barriere potranno forse contenere il contagio per un po’, ma non funzioneranno in un mondo che presto sarà avvolto da media carichi di bit.
Queste misure sempre più ostili e coloniali ci pongono nella stessa condizione di quei precedenti amanti della libertà e dell’autodeterminazione che dovettero rifiutare l’autorità di poteri distanti e disinformati. Dobbiamo dichiarare i nostri sé virtuali immuni dalla vostra sovranità, anche se continuiamo ad accettare il vostro dominio sui nostri corpi. Ci diffonderemo sul Pianeta affinché nessuno possa arrestare i nostri pensieri.
Creeremo una civiltà della Mente nel Cyberspazio. Che sia più umana e giusta del mondo che i vostri governi hanno costruito finora.
Davos, Svizzera
8 febbraio 1996
Dunque il 2026 potrebbe essere l’anno in cui smettiamo di chiederci se queste alternative siano comode o popolari e iniziamo a chiederci se siano necessarie. Perché continuare a concentrare tutta la nostra vita digitale nelle mani di pochi attori significa accettare che anche il potere di influenzare il pensiero resti nelle stesse mani. Distribuire gli utenti significa distribuire il potere. Significa rendere meno efficaci le oligarchie del pensiero, meno conveniente la manipolazione, meno semplice l’uso politico delle piattaforme. La libertà di parola non si difende solo con le leggi, ma anche pensando alle infrastrutture. Se le infrastrutture sono centralizzate, anche la libertà lo sarà. Se sono distribuite, lo sarà anche il potere. Il Fediverso o come cavolo vogliamo chiamarlo, non è una soluzione magica, ma è una direzione chiara. Un promemoria potente che un altro web non solo è possibile, ma è già qui. Sta a noi decidere se continuare a delegare il nostro spazio pubblico a pochi oligarchi digitali o tornare a costruirlo, nodo dopo nodo, dal basso.








![Delitto di Garlasco: Bugalalla come Fabrizio Corona? Vogliono farle chiudere tutto! Ma spara altre intercettazioni di Ermanno Cappa, la moglie Maria Rosa e le gemelle Paola e Stefania [VIDEO]](https://crm-img.stcrm.it/images/49268027/HOR_STD/600x/photo-2025-01-22-23-44-12.jpg)


