“Era però l’occasione per ricordare, attraverso le parole di Barraco, come perfino una sua concittadina non meno titolata, Benedetta, in decollo verticale, durante un’iniziale ordinaria conversazione WhatsApp aveva d’improvviso chiesto, esplicita, all’organizzatore di eventi: ‘Ma tu, in questo esatto momento, mi s*operesti, eh?’. Di fronte al silenzio del raggelato, convinto di ragionare semmai su una storia di predelle necessarie per un allestimento, Benedetta aveva aggiunto: ‘Ma adesso, subito, intendo! Sappi che sono qui, nuda, con un dito già dentro la fi*a! Non fare finta di non capire, dimmi solo quando arrivi!’” Precisiamo subito: non si tratta di un romanzo porno, la stessa finezza dello stile lo escluderebbe. Questo passo, icastico e diretto, è a pagina 176 dell’ultimo romanzo di Fulvio Abbate, Lo stemma, da poco uscito presso La nave di Teseo: un’opera robusta, diffusa e felicemente ricca, come ci è dato raramente di trovare nella produzione attuale degli autori nostrani. Anche perché definire Abbate “autore nostrano” sarebbe decisamente riduttivo, visto che non gli si può attribuire alcuna categoria, se non l’appartenenza alla letteratura tout court. Sul seguito di questa scena non ci pronunciamo, è bene che quelle pagine vengano gustate per intero: ci limitiamo a un “la dama, già carponi sul letto…”. Lo stemma è un romanzo corale coinvolgente, un grande affresco che ha Palermo come scenario assoluto, una di quelle città-mondo capaci di creare da sole un’epopea visionaria e dettagliata, che sia anche emblematica e riassuntiva di un’epoca e del suo tramonto, della sua trasformazione e “aggiornamento” alle derive attuali. È Panormo, così chiamata in età greco-romana perché dotata di buoni approdi naturali, “città tutto porto eppure assente all’eros pieno, nonostante il suo nome uterino, vaginale, implicitamente perfino clitorideo; le sue grandi labbra immobili ad accogliere dal mare chi dovesse giungere in nave all’alba da Napoli, Tunisi, le Eolie o da Genova”. La città che è protagonista e allo stesso tempo sfondo dietro l’agitarsi di figure emblematiche di un mondo, nel suo vario declinarsi nella nobiltà, nella mediocrità, negli eccessi, nelle assurdità etiche ed estetiche, il tutto attraverso la consapevole inconsapevolezza di una banda di personaggi pronti a esprimere se stessi con le proprie pulsioni e tensioni emotive. In questo “anti-Gattopardo” – così definito dall’autore – la protagonista, seguìta nello svolgersi dell’intreccio di vicende collegate, è Costanza Redondo di Cosseria, una giovane principessa il cui stile di vita riassume i rituali di una nobiltà panormitana decaduta che non rinuncia ai simboli di status ed esprime in modo plastico la propria mediocrità esibita come blasone, come emblema di supremazia sociale sul resto del mondo. Resto del mondo che – va da sé – tiene Palermo come centro universale, come area mistica al di fuori della quale la realtà ontologica non viene quasi concepita, come se non dovesse esistere alla conoscenza umana.

“La principessa Costanza Redondo di Cosseria è una p.!” è la scritta in vernice gialla apparsa su un muro di via Principe di Paternò una mattina di febbraio. Qui inizia il dramma, ovvero la rottura dell’equilibrio, nemmeno vissuta con eccessivo pathos dalla principessa ingiuriata, che da questo incidente cerca di avviare un’indagine sugli autori e sui moventi dell’aggressione. Accanto a lei si staglia la bella figura del cugino, il barone Carlo Sicuro di Torralva, che già all’inizio si diletta di sesso selvaggio con l’amica francese di Costanza, Blanche Josserand de Merléac, giovanissima esponente di un’imprecisata nobiltà francese, giunta a Palermo per farsene letteralmente fagocitare. C’è anche il teologo Maurilio Steiner, monsignore con ascendenze svizzere appassionato di avanguardie artistiche, intento alla missione morbosa di individuare e rintracciare un ragazzino che appare in un vecchio ritratto scolastico di gruppo, “terza fila dal basso, al centro della foto, ottavo da sinistra: viso ovale, sguardo convinto, la frangetta sollevata a formare una piccola muraglia irregolare, orecchie a sventola: il designato”. Costanza Redondo di Cosseria passa le giornate tra pranzi e cene con gli amici, passeggiate col cane cirneco Charas e giretti con la sua Porsche color blu notte, in una routine che viene rotta da questi attacchi minatori, materializzati anche in lettere anonime: “Carissima principessa di ‘sta grandissima funcia di minchia, abbiamo della Signoria Vostra foto, immagini, scatti privati che se solo fossero mostrati pubblicamente vorremmo vedere la sua faccia appunto di minchia…”. Non secondaria è la figura di Duilio Vitanza, in seguito giustiziato in trattoria, la cui esecuzione aggiunge indagine a indagine: archivista-usciere in un assessorato regionale, ex eroinomane con la vocazione del santonismo esoterico e delle pratiche magiche, improvvisatosi esperto di arti divinatorie con sottobraccio il libro dell’alchimista Fulcanelli Il mistero delle cattedrali a convalidare il suo carisma. Egli assurge a riferimento per Costanza, che diviene una delle sue più assidue frequentatrici: quando nel suo consultorio le lascia cadere davanti i tarocchi di Marsiglia, fa “subito giungere alle pupille sgranate della principessa una carta che, con mille smorfie, l’uomo prende a indicare di lampante significanza, l’Appeso”. Salvo Ciofalo, “degno esempio di foglio protocollo bianco mentale”, è uno dei migliori amici di Costanza – confidenzialmente “Costi” –, con la quale ama interrogarsi sui massimi sistemi mentre le versa un infuso di tè bancha. “Cioè, perché, secondo te, perché dovremmo esserci, tipo, soltanto noi nell’universo?” Ci si deve forse arrendere all’idea “che ci sono soltanto i gargioni nell’universo?”. Gargio viene da Gorgeous, spiega l’autore, ossia stupendo, smagliante, elegantissimo: qualifica squalificante di chi esibisce velleità di apparenza senza sostanza, in modo esagerato e senza gusto. Ma la figura femminile pienamente sexy, che incarna un inno alla felicità degli istinti, è Pina Capizzi detta Penny, di famiglia mafiosa, che a differenza delle antiche donne arcigne in abiti penitenziali è “creatura espansiva, diretta, appariscente, sessualizzata in ogni suo gesto dei polsi e nelle movenze dei fianchi. Trentenne pronta a brillare d’ogni potenziale erotico in atto”.
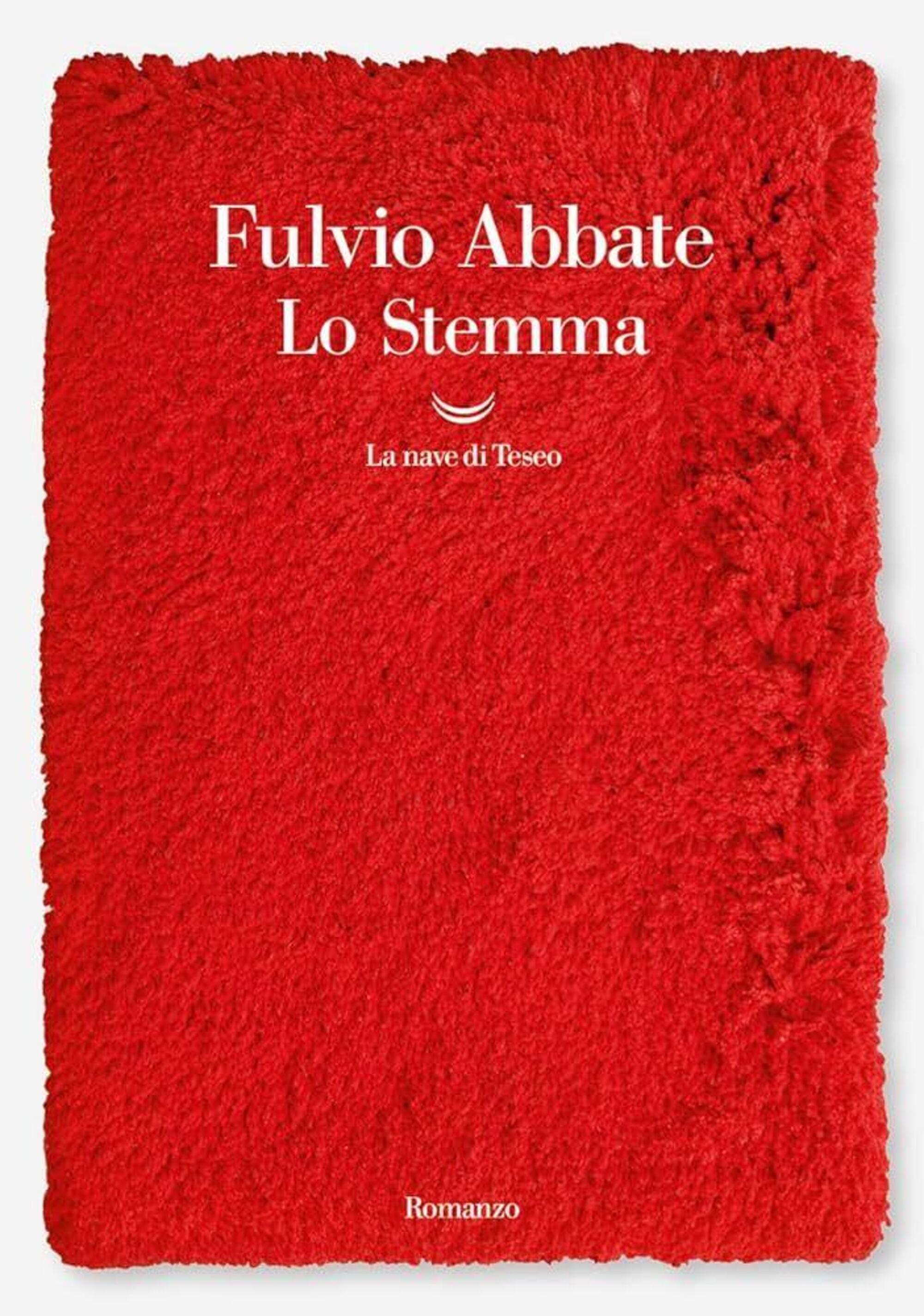
Ma andiamo a Ruggero “Ruggi” Barraco, definito “giovane organizzatore di eventi culturali, manager o pierre o capogita”, figlio di un ceto benestante che “mostra talento da mantenuto rispettato, temuto”, disposto a tutto per ottenere l’appalto, merchandising compreso, per la realizzazione del Carro del Festino di santa Rosalia. È grande il suo influsso su Costanza, che se ne sente soggiogata, ne attende sempre il ritorno, ma ne soffre l’anaffettività e la continua fissazione su questioni visionario-affaristiche. Il vero appoggio della principessa rimane il citato cugino Carlo Sicuro di Torralva, uomo intelligente e sufficientemente erudito, che con la sua voce critica cerca inutilmente di condurre Costanza – sempre “a corto di strumenti di comprensione sia del reale sia di eloquio” – a uno stato generale di consapevolezza. Sua è la mesta considerazione che “nel corso del tempo, Palermo aveva prodotto in massima parte soprattutto creature per statura filosofica degne di un lemure”. Uso a porsi domande vere, Carlo ama dar conto delle sue osservazioni sul mondo nella rubrica “Il Carnet del Barone”, quaderno di critica ricco di spigolature cultural-esistenziali, “destinato a un pubblico di diportisti del pensiero”. Tra le figure secondarie, lo svogliato commissario Francaviglia a cui Costanza si rivolge per indagare sulle minacce che sta ricevendo, la scrittrice velleitaria Vittoria Cilona della Ferla, che si pretende autrice di un seguito del Gattopardo, lo psicoterapeuta femminiere Corrado Pravitara col suo istinto predatorio. Fino alla comparsa in scena – quasi in sordina – di Sergio Sucato, detto “Brando”, una sorta di Tommy Lee Jones a cui mancano i tratti tormentati, commerciante di moquette e soave calcolatore che diventa personaggio-chiave. Lo stemma è un romanzo-mondo, un romanzo-catalogo, e anche un romanzo-fiume che porta il lettore nella sua corrente. Qui troviamo l’arte, la storia, la cronaca, la musica, il cinema, la letteratura, l’aneddotica, la reminiscenza, la prospettiva del possibile, tutte riunite a convegno per una cavalcata collettiva che si ferma solo a questioni concluse. Madonna, Lady Gaga, Frida Kahlo, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, la pittrice Carla Accardi, le sniffate di coca, il sesso, André Breton, Trotsky, le Catacombe dei Cappuccini, Francesco Rosi, Giuliano Gemma, Majakovskij, i Beati Paoli, Che Guevara, Leonardo Sciascia, Salvador Dalì, Alberto Arbasino, l’artista Luigi Ontani che ritrae perennemente sé stesso, Keith Jarrett, Bill Evans, Yves Klein con i suoi blu, Alexandre Dumas, Mario Monicelli, Adolfo Celi, Giuseppe Garibaldi, Gaetano Testa, il Gruppo ’63, Francisco de Zurbaràn, Aleister Crowley, il Conte di Saint-Germain, Carlo Lizzani, Tina Aumont, Massimo Ranieri, la serie di francobolli con le Fontane, e potremmo proseguire, ma vogliamo lasciare la scoperta a chi avrà la fortuna di leggerlo.
Il dipanarsi degli eventi viene vissuto dal lettore in diretta, standoci dentro: la figura di “Costi”, tanto stolida quanto misteriosamente desiderabile, diventa catalizzatrice insieme a quella del cugino Carlo, con le sue meditazioni e prese di coscienza che si portano fino alla fine. Il punto di vista di Fulvio Abbate sa adottare la distanza del panormita esule, comunque distaccato dal ribollire della matrice da cui discende, e lo fa dando all’insieme una compattezza strutturata che ne esalta la forza espressiva. Nel viaggio ci accompagnano le digressioni e la topografia dettagliata della città, perché Palermo è in sostanza il luogo della storia di quell’aristocrazia, di quegli attori che sono irrimediabilmente palermitani e discendono da un utero panormita – panormo, come si è detto, in greco significa “tutto porto” – e quindi rispondono fatalmente e definitivamente a quel luogo. E qui si trascende da Palermo stessa per innestarvi una riflessione sulla mediocrità, un valore o disvalore che rimane immanente, irrimediabile, planetario. È questo dato catastale a rimandare ai luoghi in modo quasi iperrealistico, creando una sorta di scansione evocativa che è insieme topografica e antropologica. La sintassi è espressiva e impeccabile, pur nella sua irriverenza, e l’ironia dello stile rende la lettura godibile senza cedimenti. Abbate fonde l’andamento fluente della narrazione orale col tono alto della letteratura, creando così un effetto-realtà che trascina e seduce. Un romanzo da consultare come libro di testo, un regesto di storie in cui si avverte un orgoglio letterario autentico, difficile da ravvisare nelle produzioni correnti: qualcosa che resiste all’impoverimento, alla semplificazione, alle scorciatoie oggi così diffuse, e anche alla brevità saccente di qualche autore nostrano che con quell’espediente simula una supposta superiorità etico-intellettuale. Lo stemma, in definitiva, è un omaggio alla grande tradizione romanzesca del Novecento, autentico e senza compromessi.












