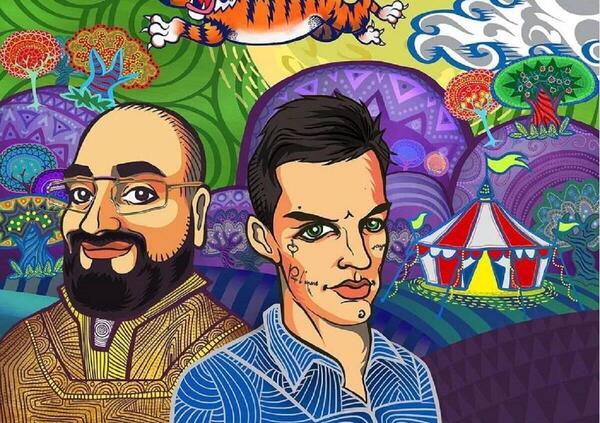Il racconto è uscito per Write and Roll nel 2016, ma la ricerca di se stessi attraverso Franco Califano rimarrà sempre attuale.
Parto all’alba da Piacenza, l’unica luce è del navigatore con impostata la destinazione: “Ardea, Roma, 560 chilometri in 5 ore e 23 minuti”. Sto facendo qualcosa che non ha nessun senso. Da poco ho perso il lavoro, non è tempo di sognare. Dovrei pensare a ritrovare una stabilità economica. Cosa vado a fare a Roma al premio Franco Califano “Che fine hai fatto cantautore”.
E’ ottobre, nel nord Italia è già inverno. Appena arrivo invece ho caldo. Il cielo è nuvoloso ma la temperatura è perfetta per un maglione di cotone. Ho prenotato una camera nella zona del Vaticano. Stanzetta piccola, pulita, al settimo piano a cui si arriva con un ascensore anni ’50. All’interno mi accoglie un arredamento antico con pizzi, merletti, crocefissi e il titolare: un giovanotto gentile, l’appartamento era di una zia scomparsa ora riconvertito in ostello.
Scendo e mangio in un ristorante cinese. I romani parlano a voce alta, come se tutto potesse essere discusso in piazza: “Mé fai il riso alla cantonese che so gonfio de pancia?”, arringa uno al cameriere e del suo problema viene informata la sala. Al mio fianco una coppia di mezza età che ha “magnàto” come se non ci fosse un domani. Ad ogni portata, serviti direttamente dal titolare, gli hanno ripetuto: “Sei bravo, molto bòno”. Quando arriva il conto, l’uomo prende per il braccio il cinese e gli chiede: “Lo sai come sé fa a essè più bòni ancora?”. Non poteva saperlo. Come? gli domanda sgranando gli occhi a mandorla. “Se nùn me fai pagà!”.

Parto per Ardea, distesa di case dopo Pomezia tra i Castelli romani e il mar Tirreno. E’ l’ultimo confine a sud della Capitale e il cartello con “Roma” sbarrata di rosso appena fuori dal centro abitato lo certifica. Cerco il cimitero in cui è sepolto il Maestro, tra strade sconnesse e polverose, immondizia ai lati della strada e un paesaggio bucolico in sali e scendi. La visita è d’obbligo. Qui ha scelto di essere sepolto, insieme al fratello e al nipote. Non avendo la residenza il Comune gli ha conferito la cittadinanza onoraria postuma che ha permesso la tumulazione.
Sbaglio campo santo. Quello antico, piccolo e affollatissimo di tombe e lumini è gestito da un custode sosia di Alain Delon. Ma sicuramente più gentile. Con i suoi occhi azzurri e il sorriso cordiale mi spiega che il cimitero nuovo è poco distante, su una collina. All’arrivo non ci sono dubbi. La fioraia ha addobbato il gabbiotto con foto e locandine del Califfo e in sottofondo ascolta “L’urtimo amico va via”. Mi dice che parteciperà alla serata del teatro Olimpico: “Nùn sé po’ mancà”, sentenzia. Faccio due passi per i viottoli e rimango a bocca aperta. E’ come se i “cari estinti” fossero ancora indaffarati nella loro quotidianità: a un panettiere hanno ricostruito un piccolo forno proprio davanti alla pietra sepolcrale. A un ragazzino di neanche vent’anni è stata incollata una moto in miniatura sulla lastra di marmo e sotto la foto la scritta: “Vai Claudié, nùn tè fermà”. Sono centinaia così addobbate e pare che da un momento all’altro qualcuno possa uscire davvero da quelle sepolture per sbrigare i propri impegni.
La più sobria, stranamente, è la grande lapide di Franco Califano. Tutta bianca, con una stella dorata nel mezzo in stile “Walk of fame” di Hollywood, sulla lapide un grande mosaico che lo ritrae color seppia con la dicitura “Non escludo il ritorno” e al suo fianco Guido e Fabrizio, i suoi cari. A terra una lavagnetta riporta scritte dei visitatori: “Shhh! Qui c’è un guerriero che sta riposando…”.

Poco distante dal cimitero si trova la casa museo. La sacerdotessa del culto “franchiano”, così si chiamano i suoi fans, è Donatella Diana, perché lo chiamava il Divino e negli ultimi dodici anni di vita dell’artista è stata al suo fianco. Ha allestito nelle sale donate dall’amministrazione una serie di memorabilia, con oggetti salvati dalla casa in cui è scomparso, ad Acilia. Foto, locandine, quadri, premi e la poltrona leopardata a lui tanto cara.
Torno verso Roma con l’amaro in bocca. Quel che rimane dei grandi artisti non è quasi mai nelle cose ma nelle immagini che hanno saputo evocare. E infatti è per via Trionfale verso l’ex bar Java, oggi Doria, che ritrovo la giovinezza di “Semo gente de borgata”, così come a Primavalle dove la passione per il calcio lo aveva portato a presiedere una società, il Tanas e a scrivere “Er tifoso”, oppure a Rebibbia, dove era stato recluso e gli aveva ispirato il pezzo portato a San Remo “Io per le strade di quartiere”, dove vestito come un personaggio de “Il padrino” di Mario Puzo cantava: “Io, con un penale tutto da pulire. Io che non la davo vinta neanche morto. Io, che mi hanno sempre tolto il passaporto”. E ancora a Fregene, dove camminare a piedi scalzi nella sabbia ed emozionarsi per un tramonto, o all’Eur in ammirazione della modernità più fredda e razionale. Franco Califano non si trova a Roma. Franco Califano è Roma. E basta guardarsi intorno.

Il giorno dopo mi preparo per la serata. All’Olimpico ci saranno 14 giovani artisti romani in gara, per una rassegna organizzata dai suoi musicisti storici Alberto Laurenti e Antonello Mazzeo. Nel pomeriggio incontro un caro amico che lavora a Roma e si offre di accompagnarmi. Il teatro Olimpico è strapieno, i “Franchiani” arrivati da ogni dove si accalcano all’ingresso trepidanti. La serata è condotta da un Claudio Lippi che si rivelerà magistrale e una appassionata Rita Forte.
Mancano pero’ totalmente i personaggi famosi che erano stati annunciati. Non c’è Gianluca Grignani, che doveva presiedere la giuria, assente Edoardo Vianello, Federico Zampaglione fa solo una comparsata, saluta tutti e se ne va. Mi chiedo cosa avranno mai da fare, invece di celebrare per la prima volta il Re di Roma? Fa niente. Perché la musica dei giovani artisti fa dimenticare ogni malinconia nonostante le perplessità iniziali, il pubblico caldissimo si esalta a ogni ritornello o aneddoto sulla vita del Califfo. L’omaggio più sentito, a sorpresa, è arrivato da Maurizio Mattioli sulle note di “Io non piango”. Alla fine, scherzo del destino, vince una donna. L’unica in gara, Valentina dello Russo e il premio “Roma Nuda” per il miglior testo in dialetto romanesco va a Stefano Lazzarini.
Si accendono le luci in sala e qualche fila più avanti scorgo un viso conosciuto. E’ Stefano D’Orazio, cantante dei Vernice. Nel ‘93 sono stati la mia colonna sonora di tutta una estate. Dal Festival di Castrocaro, dove si fecero mandare a casa per quella “stronza” urlato in prima serata su Raiuno alla ex fidanzata che lo aveva lasciato, fino al tormentone “Su e giù” che rimbombava nelle radio: “Strano io, strana la mia vita. Questa cosa qui, io non l’ho mai capita”. Gli stringo la mano, ci facciamo un selfie. E’ sparito dalle grandi ribalte ma sembra fottersene e per me rimane un mito.

Usciamo a mezzanotte e il mio amico mi avvisa: “Ti devo far vedere la Grande bellezza”. Prendiamo uno scooter Enjoy, quelli che trovi sparsi in giro e prenoti con lo smatphone e via per le larghe strade svuotate dal traffico. In quattro ore ho visto più cose che in dieci anni a Piacenza. Roma è uno scrigno. Se la visiti da solo ti ritrovi sempre nei classici posti da turista, con i giapponesi che scattano foto anche ai cassonetti. Con qualcuno che la conosce scopri quel suo candore fuoriuscire da infiniti elementi nascosti. Finiamo in San Lorenzo, beviamo una birra tra ragazzi che fumano canne e ballano reggae al ritmo di un bongo. Poi chiudiamo la serata in un quartiere residenziale su un colle. “Guarda bene”, mi avvisa. Vedo il Cupolone tra i palazzi, enorme. Ma più ci avviciniamo e più l’effetto ottico lo restringe. Fico, chissà a quante ragazze lo avrà fatto vedere prima di provare a limonarle. In fondo una terrazza, dove godersi la vista mozzafiato di quella che non è una città ma un mondo stratificato di storia, cultura, arte e fantasia.
Tornato nella mia stanzetta in zona Vaticano sono le quattro e mezza. Sono esausto ma fatico a dormire. C’è qualcosa che questi due giorni mi hanno lasciato e non riesco a spiegarmelo. Una libertà e una leggerezza che mi hanno fatto dimenticare frustrazioni e angosce. La mattina riparto e il clima è meraviglioso. Un autunno color pastello, con le piante ingiallite e non ancora spoglie, condito da un venticello tiepido e una indolenza accentuata dal testo poetico di “Un tempo piccolo” che riempie l’abitacolo mi accompagnano all’autostrada. Solo nel ritorno inizio a capire cosa ho provato. Volevo scrivere qualcosa su Franco Califano – con il pretesto del concerto – e invece mi sono ritrovato a farlo di me stesso. Ho intrapreso il viaggio più inutile della mia vita, nel momento in cui avrei dovuto concentrarmi sulle azioni più utili, e mi sentivo stranamente appagato. Ho compreso che per raccontare qualcosa bisogna viverlo intensamente, senza preoccuparsi troppo di quanti soldi porterà in tasca e a quali conseguenze andrai incontro. Più di quel che sono e voglio, ho capito ciò che non sono e non voglio diventare. E non mi sembra poco.
Tutto il resto è noia.
Se siete arrivati fino a qui seguiteci anche su Facebook e su Instagram