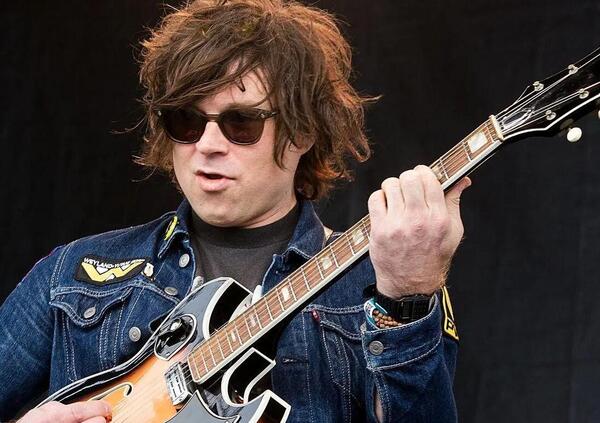“Il problema è che della musica non frega più niente a nessuno”. Parola di uno che è immerso nella musica dal primo giorno – siamo nel 1994 – in cui il pubblico ha iniziato a conoscerlo. Non c’è da annoiarsi con Enrico Silvestrin. Non è noioso il suo canale Twitch (“attraverso cui, da fine 2018, posso dire ciò che voglio e mandare in streaming tutta la musica nuova, tassativamente nuova, che YouTube mi nega”). Primo VJ italiano di Mtv, attore, conduttore radiofonico e televisivo e divulgatore musicale. Si può essere d’accordo o meno con lui, ma è difficile che passi inosservato. Lo abbiamo intervistato e non ci ha deluso, come sempre.
Voglio innescarti subito: il pop ha fatto all-in e ha vinto. Non c’è più spazio per null’altro?
C’è spazio per una divulgazione libera, non costantemente sulla difensiva. Fatta con sentimento e non per fare solo numeri.
Sulla difensiva?
Comunicare la musica in Italia è complicatissimo. C’è gente che se gli sfiori Queen, Dire Straits o Guns N’ Roses va fuori di testa. Pensano siano nomi assoluti, su cui non si possa eccepire nulla. Poi magari ignorano Can e Kraftwerk. O i Beatles, addirittura. Artisti che la musica l’hanno cambiata sul serio. Ma è un paese, il nostro, che difende tutto ciò che gli ha dato un’emozione: dal pop-punk al nu metal. Tutto, indistintamente.
E invece?
Invece la musica è contestualizzabile. Non è detto che ciò che mi ha dato un’emozione debba essere per forza considerato “artisticamente immortale”. Puoi ascoltare le stesse 20 canzoni tutta la vita, nessuno te le toglierà mai, ma non incavolarti se qualcuno prova ad andare oltre.
Quindi tu cosa provi a fare con i tuoi mezzi?
Cerco di diffondere musica nuova. Il gene della creatività artistica non è morto. Faccio ascoltare la musica che oggi ascoltereste a Berlino, Londra, New York.
Un menù in cui, credo, manchino i 20 migliori dischi italiani selezionati da Impatto Sonoro, ad esempio.
In quella lista ci sono cose interessanti, però sì, quei dischi non ci sono. Ho letto una loro recensione dell’ultimo disco dei Coma Cose, ad esempio. Capisco l’esuberanza, ma mi sono imbattuto in una sfilza di aggettivi che, sinceramente, non credo vadano utilizzati per i Coma Cose.
Come motivi tutto questo entusiasmo?
Alla base c’è uno dei vizi capitali della critica italiana. Ce lo portiamo dietro da sempre: per la nostra critica va tutto bene, è tutto bello. Spesso artista e giornalista sono pure amici, quindi puoi ben immaginare quanta libertà ci sia nel giudizio del secondo sul primo. Però certa musica italiana voglio conoscerla. Per saper dire “no, grazie” con cognizione di causa. Per dire “no, grazie” all’ultimo album dei Nu Genea, tanto per fare un nome hot.
Sei incontentabile, però.
No, affatto. Sono gli altri, non tutti, ovvio, che hanno deprezzato la musica a tal punto da non avanzare più alcuna pretesa. Va tutto bene. Ma siccome mi rifiuto di riascoltare solo The dark side of the moon come fosse una sorta di metadone, seleziono musica nuova che abbia qualche ambizione. Non per forza l’ambizione dell’immortalità, bada, quanto di affermare qualcosa oggi, nel 2023.
Un discorso che rischia di portarti lontano dai famosi numeri. Oggi anche un marchio come Coachella ha abbracciato una filosofia commerciale: suoni se porti-garantisci numeri.
Che esista un mercato lo so perfettamente. Solo che la musica non è stata sempre solo mercato.

La parola mercato mi suggerisce un nome: Festival di Sanremo. Come vedi J-Ax, con il quale in passato hai collaborato, al Festival di quest’anno?
Non credo sia un’operazione rivolta a gente come me. È una rispettabile scelta di business. Cosa possono avere da dire, oggi, gli Articolo 31? A Sanremo ci vanno per loro stessi, per imbastire un tour, mica per dire qualcosa. Come quando Ax fece la reunion con Fedez. Si vedeva da lontano un miglio che si stavano ancora sulle palle, però era business.
È anche solo business quello di Måneskin e Greta Van Fleet?
Sono band poco genuine. Il cosplay applicato all’estetica rock. Nel caso dei Greta non basta suonare come i Led Zeppelin se poi non sai scrivere le canzoni. Se qualcuno pensa che questi gruppi possano salvare il rock, non mi sta bene. Questo è pop rivestito di vecchissima estetica rock. Il rock, come genere, fatica più di altri perché, dopo essersi ibridato per decenni, pare destinato a ripetersi continuamente. Anche nel nome di una difficoltà direi tecnica. Il rock non va d’accordo con le nuove tecnologie ed è ostaggio della miopia di alcuni suoi cultori.
Cosa intendi?
Troppe frasi fatte, troppi manifesti vuoti. Ma cosa vuol dire “meglio uno che suona uno strumento vero di uno che schiaccia play”? Cosa significa, esattamente? I computer fanno tutto da soli?
Infatti ogni tanto mi imbatto in qualche commento bello tosto sotto i tuoi video.
La meccanica è semplice. Vengono da me per verificare – come si trattasse di una sfida – se la musica nuova che propongo tiene botta. Per poi dire “non mi piace perché non ha nulla da spartire con Tizio o Caio” e rintanarsi di nuovo nell’abituale comfort zone. Ma per me la musica non è una sfida. Non mi interessano più i voti, le classifiche, desidero solo divulgare cose che altrimenti, ahimé, nessuno ti fa ascoltare.

Quindi, in fondo, è il nostro pubblico il problema?
Non solo. Il nostro pubblico vive un contenitore come il Firenze Rocks come fosse un Eden del rock, quando invece è un non-festival gestito unicamente da promoter che, privi di alcuna visione artistica, collocano su quel palco i gruppi che hanno nel roster. È lo stesso pubblico che, misteriosamente, corre ancora a vedere i Green Day, felice di farsi fotografare mentre fa il dito medio e il gesto delle corna. I Green Day, ancora!
Quale sarebbe quindi l’altra parte del problema?
Che non ci sono più maestri credibili. Qualcuno che divulghi in modo sincero e appassionato, addirittura affettivo. Cercano tutti i numeri, è un cane che si mangia la coda. E poi c’è una questione epocale: oggi gli studenti si sentono maestri. Oggi se qualcosa non ti piace immediatamente diventa subito “brutta”. E non c’è scampo, nessuno che si metta in discussione, che voglia sforzarsi di capire.
Enrico Silvestrin, a 20 anni, aveva l’atteggiamento giusto, secondo te? Cosa diresti oggi, da cinquantenne, al te stesso di 30 anni fa?
Mi direi grazie. Perché all’epoca, quando lavoravo per Mtv, ho imparato il mestiere che oggi sto spendendo in totale libertà. Allora avevo un padrone, oggi no, però non facevo qualcosa che non sentivo. Mi dicono: epperò anche tu hai intervistato i Tokio Hotel. Embè? Mtv dopo poche puntate mi disse che avrei dovuto iniziare a scrivermi i testi da solo. Sai quanti, fra quella ventina di VJ, oggi, si occupano ancora di musica? Io e Paola Maugeri, gli altri volevano solo diventare presentatori. Con una differenza: Paola ha un autore che le scrive ciò che deve dire, io no.
Il filo conduttore pare essere quello della scarsa libertà che tutti respiriamo.
Secondo te il rock sarebbe mai potuto crescere se a proporlo fosse stata Virgin Radio?
Se ne esce?
Se ne esce se si smette di farci andare bene tutto. Non ha senso dire: beh, meglio i Måneskin della trap o dei BTS. Se insistiamo a scegliere il “meno peggio”, siamo fottuti.