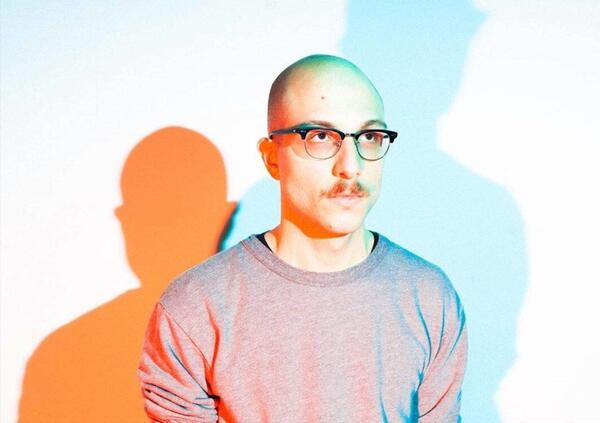Noi non possiamo pretendere che gli artisti rimangano uguali a sé stessi. Non possiamo pretendere che tengano sempre alta la qualità alla quale ci hanno abituati, specialmente se raggiungono un apice (quantitativo) dal quale è solo facilissimo cadere. Non possiamo pretendere che l’artista si conformi alla nostra egoistica aspettativa viziata dal tempo e dalle circostanze: dobbiamo accettarne l’evoluzione o l’involuzione. Queste e altre menate vagamente democristiane tenevamo in mente prima di ascoltare Lucio Corsi per la seconda volta, ora su un grande palco, dopo averlo visto una prima di fronte a cinquanta persone, comprensibilmente terrorizzati di poter assistere a una débâcle.
Approfittiamo dell’occasione per rinfrescarci la memoria: quando Lucio Corsi non era ancora il fenomeno pop ai limiti del teen idol in cui è stato trasformato da Sanremo (come è nella natura delle cose), l’avevamo visto salire sul palco per l’ennesimo concerto della sua carriera, all’epoca già dieci anni di musica e di gavetta alle spalle, raffreddato e visibilmente stanco. Raramente avevamo visto un performer più generoso sul palco. Gridammo al miracolo e ci fermammo a fare chiacchiere promettendoci di tutto pur di fare uscire questo nome dalla nicchia solo grazie al passaparola. Ma si sa che quando si è piskelli l’eccitazione può offuscare ogni senso, e ora che siamo vecchie scafatissime cariatidi? La difficoltà sta in questo punto qui: nel non cascare nel tranello della realtà che muore perché iperbolicamente sentiamo di star morendo noi, ovvero le nostre idee, i nostri entusiasmi, la nostra eccitazione rock ’n’ roll postpuberale.
Per questi motivi rivedere Lucio Corsi dopo l’incredibile e prevedibile botta di fama ha posto noi spettatori con la puzza sotto al naso in crisi: non era un concerto, era un corpo a corpo con la sindrome di Mastro Don Gesualdo. E tutto ciò noi dovevamo ben tenerlo a mente. Ma è possibile che un concerto come quello del Locus Festival possa deluderci non solo per colpa nostra e dei nostri fantasmi? Ce lo chiediamo dopo alcuni confronti con chi giustamente ci fa notare l’impatto dell’effetto sconosciuto e dell’esaltazione narcisistica che ne deriva nel sentirsene scopritori, rispetto al triste monito del “c’ero dal giorno zero, ora è cambiato” eccetera. Allora limitiamoci a registrare alcuni dati con la massima obiettività possibile.
Lo spettacolo di Lucio Corsi è cambiato visibilmente in un dettaglio: l’impostazione, la postura (avete inteso, ne siamo certi). Di fronte a cinquanta disperati l’interplay tra Corsi e la banda quasi ci stonava, a noi disperati nei cinquanta, ci rincoglioniva nella nostalgia, la scaletta non era una fissa tabella di marcia ma lasciava spazio a lunghe e interminabili jam che spesso si concludevano con poca precisione ma con immensa bellezza, con tutta quella foga di darsi per il gusto di rimbambire ambo le parti, artista e pubblico, con la distorsione delle Gibson quasi ridondanti tra di loro (ormai marchio di fabbrica del suono di Corsi, riesumato dalla tomba di Marc Bolan e del glam rock anglofono di primi anni ‘70).
Ora il fatto è cambiato, e come poteva non cambiare? Ma si può pure cambiare in meglio. Una cosa che ad esempio mancava al primo Corsi era l’idea di uno spettacolo ragionato, anche scenograficamente, un’idea narrata di concerto e di concept che ci si aspetterebbe da chi si presenta truccato come David Bowie. Non è il caso ora di addolcire la pillola: il concerto di Lucio Corsi a cui abbiamo assistito pochi giorni fa è stato piuttosto deludente. Corsi non pare aver guadagnato in contegno e carattere su grandi palchi ma in rigidità e manierismo, pare aver ben introiettato la regola che impone di non poter dilatare i brani perché sennò la gente si annoia; e allora ecco la trafila della ballata piano voce strazzamutande replicata in varie forme fino alla nausea, il pezzo di Sanremo veloce veloce per cui la gente è venuta al concerto e si ricorda pure qualche parola, due tre camminate in mezzo al pubblico e la si porta a casa. Anche la struttura della scaletta ha alcune evidenti falle: ne citeremo solo una, e cioè la scelta di mettere tutte le ballad lente, e dopo un poco francamente indistinguibili, una dopo l’altra (tra queste emerge Nel cuore della notte, che si sforza di essere un pezzo a struttura iterativa dylaniana, ma risulta semplicemente una nenia retorica di sei minuti).
Ciò che salva il concerto dalla effettiva débâcle sono i pezzi sempreverdi di un cantautore che comunque sa scrivere, quando decide di saperlo fare: La Lepre, Magia Nera, La Bocca della Verità, Freccia Bianca, La Gente che Sogna, sono canzoni capaci di elettrizzare anche se chi te le canta ha l’impressione di starlo facendo con una lieve stizza, con una lieve noia impostata mascherata da umile innocenza. Non a caso sono canzoni che non canta nessuno, perché nessuno nel nostro pubblico le riconosce, e a questo punto è il caso di chiudere con alcune domande: cosa vuole l’artista che scrive canzoni? Vuole tanta gente fredda che ne conosce una sola o poca gente calda che le conosce tutte? Vuole bambini coi cartelloni, coppie borghesi con passeggino, fighetti impomatati con la maglia di Topo Gigio, o vuole un pubblico? Vuole vedersi istituzionalizzato appena in tempo per annoiarsi dopo molti anni di lavoro, o vuole essere Fabrizio De Andrè che, accortosi di star cantando nel “tempio della borghesia” a Viareggio nel 1975, cambia il testo di Marinella in un testo hard pur di godere del grottesco, di registrare la frattura irrisolvibile tra sé e chi lo voleva un monumento?
Prima fu una carezza ed un bacino
poi si passò decisi sul pompino
e sotto la minaccia del rasoio
fosti costretta al biascico e all'ingoio





![Siamo andati al concerto di Kendrick Lamar e Sza allo Stadio Olimpico di Roma, ma com'è stato? Un viaggio iconico tra hip hop e RnB. Saranno i nuovi Jay Z-Rihanna? E sul fumogeno e gli orari di Ticketone... [VIDEO]](https://crm-img.stcrm.it/images/45832676/HOR_STD/600x/lamar-sza.jpg)