Ci ha mollato per terra una damigiana da 1788 pagine, ora Enrico Merlin può mica fare finta di niente e fissare il cielo zufolando indifferente. 1000 dischi per un secolo è l’imponente opera (Il Saggiatore) con cui il musicista/compositore/scrittore offre la sua visione del “suono del Novecento”. La bellezza che passa per l’innovazione pura, talvolta. O una significativa evoluzione, più spesso. “Basta che non mi chiamate ‘critico’ perché non lo sono. Quando un critico è bravo nella musica vede cose, come diceva Ringo Starr, che neppure un musicista vede, ma il mio approccio è diverso”. La prospettiva di Merlin prevede una musica suonata (“Sono appena tornato da un minitour con Max Prandi a supporto del nostro disco blues uscito per Velut Luna. Il “popolo del blues” è un bel problema, sai? Attaccano subito con la tiritera del blues che è la musica delle emozioni. Chi suona altri generi non si emoziona e non emoziona, quindi?”), ma anche una musica pensata, analizzata attraverso le pieghe della Storia. “Ho suonato con Carla Bley, Paolo Fresu, Enrico Rava, John Surman. Dei grandi italiani mi manca solo Stefano Bollani”, ci dice. Per poi aggiungere, spiazzante: “Con la mia versione Tex-Mex di Romagna mia ho ricevuto i commossi complimenti dalla figlia di Secondo Casadei”. Canzone più importante del Novecento? A spinta Tomorrow never knows dei Beatles, azzarda Merlin. Meglio indagare oltre.

Anno 2024, fonti web ovunque, classifiche su ogni pagina e profilo social, video-tutorial che intasano YouTube. Cosa ti ha spinto a pensare che ancora oggi fosse necessario un tomo cartaceo sulla musica del Novecento?
Dunque, io sono un tipo molto social e devi sapere che in alcuni gruppi sono quasi considerato un oracolo (ride, nda). C’è come una brigata di individui che mi segue con dedizione totale. Allo stesso tempo mi ritrovo spesso alle calcagna un manipolo di hater che non mancano occasione di sfracellarmi i coglioni. Fanno i tifosi da curva sud. In un gruppo, di recente, un tizio di questi ha fatto proprio una considerazione simile, ma con piglio ben più polemico e prevenuto. “Sono libri che invecchiano presto, questi”, ha commentato.
E tu?
Chiariamoci, sono il discografo ufficiale della famiglia di Miles Davis, ho accesso a tutti gli archivi e alle registrazioni inedite della Columbia. E pur essendo un soggetto non competitivo, mi tiro addosso l’invidia di vari esimi professoroni. Ce ne fossero un milione di libri come il mio! Più opinioni, più cultura. Mi fa piacere vendere copie, ma il piacere è riuscire a mantenere i miei cinque figli, mica vedermi alto in classifica. Per me ha senso scrivere un libro simile perché amo il supporto fisico. E adoro gli stimoli multisensoriali che mi può dare un disco in vinile. Ho voluto, semplicemente, scrivere di musica, attività per la quale serve tutto: l’udito fine, l’analisi, la logica, gli occhi ben aperti.
Quanto è personale la tua interpretazione del Novecento in musica?
Non ho messo insieme i miei dischi preferiti, i dischi più famosi o quelli più importanti e apprezzati dalla critica. Ho cercato di allineare i mille dischi che raccontano “la storia del suono del Novecento in Occidente”. C’entra nulla “i dischi più belli” o amenità simili. Intatti Il Saggiatore lo considera una sorta di “reference book”.
Torniamo a Davis. Quando uscì “Bitches brew” (1970) – disco monumentale – tre quarti dei jazzofili lo stroncarono. Non è che il jazz avrebbe goduto di miglior sorte senza i jazzofili?
Il jazz è frequentato da molta gente che ama stilosamente tirarsela mentre sorseggia un whiskey, sai? John Cage, più estremo ancora, diceva: “Se i musicisti si levassero di mezzo, la musica avrebbe solo da guadagnarne”. Il problema è sempre l’ortodossia impomatata. Ogni volta che con certa gente esci dal seminato, è come se bestemmiassi. Lo vogliamo capire che il risultato estetico dell’arte non ha necessariamente a che fare con la preparazione puramente tecnica? Gli atti creativi veri spesso sfuggono all’idea che “la difficoltà esecutiva giustifichi la grandezza di ciò che ascoltiamo o vediamo”.
A cosa serve la tecnica, quindi?
A fare uscire con più facilità il messaggio, amplificarlo. Serve ad aggirare le barriere, a comunicare meglio. Ma molti non lo comprendono. E infatti tanti appassionati non sanno davvero dirti perché John Coltrane sia un genio. Ma va bene così, in fondo. L’arte puoi apprezzarla anche senza capirla da un punto di vista tecnico. Il problema è che non siamo ancora riusciti a cogliere l’occasione che ci può offrire l’incontro con una spiazzante asperità. Immediatamente pensiamo: “Questo si è rincoglionito”. Può essere, ma spesso siamo noi che non siamo abituati a metterci in discussione. Il compito dell’artista è portarci “fuori” dal piano della realtà, non di riprodurre ciò che c’è già.
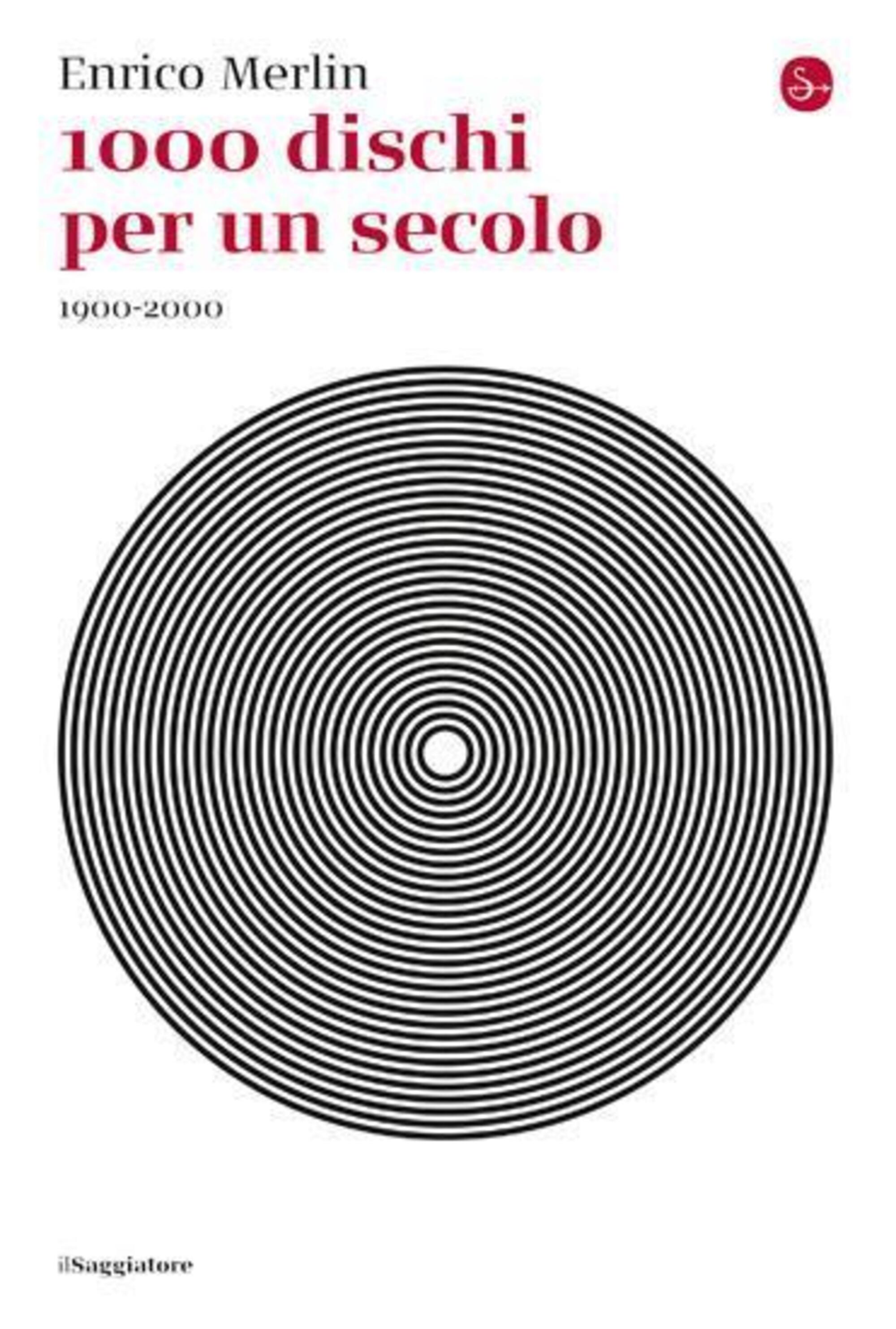
Al di là dell’imponenza, il tuo libro di certo non si nasconde. Suono, storia, innovazione, evoluzione: sono questi gli elementi in gioco. Veniamo da settimane in cui una certa nostalgia dotta ci ha ripetuto quanto fossero grandi Enzo Jannacci e Giorgio Gaber. Che tu, al pari di altri italiani, non hai incluso.
È una cosa voluta. Volevo raccontare le pietre miliari dell’innovazione musicale. Io sono molto affezionato a Enzo Jannacci e conosco bene suo figlio Paolo. Anche perché quando sono nato Jannacci era di turno a La Mangiagalli. Era lui a premere sul pancione di mia madre per farmi venire al mondo. Non ho preclusioni di alcun tipo verso di lui: è un genio, in Italia è stato fondamentale, ma a livello internazionale non ha inventato nulla. Ancora meno Gaber. O Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Fabrizio De Andrè (tranne Crêuza de mä, in cui infatti c’era di mezzo Mauro Pagani, che con quel disco ha concepito un “suono del Mediterraneo”), tutti figli di Woody Guthrie, Bob Dylan, Jacques Brel, George Brassens, che nel libro ci sono. Area, Perigeo e Napoli Centrale, invece, hanno fatto una musica che prima non c’era. E poi attenzione, eh! Io mi occupo del “suono” del Novecento. Motivo per cui Wish you were here (1975) dei Pink Floyd è superfluo, nella mia selezione, rispetto a The dark side of the moon (1973).
E se spostassi in avanti le lancette del tuo testo di 23 anni, avresti particolari problemi a selezionare la musica di oggi?
Lo storico deve aspettare un po’ a pronunciarsi. Deve prendersi le sue necessarie distanze temporali, è il critico che scrive in diretta. Detto questo, da musicista, ti dico che la scena attuale è fantastica. C’è molta musica interessante, in giro; più oggi che dieci/quindici anni fa. E aggiungo: se mi occupassi dei primi 23 anni di questo nuovo secolo potrei mai ignorare la trap?
Una frase dinamitarda se gettata scriteriatamente nella Rete.
Troppe cariatidi in giro. Portano il rock nelle università, fanno le masterclass sul pop. Cercano di “istituzionalizzare” la popular music, farla normare dai ministeri. Tu te lo immagini Kurt Cobain che studia composizione per fare pop? L’avrebbe mai scritta Smells like teen spirit? Lo so, suona provocatorio dire che oggi c’è molta musica bella in giro. Ma il mio compito è fare mediazione culturale, devo solo stimolare la curiosità, la conoscenza viene dopo. Noi occidentali spostiamo sempre tutto sull’insegnamento, anziché puntare sulla educazione.
Così poi troppa gente, anche in età matura, cerca di leggere il libro che, per l’ennesima volta, gli dà ragione. Per il tuo testo, invece, serve una violenta curiosità.
Il mio libro è una selva di rimandi e rimbalzi. Parti dai Beatles, così tocchi Stockhausen, quindi Schoenberg, Mahler e così via. Di passaggio in passaggio tutto o quasi si connette. Guardando indietro o avanti, a seconda. Tutto evolve. Quando una struttura si chiude su sé stessa urlando alla purezza, inevitabilmente, nel giro di poco tempo, collassa. Quante volte l’abbiamo dato per morto il rock? E il jazz? Poi emerge qualcosa che scompagina tutto e si riparte in nuove direzioni. Oggi qualcuno potrebbe dire che Louis Armstrong non sia jazz? Sarebbe un folle, ma nel 1926 Armstrong non era considerato jazz.
Sarà mica, alla fin fine, una questione di “bellezza”?
Sì, bellezza intesa come equilibrio fra forme e strutture (anche un “non equilibrio” alla Metal machine music di Lou Reed, a suo modo, è una questione di equilibrio perché comunque rimette in discussione tutti i parametri). Il punto è che bellezza e gradevolezza non vanno confuse. Bellezza non è qualcosa che necessariamente ti rasserena per dieci minuti. Semmai è qualcosa che ti sfida, che ti muove dentro. L’arte deve muoverti, dare emozioni. Uno definisce “meraviglioso” un film che fa piangere, non è strano? Eppure, è così. Bellezza è suscitare qualcosa: pensieri, progetti, emozioni. Disgusto? Tensione? Ben vengano. La bellezza non ha nulla a che vedere con la comfort zone. Lo scopo dell’arte, soprattutto dall’informale in avanti, ha lo scopo di suscitare in noi qualcosa (anche di imprevisto). Prendi le sculture sonore di Petr Válek. Sconvolgenti. Usa anche la AI? E chissenefrega”.
Ti piace provocare, eh?
Sì. E ti dico che Roots dei Sepultura (1996) è la più grande opera di etnomusicologia del Novecento. E infatti ai metallari duri e puri non piace. Quel disco dimostra che le radici del thrash metal brasiliani risiedono nella musica degli Indios dell’Amazzonia.













