La prima volta che incontrai Paolo Colagrande restai folgorato dalla sua illuminata prudenza. “Mi piace iniziare una frase con “credo”, utilizzare qualche “forse”. I miei personaggi, per dire, non hanno tutte ‘ste grandi certezze nella vita”, mi disse. Da “Fìdeg” (l’esordio per Alet che gli valse il Campiello) sono trascorsi ormai sedici anni, ma al tavolo del bar dove ci incontriamo trovo di nuovo l’acuto conversatore di allora. Nonostante una carriera che parla da sé e un ultimo romanzo, “Salvarsi a vanvera”, uscito per Einaudi, che ha raccolto consensi e premi (premio “Emilio Lussu”, “Monte Carmignano per l’Europa”, “Alassio Centolibri-Un autore per l’Europa”), a Colagrande piacciono ancora le formule dubitative. Verrebbe da pensare che uno scrittore con una voce letteraria così riconoscibile sia una figura tetragona che non inciampa mai. E invece “gli esseri umani si rivelano negli inciampi”, mi dice. Inciampi veri, intende, mica metaforici. Se si fosse messo a parlare per metafore non sarebbe più il Colagrande che mi fece scoprire Ermanno Cavazzoni, che ha sempre speso parole d’ammirazione per Luigi Malerba, che mi mostrò il “Candido” di Voltaire (“torno ancora qui, ogni tanto”) con l’entusiasmo di chi l’aveva scoperto il giorno prima e finito in una sola notte.
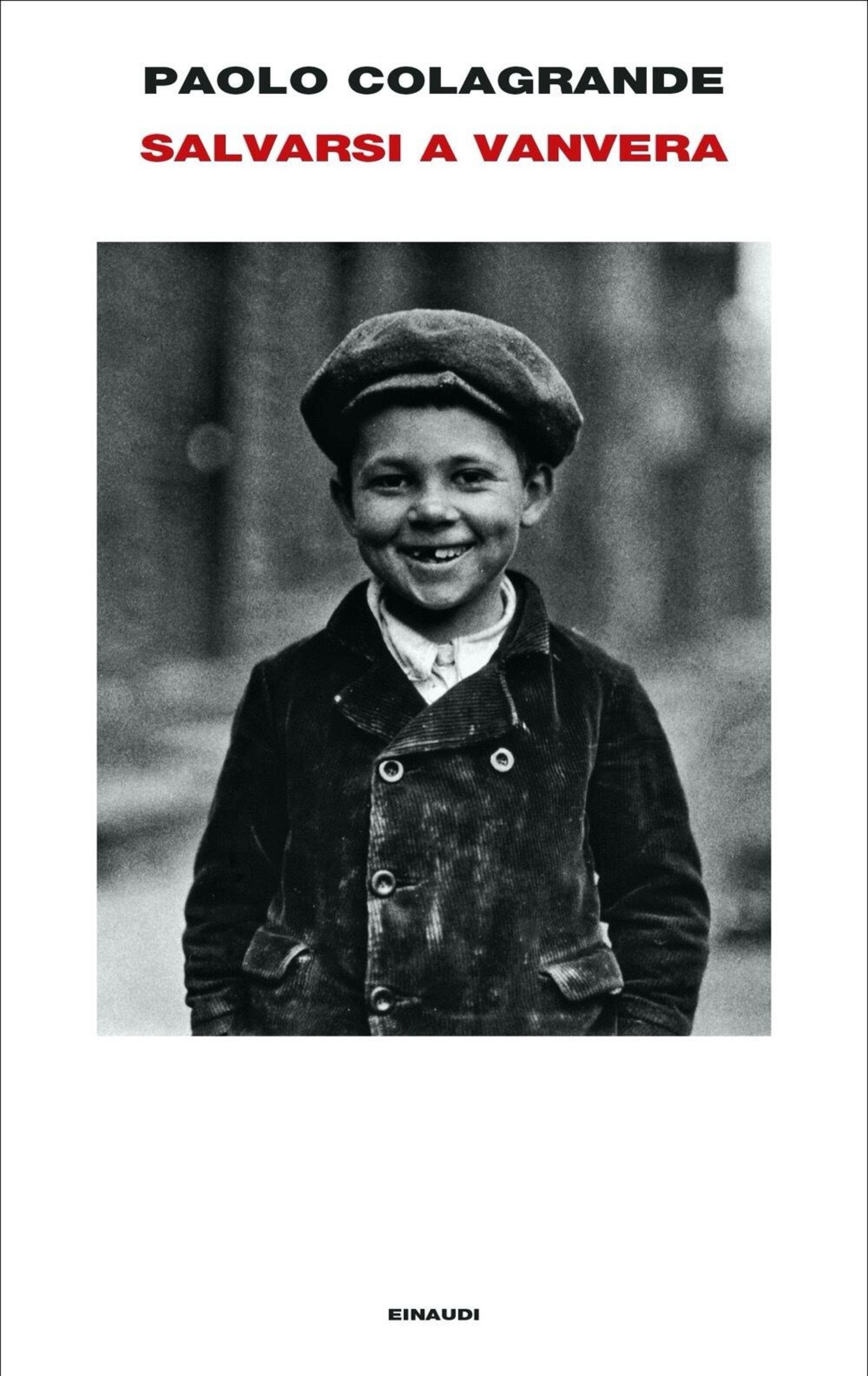
Possiamo ritenere “Salvarsi a vanvera” l’ultima tappa di un percorso o un episodio a sé?
È un problema che non mi pongo, anche perché ogni tanto rileggo miei pezzi vecchi e mi dico: “Mica male, dai”. Ogni libro è un ricominciare da capo. Questo è un po’ diverso dagli altri, ha una sua precisa collocazione nel tempo e contiene un germe autobiografico. La critica lo ha qualificato come “romanzo storico”.
Ingenuamente pensavo che potesse definirsi “storico” ogni romanzo che non contenesse troppa fiction.
Anch’io. Ma il concetto si può estendere a vicende umane situate all’interno di una cornice storica, senza che i protagonisti dell’epoca siano menzionati. Non è neppure nominato Mussolini, ma la storia – in parte vera – è condizionata dalla guerra, dalla propaganda, dalle leggi razziali.
Parlavi di un germe autobiografico…
Sì, da parte di mia mamma. I miei nonni materni erano del 1890. Mio nonno paterno, abruzzese, addirittura del 1875, si chiamava Vittorio Emanuele Secondo Colagrande. Quando una volta mio figlio, a scuola, disse che suo bisnonno Federico era stato telegrafista nella prima guerra mondiale e aveva annunciato al re, da Villa Giusti, la capitolazione dell’Austria-Ungheria, tutto vero, la maestra si preoccupò: “Suo figlio – mi disse - forse lavora troppo di fantasia”.
La fantasia è nel Dna della vostra famiglia, ma in “Salvarsi a vanvera” c’è anche molta verità.
Sì, è vero. Io, solo grazie alla mia famiglia, tocco tre secoli. I miei figli sono nati nel millennio corrente. Mia nonna mi parlava di come viveva nell’800, mia madre mi racconta la guerra come realtà di ogni giorno. Noi pensiamo alla guerra come morte e distruzione – ed è così –, ma chi la vive cerca di salvare un quotidiano, un apparato di abitudini. Le scuole, all’epoca della guerra, continuavano più o meno a funzionare. La notte che venne bombardata piazza Duomo (Colagrande è di Piacenza, nda), la casa dei nonni restò in piedi. La mattina seguente mia mamma esce di casa e, in un panorama devastato, ritrova la compagna di classe con cui va a scuola ogni mattina. E, come ogni mattina, insieme raggiungono il liceo ed entrano in classe, dove si fa regolarmente lezione, col cappotto perché non c’è riscaldamento. Dentro la Storia con la S maiuscola si muovono le storie della gente che la subisce, non di chi la fa. E chi subisce la Storia prova in ogni modo a salvarsi, anche a vanvera. Manzoni ce l’ha insegnato.
Dicevi infatti che non nomini il Duce.
Non parlo né dell’Italia come nazione, né di Badoglio né di Hitler. E Mussolini è, sarcasticamente, “il grande condottiero del governo repubblicano” (siamo in piena repubblica di Salò, che comunque non viene nominata). Sono presenze sullo sfondo.

È anche questo che ti ha permesso di scrivere un testo divertente su un tema così delicato? Ma più in generale, come ti sei “armato” per scrivere un libro simile?
Parto dal presupposto che gli uomini siano pessimi attori tragici. Anche la tragedia ci rende involontariamente ridicoli. Credo che la tragedia pura sia finita letterariamente con la Grecia antica dei miti e degli dèi. Perso il mito, abbiamo perso il senso letterario della tragedia. Oggi, spesso, la tragedia è un simulacro di tragedia. La nostra natura, organicamente comica, è anche l’unica che ci descrive appropriatamente perché in quella visuale c’è la rassegnazione ad una condizione precaria. Penso alla comicità del witz ebraico, a Woody Allen. Se parti da lì riesci a vedere le cose da una certa distanza e sorridere. Pensa quanto comica sia l’autorità, quanto lo possano essere le divise. Pensa all’autorità intransigente dei regimi. Mia madre mi racconta che un giorno i tedeschi confiscarono il camion del nonno. “Cosa sta succedendo, papà?”, gli chiede, e lui le risponde facendo il verso all’ufficiale tedesco che parla un italiano da “Sturmtruppen”: “Camion rekvisito!”. La parodia è una fedele lente di ingrandimento della realtà. Che è confusa, sgangherata, asimmetrica. C’è poi una soglia invalicabile, che va oltre la commedia umana e ogni possibile dimensione tragica. Il mio racconto si ferma lì, prima di quei cancelli...
Dev’essere difficile fare un lavoro di editing su un tuo romanzo.
Più che l’editing, la correzione di bozze. Perché certi refusi entrano nel testo senza controllo, anche dopo l’ultima revisione. Nella prima edizione di “Salvarsi a vanvera” trovo un pezzetto avulso dal testo, attaccato a una frase per uno “scatto del mouse”, così mi hanno detto in casa editrice. Sufficiente ad annientare il senso di pagina e a togliermi il sonno per mesi. La sto facendo un po’ tragica, lo so.
Sei stato all’ultimo Salone del libro?
Sì, claustrofobico. Troppa gente, forse.
Cosa ne pensi della contestazione alla ministra Roccella?
I ministri non dovrebbero essere invitati a presentare i loro libri in una manifestazione letteraria. Hanno già una loro platea, tutti i giorni. Se non ti piacciono le contestazioni devi lasciarli a casa. Se li inviti le contestazioni sono inevitabili.
Solo narratori puri alle fiere, quindi? Niente chef o sportivi?
Ma no, quelli fanno parte del costume. La politica è per forza divisiva e i libri scritti dai politici sono autopromozione per raccogliere consensi. Lo sportivo è fuori da questi giochi strumentali, e il suo libro, scritto da un ghostwriter, vende un sacco di copie e fa felice l’editore. Lo sport, soprattutto il calcio, infiamma tutti quanti, critici letterari compresi.
I critici?
I critici sono tifosi pazzeschi. Accende sempre un dibattito, lo sport. Ma senza voti di mezzo.

Enrico Dal Buono (uscito lo scorso anno con “Ali”), intervistato dal nostro direttore, ha recentemente affermato che l’autofiction è la sconfitta della letteratura. Il vero scrittore dovrebbe creare mondi.
La letteratura credo debba avere una visuale ampia. E contemporaneamente modesta. Difficile essere modesti quando si mette in scena se stessi. Il tuo quotidiano può essere l’occasione, o il pretesto, proprio per portarti fuori dal tuo stretto orizzonte, e se anche parli in prima persona non è proprio la tua vita a mettersi in scena. Quasi tutto quello che scrivi, forse, è indirettamente autobiografico. Ma c’è un modo di sottrarsi all’insistenza del primo piano.
Quale?
Non dare riferimenti. Non utilizzare luoghi geografici, personaggi reali. Sono cornici altamente condizionanti che comprimono un contesto. Se parli, poniamo, di Palermo, tanti possono avere un’idea della città e la trama si interconnette inevitabilmente con quell’idea, magari tratteggiata attraverso poche caratteristiche salienti, creando una forzatura. Chi ci vive, poi, potrebbe addirittura non ritrovarsi.
C’è qualcuno fa buona autofiction?
Vitaliano Trevisan ha fatto buona autofiction perché il lettore, leggendolo, non vede la fusione tra autore e voce narrante.
Sei ancora del parere che il lettore debba faticare un po’ per seguire l’autore?
Certo. Da lettore non trovo gratificazioni se non ci lavoro un po’ su. Ma il mercato ha esigenze diverse, più pratiche: servono soprattutto libri con meccanismi narrativi collaudati, oppure consumabili in un’ora di treno.
Quanto fai dannare i tuoi editor?
Poco. Da parte mia garantisco un autoediting molto forte. Però il mio esordio in questo settore è stato memorabile: la editor tentò, con le migliori intenzioni, di normalizzare “Fìdeg”. Un’impresa impossibile, oltre che inutile: avrebbe impiegato mesi e mesi a snaturare un’idea di linguaggio – una lingua un po’ balenga – che era la sola compatibile con la voce del protagonista-narratore. Se ne è accorta dopo una decina di pagine, e ci abbiamo riso sopra. Con Bisi (il protagonista del romanzo, nda) “normalizzato” non avrei avuto nulla da condividere, non ci avrei mai preso un caffè al bar, per dire. In genere, però, a parte questo episodio, bisogna saper negoziare, mediare.
Di cosa hanno paura gli editor?
Gli editor sono in una posizione delicata, critica: magari condividono la cifra dello scrittore ma devono anche assecondare un’idea da lettore “medio”, direi normodotato.
Prima di iniziare a scrivere forse non avevi preventivato queste cose…
Ma non le preventivo neanche adesso, in realtà, perché non faccio tesoro delle esperienze. Coazione a ripetere, in psichiatria (ride, nda).
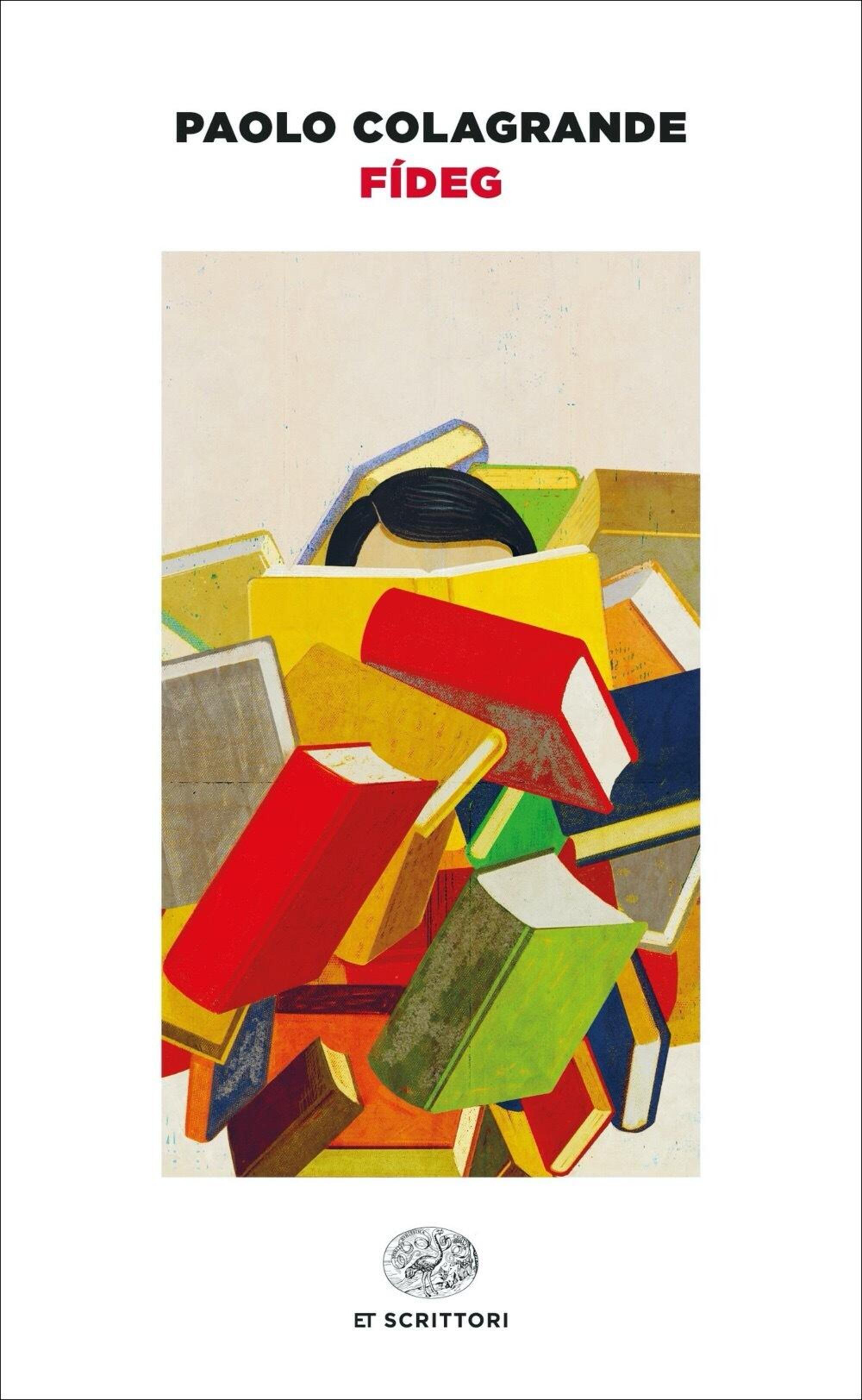
Toglimi una curiosità: cosa pensa uno scrittore così libero come te, così poco schiavo delle convenzioni, della cosiddetta cancel culture? Alcuni, forse i più cinici, ci ricordano che i libri sgraditi esistono da quando esiste la carta stampata. Altri vedono in questa deriva censoria un pericolo nuovo, anche per il modo con cui si esprime intolleranza verso qualcosa che non è in sintonia con il sentire contemporaneo. Come la vedi?
Mi pare una tendenza in declino, non perché siamo più autorevoli, anzi proprio perché non lo siamo. E soprattutto perché molti scrittori tendono ad autolimitarsi, omologandosi ai gusti, ai temi e ai modelli correnti. Il rischio, oggi, è un altro: dimenticare autori importanti perché ritenuti inadatti a un investimento. Penso a Giuseppe Berto, autore capace di raccontare le ferite della nostra vita e della nostra società in modo straordinario. E penso anche a Roman Gary, che dagli anni ’70 non era più stato tradotto in Italia. Entrambi sono stati ora ripubblicati da Neri Pozza. Sono solo esempi. Cito anche un testo geniale di Luigi Malerba – “Che vergogna scrivere”, mai ristampato – che mette in parodia scrittori, critici, lettori, editori, proponendo situazioni tipo, come ad esempio due lettori un po’ sofisticati che disputano e si accapigliano su un libro che, in realtà, nessuno dei due ha letto.
E oggi si leggono ancora i libri?
Diciamo che ancora si comprano, ma i non-lettori sono una maggioranza schiacciante. In generale il libro è un regalo prêt-à-porter. Ed esiste anche un tipo di libro che “si regala bene”, almeno così mi ha detto una volta un editore, nel senso che chi lo compra pensa che sia interessante – per titolo, copertina – e chi lo riceve pure. Ma alla fine quel libro non lo legge né chi lo regala né chi lo riceve. Resta lì. E poi, tornando alla cancellazione: oggi il potere si preoccupa davvero della letteratura al punto da volerla zittire? Non credo. Un Pasolini, oggi, non raccoglierebbe grande interesse, perché va letto. E la lettura sembra pubblicamente iscritta fra i mestieri logoranti, da alleggerire con dispositivi comodi, facilitati, ergonomici. Il saggio “Caccia allo Strega” di Gianluigi Simonetti, da poco uscito, descrive molto bene questa deriva, attraverso l’analisi di un premio ultramediatico. Lo Strega, in tempi passati, premiava e proteggeva il talento, infatti l’assegno per il vincitore era altissimo – nel 1950 un milione di lire – per dare modo allo scrittore di continuare scrivere senza doversi svendere. Ora è il premio stesso ad essere motore di vendita e, inevitabilmente, a diventare preda e strumento di un mercato. Sto citando liberamente, e con molta approssimazione, Simonetti.
Torniamo a Pasolini. In questo considerare (e valorizzare) poco, oggi, un certo tipo di letteratura, c’è anche una colpa degli intellettuali e dei letterati, alle prese magari con l’autofiction – o, nel migliore dei casi, con il tentativo di “creare mondi” – e non con temi, anche dolorosi, più quotidiani e urgenti?
Può essere. Ma credo ci sia molta confusione. Considera che in un passato prossimo le recensioni le facevano critici di professione. Oggi a recensire sono più spesso gli scrittori o i giornalisti che contribuiscono al dibattito con un loro particolare gusto, e a volte con un narcisismo autoriale che mette in ombra il libro recensito. Molti scrittori sono anche editor e viceversa. I ruoli sono crollati. Tutto si sovrappone, si fonde, si interseca. I critici “di razza”, i letterati del mondo universitario restano spesso voci lontane, ai margini di un dibattito “da copertina” dove prevalgono le firme.
Prevalgono quindi i Lester Bangs nella critica letteraria.
Più o meno. Perché finisci per ricordarti la firma, appunto. Manca poi quello spirito di condivisione che, magari in modo un po’ improvvisato e garibaldino, univa fiduciariamente lo scrittore al mondo del libro finito e pubblicato. L’editore teneva sotto contratto l’autore e gli diceva: “Vai, scrivi, fai la tua parte”. Oggi l’editore deve sopravvivere, e lo scrittore deve saper “leggere” il mercato, improvvisarsi performer multitasking, frequentare campi non suoi, identificarsi. Sei simpatico? Va bene. Sei antipatico? Va bene lo stesso, il mercato investirà anche sulla maschera dell’antipatia, per darti un ruolo, crearti un outfit. Prima ancora del libro deve esserci la creatura visibile, mediatica, iconografica: lo “Scrittore”. Che un tempo scriveva e basta.













