Una storia di provincia, ma non come tante. Nella mattinata dell’11 gennaio 2022, nei pressi di Calendasco, un piccolo paese in provincia di Piacenza, viene trovata nel fiume Trebbia un’auto capottata. All’interno i corpi senza vita di quattro ragazzi: Domenico Di Canio (22 anni, Borgonovo), William Pagani (23 anni, Castelsangiovanni), Elisa Bricchi (20 anni, Calendasco), Costantino Merli (23 anni, Guardamiglio, Lodi). Una notte di nebbia fitta fagocita quattro esistenze ancora tutte da scrivere. Da quella notte prende anche il via l’indagine di Valerio Millefoglie – musicista, scrittore, giornalista –, un’inchiesta coraggiosa alla ricerca della vita nella tragedia. Il titolo del volume di Millefoglie si intitola infatti “Tutti vivi” (Strade Blu Mondadori). Per sottolineare che quell’inchiesta è stato l’elaborato tentativo di raccontare i quattro ragazzi attraverso le loro passioni e pulsioni vitali. Vietate le cartoline sbiadite, solo immagini vivide ed evocative, recuperate grazie alla collaborazione delle famiglie. Fra gli scritti, gli appunti, i suoni e le battute, la musica trap, grande co-protagonista del libro di Millefoglie. Domenico e Costantino scrivevano e cantavano con il nome de Il Dome e Milions, mentre William detto Wollas era il produttore musicale. Elisa e Costantino si erano conosciuti all’Unieuro, dove entrambi lavoravano, e si frequentavano da qualche mese. La sera della tragedia avevano festeggiato i 23 anni di William. “Tutti vivi” è colmo di rime e beats, di tracce recuperate, ascoltate e poi pubblicate. “Tutti vivi” è memoria vera.

Perché questa storia ti ha così incuriosito?
Per due motivi: i genitori, in questa vicenda, diventano archivisti dei propri figli e, attraverso le canzoni di questi, li scoprono e li riscoprono. A volte la troppa vicinanza non ci permette di comprendere appieno alcune cose, anche importanti. Penso a Francesco, il padre di Costantino. Una delle prime cose che mi ha detto è che attraverso le canzoni stava conoscendo meglio suo figlio. La musica, quando i ragazzi erano vivi, era anche una barriera, perché la trap è spesso indigesta agli adulti. Dopo è cambiato tutto, quei brani sono diventati una chiave di lettura. Io credo molto nell’importanza dei documenti e nei vent’anni di quei ragazzi ho rivisto i miei vent’anni, visto che anch’io iniziai scrivendo testi hip hop.
Sono state particolarmente rivelatorie queste canzoni per i genitori?
Direi di sì. E aggiungo, loro non facevano solo trap, ma anche rap. Ci sono un paio di pezzi rap di Milions (Costantino) – quasi old school anni novanta, con testi molto letterari –che sono fortemente autobiografici. Fino ai nove anni aveva vissuto in un orfanotrofio a Kiev, in quei brani (vedi “Figli di nessuno”) ci sono i suoi ricordi d’infanzia, ricordi che faticava a comprendere. A capire se fossero stati sogni o fatti realmente accaduti. In “A te”, che Costantino ha dedicato ad Elisa, c’è quasi una visione profetica delle notti lungo il fiume.
Perché la trap, da qualche anno, è il veicolo preferenziale per esprimere il proprio disagio?
Perché è una musica democratica. Non servono chitarre o pianoforti. Non serve affittare una sala prove. È un linguaggio immediato, per nulla finto. Ideale per raccontarsi. Il pop è più generico, talvolta persino astratto. La trap crea un’immedesimazione che accorcia le distanze. Meno sentimenti, più fatti, più eventi. E se il sentimento c’è, questo è figlio della vita reale.
Brani che aggiornano un diario di bordo in divenire, ma perché per la Gen Z è diventato così doloroso questo diario di bordo?
Beh, forse per colpa nostra, della generazione precedente. Loro narrano il mondo che si sono trovati in mano, e glielo abbiamo preparato noi. Qualsiasi adolescenza, in realtà, ha in sé qualcosa di doloroso, ma questo mondo di certo non l’hanno costruito loro.
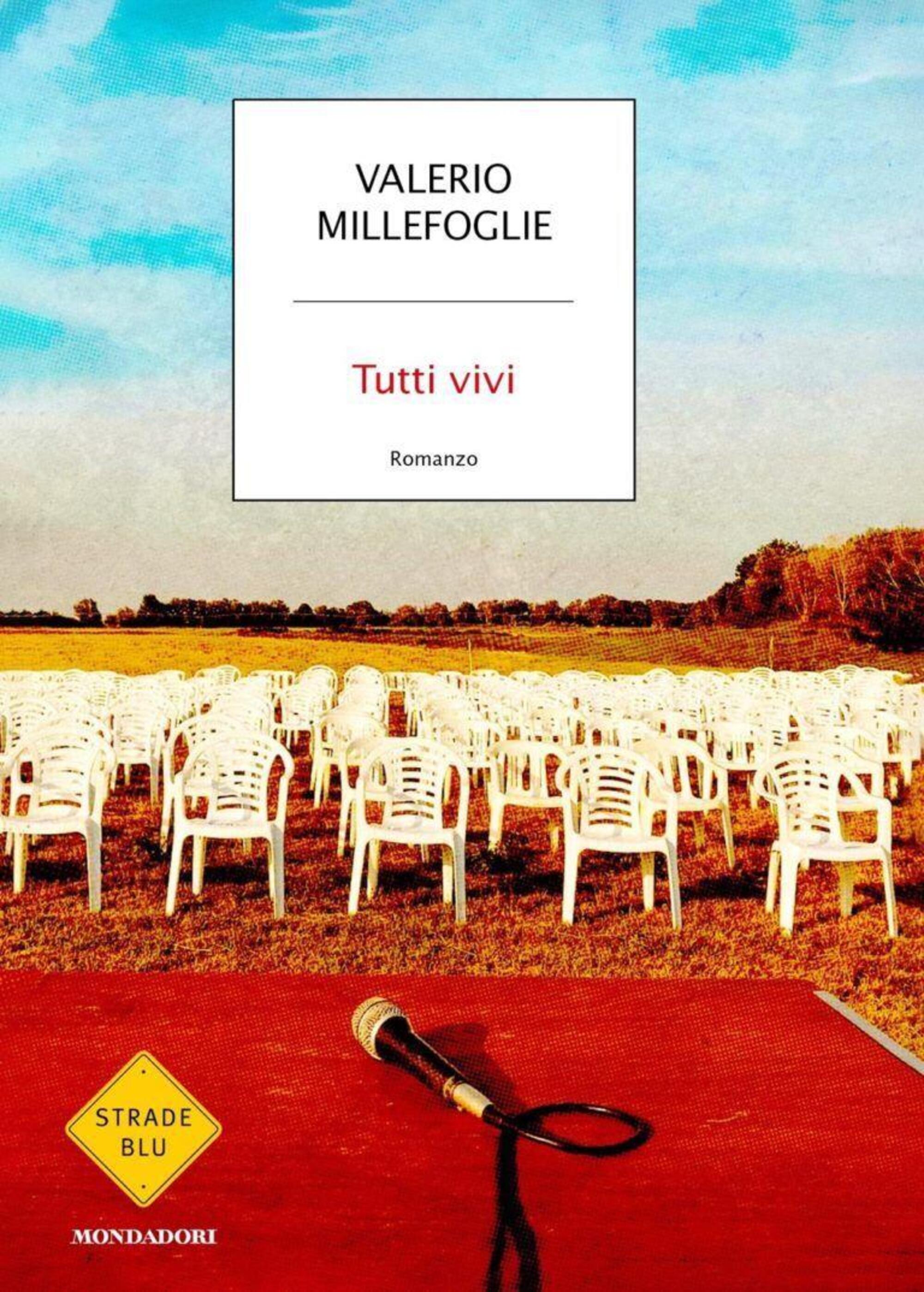
Lo chiedevo perché, essendo la trap popolare, viene difficile comprendere come una generazione giovane abbia eletto a proprio emblema un genere così cupo.
Mi viene in mente, fra le tante interviste che ho fatto per “Il venerdì” de “La Repubblica”, quella che feci a Massimo Pericolo, che cinque anni fa esordì con “7 miliardi”, una produzione molto industrial e distorta. Nel video si vedeva la carta stagnola, era tutto molto violento. Ecco, l’ultimo verso di quel brano dice: “Voglio solo una vita decente”. Massimo Pericolo mi disse di aver scoperto la letteratura in carcere, grazie al bibliotecario. I primi testi li scrisse senza neppure appoggiarsi sulle basi, mosso dall’urgenza di raccontare tutto ciò che aveva dentro. Il suo ultimo disco si intitola “Le cose cambiano”, come a farci capire che tutta quella rabbia derivava da ciò che non aveva. E che la letteratura gli è servita per ribaltare tutto. Poi, tornando alla domanda, va anche detto che i ragazzi imitano molto. Chi sta bene imita il disagio di chi non sta bene.
La sensazione è che tanti ci giochino un po’ sulla tragicità della propria biografia.
Tutti quelli che ho intervistato per “Il venerdì” mi sono sempre sembrati genuini. Realmente motivati, decisi a coltivare un talento.
Tuttavia la trap è sempre accerchiata dalle polemiche. Tipo quella della scorsa estate sull’autotune.
C’è un libro, “Autotune theory” di Kit Mackintosh (Nero), che parla proprio di come l’autotune, dando alla voce quel suono etereo e disperato, sia diventato funzionale a una forma nuova di narrazione. Ma rap e trap, in genere, non sono il territorio del bel canto e dell’intonazione. L’autotune dà un suono. Non mi fa impazzire quando è troppo massimizzato, ma la polemica del bel canto, in quel contesto, fu assolutamente fuori luogo. Qui ciò che conta è il testo, la grana della voce, la personalità di chi calca il palco.
L’hip hop che anche tu hai vissuto rimandava spesso a musiche precedenti grazie al largo uso di campionamenti. La trap, invece, suona sempre molto autoreferenziale, non propone slanci verso la musica del passato. Sembra valere solo “per sé”.
Beh, mi hanno stupito, in questo senso, gli ultimi dischi di Sfera Ebbasta e Ghali, in cui c’è una forte tendenza all’autocitazione. Citano i loro esordi, come se quel 2016 fosse un’epoca già storicizzata. Qui il guardare alle spalle è sempre in termini autobiografici. Io quando scrivo sono senza dubbio più vicino alla cultura del sample. Mi piace andare a spulciare gli archivi. Mi piace indagare il suono delle parole, campionare estratti da documenti. Quando scrivo dell’annegamento dei quattro ragazzi scomodo l’annegamento della figlia di Victor Hugo. Innesto una vicenda risalente a fine ottocento in un fatto di cronaca del 2022.

La trap è la musica più autobiografica che abbiamo conosciuto finora?
Sì, è la musica dell’autoritratto. Una caratteristica comunque già presente nel rap.
Torniamo da dove siamo partiti, dal fatto di cronaca. L’auto si capottò in acqua e il giorno dopo, una volta recuperata, venne fatto notare che il portellone posteriore era aperto. Nessuno, però, riuscì ad uscire dal veicolo. Hai assistito, durante le tue indagini, a una ricostruzione dinamica dell’evento?
Quando sono arrivato lungo la riva del fiume, qualche settimana dopo, c’erano ancora le impronte delle ruote sulla strada sterrata. Quando ai genitori viene riconsegnata l’auto, la madre di Antonella si siede esattamente dove era seduta la figlia, come per cercare qualche traccia, le impronte delle unghie per provare a divincolarsi. Invece l’auto è perfetta, nessun segno.
Anche il meteo di quei giorni fu una beffa. Mai una nebbia così fitta, in zona, nei giorni seguenti.
Sì, fu un incidente “non incidente”. Quando si parla di incidenti si pensa sempre a una collisione, alla manovra sbagliata di qualcuno che va a sbattere contro un palo, un albero o un’altra auto. Qui abbiamo a che fare con qualcosa di quasi paranormale, come se quell’auto fosse stata inghiottita dalle nebbie. L’acqua era alta un metro e mezzo, un’altezza che non suggerisce l’idea dell’impatto. Fu l’ultima notte di una nebbia così fitta; il giorno del funerale, il 21 gennaio 2022, splendeva un sole meraviglioso.












