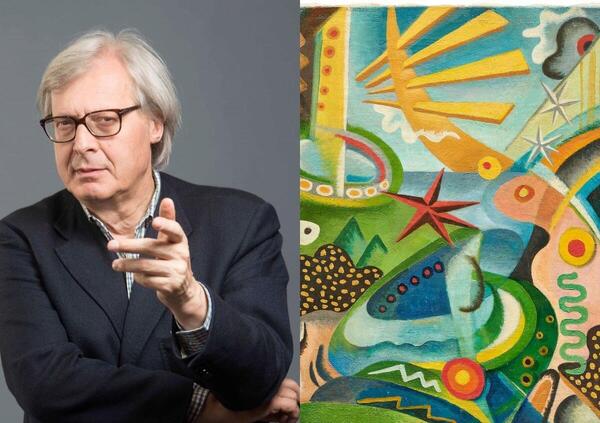Come va lì? Perchè non fai un pezzo su “essere marchigiano”? E’ andata più o meno così nella solita riunione di redazione e all’inizio m’è venuto quasi di rispondere che non ne avevo voglia. Ogni volta a raccontare robe brutte, dopo averlo fatto per una vita. Proprio adesso che, finalmente, posso raccontare solo di moto e uomini veloci. Poi, però, quel “no” non l’ho detto e mi ci sono messo a pensare, perché è vero che qua, nell’unica regione al plurale, capita di tutto, ma è vero pure che appena apri la finestra te ne scordi. Non è questione di paesaggi, di clima o di robe così. E’ questione di sensi e di destino. Di sangue che corre e cuore da non ascoltare. Di dialetti strani e di fare a capirsi. Perché essere marchigiano è qualcosa di tremendamente simile alla velocità: hai paura ma non vorresti fare altro. Sai che un po’ meno sarebbe meglio, ma in verità ne vuoi di più. Mentre dentro una vocina ti dice che tanto gli altri sono più veloci e prima o poi ti sorpasseranno.
Plurali e contrarie, le Marche. E ogni tanto pure contrariate. Questa volta da quello che è successo nell’Anconetano e nel Pesarese, che va a finire insieme a quello che invece era successo nel Maceratese e nell’Ascolano nel 2016 e pure a un po’ di storiacce di cronaca più o meno recenti (rigorosamente narrate in funzione del politicamente corretto piuttosto che raccontate) e che, vuoi o non vuoi, hanno reso il vivere nelle Marche sinonimo di sport estremo. Come se la residenza qui meritasse una sponsorizzazione della RedBull, per quelle attività che suonano un po’ da suonati. Per carità, non è il momento delle battute, mentre una donna di 56 anni e un bambino di 8, otto anni, sono ancora dispersi. Ma tirare su le spalle è un modo quasi per onorare: è essere marchigiano. E’ provare a ridere anche quando c’è solo da piangere. E’ abitudine alla sorpresa e consapevolezza che la sorpresa spesso ferisce più che sorprendere. Roba da gente che tanto s’è abituata a vivere di differenze, di difficoltà, di “non ci lasceranno soli” (ma se fate da soli è meglio). Che non sono solo nei disastri, ma in ogni giorno. Pure un po’ circondati da quelli più bravi: l’Abruzzo “che è il futuro”, la Romagna che “loro sì che sanno fare turismo”, l’Umbria che “ammappate quanto ci tengono al territorio”, la Toscana che “parlano bene e so’ pure simpatici” e il Lazio che “va be’ loro c’hanno Roma”. Le Marche, invece, sono quelle del sempre un po’ meno (che non è vero, ma se lo sentono), quelle di cui si finisce per parlare solo se capita qualcosa e magari qualcuno ci lascia anche le penne. Come se fossimo incapaci di far parlare bene di noi per tutto il bene che c’è. Per tutto il bello che c’è. Come se fosse una vergogna. Come se quel bene e quel bello sentissimo di non meritarlo.
Prostituite, le Marche, al punto che, adesso che ci sono le elezioni, nemmeno i candidati delle Marche sono marchigiani. Te li mandano da fuori, come se fosse un favore: “Tiè, ti presto un candidato”. Essere marchigiano è quel vizio lì: pensare che gli altri sono più bravi e più fortunati, credere che dietro queste colline e questo mare ci sia la patria dei fenomeni. Roba che un fotografo lo chiami dalla Lombardia e lo vai pure a trovare in Sicilia e un baccelliere invaghito del situazionismo lo chiami filosofo. Roba che chiacchieratissimi personaggi squallidi, ma in rispettabilissimi abiti, li accogli da lontano per fargli smanovrare milioni di Euro. Il magis dell’esterofilia…e delle insicurezze. Adesso, ad esempio, c’è la ricostruzione del post sisma (e ora pure quella del post alluvione) e giù a andare a fidarsi di azzeccagarbugli che offrono solidarietà a suon di fatture e poi magari ti mandano pure in galera. Essere marchigiani significa prostituirsi alla legge del forestiero e, quando non basta, significa anche lasciarsi stuprare. Solo che se sei marchigiano ci paghi pure sopra e alla fine ringrazi anche. Altro che esattori del Papa e quella storia lì dello stare dietro la porta. Come a non voler accettare che oltre questo plurale, le Marche, c’è solo il singolare. Che è sempre uguale. E dopo un po’ annoia pure. Come a non voler capire che l’unica invidia utile dovrebbe essere per l’orgoglio che gli altri sanno avere rispetto alle loro radici.
Sì, ok, essere marchigiano significa fare i conti con gli scherzi che ti tira la natura ogni tanto. Che poi non è sempre colpa della natura e basta. Però è quella stessa natura che ogni giorno ti fa benedire l’essere rimasto o tornato qui, il non aver ceduto a quel qualcosa che ti spinge eternamente dentro per inseguire sirene fuori. E’ pochi fronzoli, è culto dell’andare avanti, è tirare su le maniche qualunque cosa succeda e credere ciecamente in una fede che non si chiama Dio, ma Futuro. Che è ancora di più, perché il Futuro se lo sai cercare lo trovi veramente, al contrario di Dio che invece resta sempre un po’ nel dubbio. Futuro e consapevolezza che, stravolgendo gli scenari, cambiano pure le prospettive. Come quando da ragazzini, appena presa la patente, siamo andati a sciare con i costumi sotto la tuta da sci e poi, all’ora di pranzo, ci siamo presentati in mezz’ora in spiaggia per fare il bagno al mare, con tutti che ci guardavano e gli scarponi Nordica per ciabatte. Dove altro se non nelle Marche? Educati al cambiamento repentino anche nelle mattate adolescenziali.
Le Marche sono Itaca: isola isolata che maledici e poi rivuoi con una forza che non si contiene. Come un luogo che, mentre ti incatena, libera opportunità e che poi, quando ti sei liberato, scopri essere l’opportunità stessa. Qualità e bellezza, ma senza apprezzarle mai abbastanza. Perché “abbastanza” è una parola che nei dialetti marchigiani non esiste. Perché c’è sempre un di più da fare. Perché è ancora tutto da fare e perché anche ciò che è fatto è spesso da ricostruire, visto quello che succede. Le ha maledette persino Leopardi, le Marche, solo che senza Marche, senza quella siepe oltre cui c’era L’Infinito, non sarebbe diventato Leopardi. Che poi nell’Infinito – che Infinito non era e ha dovuto scoprirlo - c’è morto, ammazzato da un gelato. E lo sapeva benissimo: fino a maledirle per finta, con una dolcezza che commuove – proprio lui che del dolore è stato interprete – in quei passaggi sul “borgo natio”, sul “poco valore delle maniere semplici”, sul cercare un oltre che invece è dentro. Semplice e scarno, come è semplice e scarna la gente di qui, quasi intimidita da un sentirsi ben voluta che è come quel bene che si vuole a chi sfugge sempre a un disastro. Ridendone, perché tanto piangere non serve quanto ricominciare. Ogni volta. E guai, guai davvero, a abusare di quella parola, “resilienza”, che in verità non significa assolutamente niente e fa vomitare persino su quei documentari raffazzonati via e su quelle pubblicazioni che ci si vergogna (giustamente) di chiamare "libri" o "cataloghi". Resilienza, lasciatemelo dire, fa sentire anche un po’ presi per il culo.
Come se la natura - che ogni tanto cancella - avesse in qualche modo cancellato pure i luoghi, tutta l’arte che le Marche hanno cullato, la poesia stessa e il cuore che c’hanno lasciato quelli che da qui sono passati. Che il Rinascimento scordatelo senza il ‘400 marchigiano se parliamo di pittura, che D’Annunzio momenti sbava mentre s’affacciava sul Conero, che pure Dante s’è sentito di scrivere ben più delle bellezze e dei personaggi marchigiani cantati sulla Divina Commedia. O ci vogliamo mettere in mezzo lo sport, Valentino Rossi giusto per dirne uno, oppure quei capitani d’impresa che hanno portato nel mondo la bottega sotto casa? Sì, la bottega sotto casa che rimane tale anche quando si fa industria. A proposito: fanno le scarpe, i marchigiani, e le tirano pure fuori sempre. Dal senso di inadeguatezza, dal disagio innato, dalle macerie di un terremoto, dal fango di una alluvione. Da chi ti promette che ci sarà sempre e poi scompare. Con tre o quattro accenti assurdi e una cadenza che magari fa un po’ ridere. Ma tanto di parole, se sei marchigiano, ne servono poche, meno che mai per vantarsi di quanta roba sono le Marche. Perché comunque c’è sempre altro da fare, qualcosa da ricostruire, un dolore da superare, un futuro da rigenerare con prospettive mutate e differenti. A gas aperto non per il gusto della velocità, ma per la necessità di fuggire, al limite inseguire e, al massimo, provare a superare. Se stessi prima che gli altri. Al punto che anche il clamore della solidarietà finisce quasi per dare un po’ fastidio, ma con la timidezza e l’educazione di non stare troppo a dirlo.
"Essere Marchigiani è un destino. Significa stare al mondo in modo tellurico e fantastico al tempo stesso. Aver sempre la necessità di scappare e sempre - sempre - patire la nostalgia ineludibile del ritorno. Significa avere la netta sensazione che la vita si svolga altrove, per poi scoprire che la si è persa in tutto ciò che si è lasciato. Significa rimanere incommensurabilmente soli in un deserto così somigliante al paradiso da confondere gli angeli nel loro volo (C. Catà)"