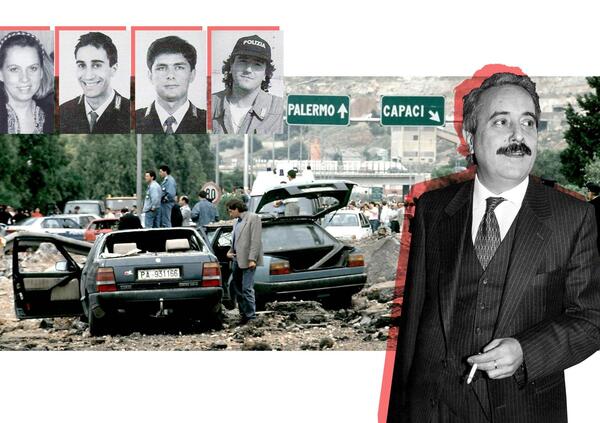«Fare luce su quel barbaro omicidio è una questione prioritaria per il nostro Paese». Le parole pronunciate oggi dal presidente della Camera, Roberto Fico, arrivano a 27 anni di distanza dalla morte di Ilaria Alpi il 20 marzo 1994. Ma soprattutto nel giorno in cui la giornalista del Tg3 uccisa in Somalia insieme al cineoperatore Miran Hrovatin avrebbe compito 60 anni.
Noi di MOW, per ricordarla abbiamo contattato Lucia Goracci, una delle migliori inviate all’estero, sempre in prima linea con la troupe della Rai per raccontare storie che possano renderci un po’ più consapevoli del mondo in cui viviamo, anche oltre alla nostra consueta confort zone. Con la collega scomparsa condivideva tantissimo: giornalista, donna, inviata di guerra e quella curiosità instancabile che le ha portate a superare qualsiasi difficoltà pur di onorare il proprio mestiere.

Lucia, oggi Ilaria Alpi avrebbe compiuto 60 anni. Che ricordo hai di lei?
Molto forte, non per conoscenza diretta ma per un legame ideale. Perché quando fu uccisa io stavo finendo la selezione per entrare in Rai come praticante giornalista. La stessa che aveva fatto lei precedentemente. E l’ultimo scritto infatti fu sulla Somalia, dove appunto lei è stata uccisa. Amavamo molto il suo modo di fare giornalismo, che era eccellente per varie ragioni.
Quali?
Intanto perché lei restava. Non andava sugli eventi soltanto quando erano di primo piano. Continuava a tornare, che è il miglior modo per raccontare. Quando tutti se ne vanno, la ricostruzione dei fatti può avvenire con più profondità e con una conoscenza a lungo termine. Lei andava in Somalia anche quando era meno hard news, come succede spesso nel fiume carsico dell’informazione. E poi perché non mollava mai la presa. Si avvicinava alle storie volendo raccontare l’altro lato delle cose. Senza dimenticare il tono del suo racconto, mai enfatico. Insomma, era un tipo di giornalismo al quale mi sono ispirata perché è quello che fa la differenza. Per questo è ancora così presente. E spesso mi chiedo, quando scoppiano grossi eventi, come lo avrebbe raccontato Ilaria Alpi.
Ti è capitato di imbatterti nella sua figura o nelle sue storie durante il tuo lavoro?
Con i colleghi degli esteri del Tg3. La prima volta che andai in Iraq, era il 2004 ed ero già 30enne, il mio direttore di allora Antonio Di Bella mi disse: “Mi raccomando, Lucia… ” menzionando poi Ilaria come se io fossi una giovane alle prime armi. Quello che ha lasciato lei è un forte segno di memoria emozionale, per cui aver lavorato nella stessa redazione sicuramente me l’ha fatta avvicinare. Le sue storie non le ho mai incrociate, perché non sono mai stata in Somalia, però ho sempre pensato quanto sia stato da subito difficile, al di là dei depistaggi, indagare su quell’agguato in cui morì insieme a Miran Hrovatin.
Come mai?
Perché in certi paesi l’impunità è legge e la ricostruzione dei fatti è estremamente difficile. Ora che si stanno tentando di mettere sotto accusa i capi dello Stato islamico per quello che hanno subito gli Yazidi mi è tornato alla mente. Nei paesi in guerra è sempre difficoltoso ricostruire quel che accade. Poi il tempo ci ha messo del suo. Purtroppo, è il peggior alleato della verità e il migliore alleato dei criminali.

Cosa provi quando senti dire: “Però un po’ se la vanno a cercare…”.
Un po’ pena, dico la verità. Perché denota la totale mediocrità di un mondo in cui siamo tutti pronti a guardare la realtà dal buco della serratura dei social e questo ci porta a giungere a conclusioni da distanze siderali dagli eventi. Io mi sento molto vicina a chi continua ad andare nei luoghi in cui i fatti accadono. La verità è qualcosa di astratto, ma questo è l’unico modo per declinare questo mestiere e provare ad avvicinarsi a una ricostruzione coerente e intellettualmente onesta di come le cose accadono. Le guerre contemporanee sono inevitabilmente asimmetriche, spesso ci troviamo al seguito di gruppi ribelli, quindi privi della capacità di essere allertati del pericolo in tempo. E così, quando ci accorgiamo che potrebbe arrivare, spesso ci è già precipitato sulla testa e ci va bene se ti ha solo sfiorato. Non se le vanno mai a cercare, semplicemente vanno a cercare. Che è ancora il vizio peggiore che abbiamo noi giornalisti.
Qual è stato il momento in cui hai rischiato di più la vita?
Me ne vengono in mente due. Il primo quando nell’estate del 2014 seguivo la guerra tra Israele e Hamas a Gaza, eravamo sulla linea del fronte approfittando della prima tregua e si ruppe proprio sulle nostre teste. Quando sei in mezzo è difficile poi trovare un riparo. Un altro volta, emblematica, a Kobane nel gennaio del 2015 mentre era sotto assedio dell’Isis. Noi la stavamo perlustrando al seguito delle forze curde e ci fu un attacco con una doppia autobomba, In pratica ci ritrovammo a rifugiarci in un cortile interno circondato da mura mentre tutto intorno divampava la battaglia. Il pericolo era che l’Isis, quando ti prende, non fa prigionieri. Per alcune ore rimanemmo in attesa, ma per fortuna vinsero i nostri.
Qual è la percezione per pericolo quando ti trovi in certi luoghi?
Tu pensi sempre di aver fatto tutto per proteggere te stesso e chi ti accompagna, come l’interprete o l’autista, perché non bisogna dimenticare che al nostro destino si accompagnano anche loro, che spesso sono locali che rischiano moltissimo. Perché noi possiamo almeno sperare di diventare merce di scambio per un riscatto, mentre loro vengono uccisi subito. Però tutto non si può calcolare al millimetro e anche quando pensi di averlo fatto rimane qualcosa di inaspettato che può risultare decisivo. Ma la curiosità prevale, la voglia di testimoniare, di raccontare, di andare a vedere con i propri occhi. Per cui il giorno dopo un grande spavento sei già pronto a ripartire.

Ho conosciuto Gabriele Micalizzi, fotoreporter di guerra, che dopo essere rimasto gravemente ferito in Siria, appena ha potuto è subito tornato al fronte. Un richiamo che evidentemente chi fa il vostro mestiere sente troppo forte.
Ci vogliamo molto bene. Io ero in Iran quando Gabriele venne colpito da quel razzo e stetti malissimo perché nelle prime ore non si capiva se fosse vivo o morto. Lui è un altro che ho poi ritrovato nonostante abbia rischiato grosso. L’Isis pubblicò quel video e dal lato dell’attacco l’esplosione è impressionante. Però anche lui ama questo mestiere al punto tale che poi alla fine è ripartito.
Non ci hai ancora mai pensato, dopo tanti anni, di tornare in redazione o di occuparti di qualcosa di meno rischioso?
Nel mio caso ci sono storie che non sono ancora finite e mi piace continuare a raccontare. Sono stata molto lieta di aver seguito Papa Francesco in Iraq, pur non essendo vaticanista, perché è stato il compimento di un racconto. Avevo raccontato i luoghi dei cristiani presi d’assalto dall’Isis, la liberazione delle città nella Piana di Ninive e questo l’ho trovato un grande gesto politico. Un viaggio arrivato in una fase in cui l’Iraq rischiava di uscire dai radar della nostra attenzione e invece il Papa li ha riportati d’attualità. Spingendosi fino a Mosul Ovest che è sunnita, che ha ancora lo stigma di aver aiutato l’Isis a resistere. In qualche modo ha risarcito gli ultimi, che è quello che un Papa dovrebbe fare. Però, finché ci saranno le mie storie in circolo mi piacerà raccontarle.
Oltre alle storie, c’è qualcos’altro che ti spinge a continuare?
È la capacità di meravigliarmi e di indignarmi. Quando sentirò che qualcosa scricchiola in questo senso mi fermerò, perché è giusto farlo. Non dico prendere posizione, ma almeno avvertire ancora le emozioni.
Per cui, nonostante le voci di un tuo ritorno alla conduzione del Tg3 o di Uno Mattina, il tuo posto è ancora altrove?
È interessante perché ogni tanto si fa il mio nome, ma a mia insaputa. Io per ora sto bene qui, con le mie storie, in questo paese complicatissimo e affascinante in cui vivo da tre anni e mezzo che è la Turchia e fino a quando riuscirò ad avere voglia di ripartire e la curiosità e l’empatia di raccontare continuerò a farlo.