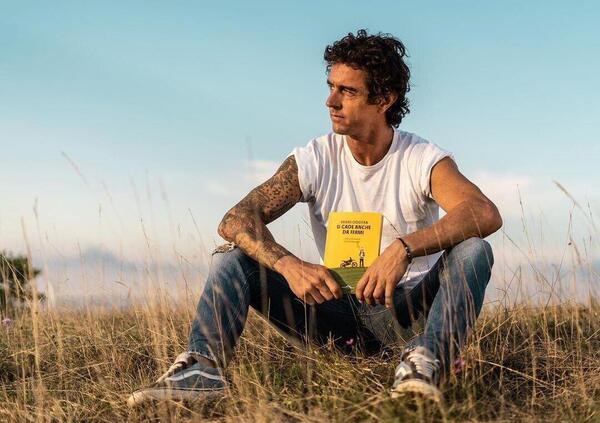Quello di Armando Nogueira è un nome per iniziati, ma l’epitaffio definitivo per Pelé non può che essere suo, del giornalista che più di altri ne ha cantato le gesta: «Se não tivesse nascido homem, teria nascido bola», e cioè se non fosse nato uomo, sarebbe nato pallone. Nogueira se n’è andato nel 2010, ora è la volta di O Rei, il Re, primo calciatore riconosciuto quale il migliore di sempre su scala globale, personificazione dell’assoluto calcistico dall’epifania sui campi sino all’ultimo giorno. Il primo, occhio, e qui non hanno rilevanza alcuna i paragoni con i grandi che sono venuti dopo perché, appunto, possono anche averlo superato – e chi può dirlo? – ma non potranno mai togliergli la primogenitura nell’immaginario collettivo. Perché prima di lui, così, nessuno.

Il resto è mancia abbondantissima, opulenta: la povertà redenta, il sedicenne che piazza il Brasile nell’empireo del calcio, il fuoriclasse delle tre Rimet, gli innumerevoli gol segnati – e il loro conteggio, giochetto molto brasiliano al quale ha partecipato con atteggiamento splendidamente infantile anche Romario – e pure quelli che gol non sono stati e hanno gonfiato l’epica dei suoi avversari (Gordon Banks, 1970), il tunnel che riusciva a non essere derisorio né era percepito come tale, i rivali che non erano nemici. Pelé è stato un incipit leopardiano per quello che è forse il più formidabile articolo calcistico di Gianni Brera (Benfica-Santos, 1962), la Regina d’Inghilterra di Antonello Venditti, un popolarissimo siparietto tra Malcolm Allison e Pat Crerand nel 1970 («How do you spell Pelé?», «Easy: G-O-D»), e poi ancora l’apoteosi del numero 10, l’immortalità del Santos, il calcio a New York, il caporale Luis Fernandez su celluloide e tutto quanto di lui è stato scritto, detto, cantato, documentato, evocato.

Il Pelé pubblico è stato anche una peculiarità impossibile da rintracciare in fuoriclasse vicini al suo livello. Prima che le librerie online ridondassero di volumi più o meno inutili a tema sportivo, nel 1997 Gian Paolo Ormezzano uscì con Tutto il calcio parola per parola, un alfabeto pallonaro imitatissimo nel quale, alla voce Pelé, si leggeva una chiave interpretativa storica che ne inquadrava la singolarità sociale e politica. Una trasversalità da foto incorniciata nel pantheon di chiunque. Non un rivoluzionario, meno che mai un ribelle o un capopopolo, sicuramente un nume tutelare, icona del gioco a prescindere, adatto a tutte le stagioni della Fifa e del Brasile, immagine del calcio e dello sport di tutti senza tribalismo alcuno. Lontano dalla rappresentazione che ha alimentato l’agire pubblico di Alì, di Smith e Carlos, persino di Friedenreich. Nessuno di loro, o forse tutti loro messi insieme ma senza annessi e connessi.

«Abbastanza curiosamente – scrisse Ormezzano – Pelé è riuscito ad attraversare anni e anni di conflitti razziali anche duri senza mai essere spinto o magari essere costretto a passare per simbolo del colore della sua pelle. Ha sposato donne bianche, è diventato ministro per lo sport in un Brasile che, sostenendo di non essere razzista, offre in realtà ai neri soltanto lo sport per fare esercitazioni di pari opportunità e anche di eguaglianza, e non ha mai avuto un nero contro, non ha mai dovuto subire un nero deluso». Una lettura di venticinque anni fa – le uniche critiche sulle blande o assenti prese di posizione, in effetti, a Pelé sarebbero arrivate solo recentemente da Lilian Thuram – eppure molto attuale ora che l’intreccio fra sport e politica viene analizzato con maggiore attenzione. Un’indole nella quale i cinici vedono una strategia – buonismo, lo chiamano, uno dei neologismi più insulsi dei tempi recenti – ma è di certo un modo di vivere che neutralizza i conflitti (e ne ha avuti anche O Rei, nella sua esistenza) ed elimina la possibilità di riempire la sua figura di senso altro che non sia, semplicemente, quello del calcio, della sua essenza.