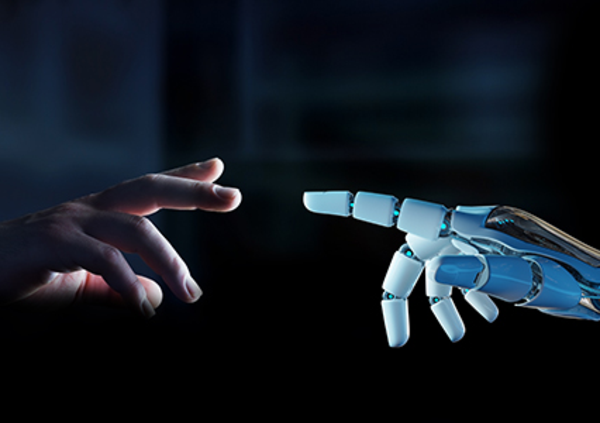Nel corso della sua storia, l’umanità è avanzata molto spesso grazie a trovate tanto semplici quanto efficaci: dalla ruota, all'ombrello, dai bottoni, alla penna a sfera. Problemi più o meno grandi hanno trovato risposta grazie a intuizioni geniali, capaci di risolvere in maniera efficiente una serie di problemi, attraverso soluzioni che erano sempre state davanti agli occhi di tutti, ma che nessuno era mai stato in grado di vedere.
Anche il casco fa parte di questo tipo di trovate. D’altra parte, come proteggere il cervello se non con un guscio in grado di imitarne il suo naturale sistema di protezione? In realtà, un modo per preservare ancor meglio il più prezioso dei nostri organi esiste eccome, ma l’esigenza di superare il concetto tradizionale di casco è emersa soltanto di recente, grazie a un gruppo di ricercatori e al Royal Institute of Technology di Stoccolma. Siamo stati a Täby, in Svezia, per fare visita a Mips, l’azienda a cui questo gruppo di studiosi ha dato vita. Li abbiamo scoperto come è nata una tecnologia apparentemente banale nel suo funzionamento, ma così valida da convincere decine di costruttori a integrarla all’interno dei propri prodotti, nelle più disparate discipline. Perché come diceva Bruno Munari: «Quando qualcuno dice: “questo lo sapevo fare anche io”, vuol dire che lo sa rifare, altrimenti lo avrebbe già fatto prima».
Una storia lunga trent’anni
Era il 1995 quando il neurosicenziato svedese Hans von Holst decise di contattare il Royal Institute of Technology di Stoccolma per iniziare a studiare i danni provocati dagli impatti accidentali alla testa, nonostante l’utilizzo di un casco. Ciò che emerse, dopo alcuni anni di esperimenti, fu che la presenza di uno strato protettivo non era in grado di evitare al cervello gli effetti degli scontri che esso stesso subiva contro la parete interna della scatola cranica, a seguito di ogni urto. «Dovete considerare che un cervello umano pesa circa, 1200-1300 grammi. Un peso che, al momento dell’impatto, viene moltiplicato esponenzialmente in base alla velocità con cui il corpo si sta muovendo», ci dice Peter Halldin, Chief Science Officer e Co-founder di Mips, mentre illustra alcuni degli studi condotti da lui e dai suoi collaboratori, nei primi anni di vita di questa avventura. Per capire cosa avvenisse all’encefalo durante ogni urto, vennero perfino utilizzati dei veri e propri corpi umani, donati volontariamente alla scienza. Gli impatti venivano filmati con delle speciali videocamere in grado di catturare, con un altissimo numero di frame per secondo, ciò che avveniva dentro la scatola cranica. Al cervello venivano applicati dei marker, così da poterne distinguere la superficie e osservare i suoi movimenti dentro alla testa, a seguito dei vari impatti. Ciò permise di rendere evidente come, al pari di un’onda che si infrange, nel caso di urti non esattamente perpendicolari, l’encefalo subisce una rotazione nella direzione dell’impatto, dissipando la sua energia cinetica contro le ossa che dovrebbero proteggerlo. Quali erano le conseguenze di queste collisioni? Gli studi mostrarono come questo tipo di rotazioni potessero generare versamenti ed ematomi in grado di compromettere gravemente le funzionalità di quell’organo.
Apparentemente, tuttavia, nessuno si era ancora posto il problema di come prevenire questo tipo di danni. Ciò era testimoniato - anche - dal modo in cui allora (e così per molti anni a seguire) venivano eseguiti i test necessari per le omologazioni di questi prodotti, specialmente in ambito motociclistico. Le prove che i prodotti dovevano superare, infatti, simulavano sempre un impatto perfettamente perpendicolare alla testa. Gli urti a cui sono sottoposti motociclisti, ciclisti, scalatori, fantini, pattinatori e chiunque utilizzi un casco, tuttavia, sono nella stragrande maggioranza dei casi caratterizzati dalla presenza di un angolo di impatto ben diverso da 90°, a cui si aggiunge, inoltre, la forza d’inerzia di cui è portatore un corpo in movimento. Cosa significa tutto ciò? Significa che per proteggere adeguatamente ogni testa era necessario cominciare a considerare le conseguenze di urti con angoli differenti e l’accelerazione lineare che ne derivava. Facile a dirsi, ma non a farsi. La risposta, ancora una volta, venne dall’osservazione della natura e di ciò che il nostro corpo ha già individuato come sistema di salvaguardia.
Dalla natura, le idee migliori
Abbiamo accennato, in precedenza, a come i caschi, storicamente, non abbiano fatto altro se non imitare, moltiplicandola, la capacità di assorbire gli urti che è naturalmente propria del nostro cranio. Ebbene, la nostra testa non è composta, però, unicamente da ossa e cervello. A separare questi due “componenti” ci pensa un fluido che millenni di evoluzione hanno frapposto fra i due, proprio allo scopo di consentire una certa libertà di movimento all’encefalo, evitando frizioni con ciò che lo contiene. Il suo nome scientifico è liquido cerebrospinale (o liquido cefalorachidiano) e il suo scopo è proprio quello di agire come una sorta di cuscinetto per il cervello, fornendo una protezione meccanica e immunologica di base, all'interno del cranio.
È osservando questo sistema di difesa che i ricercatori di Mips hanno ipotizzato di poterne replicare il funzionamento con l’introduzione di uno strato aggiuntivo, da posizionare tra l’imbottitura del casco e lo strato demandato ad assorbire la forza cinetica degli impatti. L’obbiettivo era quello di permettere alla testa di ruotare all’interno del casco stesso, al pari di quanto fa il cervello dentro alle sue pareti.
Gli esperimenti realizzati con l’utilizzo dei primi prototipi hanno dato immediatamente esito positivo, dimostrando come questa soluzione potesse risultare efficace per ridurre di quasi 1/3 l’accelerazione angolare a cui il cervello era soggetto in caso di impatto. Ma per poter approfondire gli ambiti di applicazione e per poter rendere questa tecnologia utilizzabile da una moltitudine di aziende, era necessario poter effettuare delle simulazioni che consentissero di riprodurre virtualmente quanti più esperimenti possibili. È così che è nato il KTH FE Human Head Model.
La simulazione che salva le vite
Cominciamo col decriptare gli acronimi: KTH sta per Kungliga Tekniska högskolan, che in svedese vuol dire Istituto Reale di Tecnologia (o, appunto, Royal Institute of Technology). FE (o FEM) sta, invece per, Finite Element Method (in italiano “Metodo degli elementi finiti”), una dicitura che identifica un sistema standardizzato di analisi che consente di simulare, con calcoli matematici, l’effetto dei carichi meccanici o termici applicati ad un corpo. Qual è stata l’intuizione dell’Royal Institute of Technology? Applicare questa tecnica solitamente adoperata in ambito automotive, per analizzare gli effetti a cui sono soggetti i diversi materiali che compongono un casco e le conseguenze che si riverberano sulla testa di chi lo indossi. Il vantaggio, come è facile intuire, è la possibilità di rendere potenzialmente infinito il numero di test effettuabili a parità di tempo.
Tutto facile quindi? Mica tanto. Perché il modello potesse funzionare, infatti, era necessario creare un enorme database che permettesse ai software di interpolare i dati. Come reagisce il materiale X, se aggiunto al materiale Y, dopo un impatto Z? Per saperlo bisognava testare i singoli materiali. Le risultanze di questi test hanno costituito il corpus di dati che sono stati poi forniti in pasto alle macchine chiamate a prevedere gli effetti delle interazioni tra tutte le variabili descritte in precedenza. Un lavoro lunghissimo che ha richiesto, ad oggi, oltre 25 anni di esperimenti e che consente ora, a Mips, di svolgere un’attività di consulenza per i più importanti player nella produzione di caschi, al fine di sperimentare la loro efficacia e le loro capacità di essere protettivi, addirittura prima che un determinato modello sia stato messo in produzione.
Ok ma come funziona il sistema Mips?
Mips equipaggia, oggi, oltre 1000 differenti modelli di casco, tra prodotti destinati alle biciclette, alle moto, all’equitazione, all’alpinismo, allo sci e alle discipline invernali in genere, per finire con il mondo delle costruzioni. Ognuno di questi caschi monta al suo interno un sistema specificamente studiato per quel determinato modello, il cui principio di funzionamento, basato su quell’analogia con il liquido cerebrospinale di cui abbiamo parlato in precedenza, è sempre lo stesso. A distinguere ogni applicazione è, ovviamente, la differente conformazione di ogni casco e la conseguente necessità di individuare, per ognuno di essi, la migliore collocazione del sistema.
Un processo di customizzazione per i nuovi caschi e di ricerca e sviluppo dei diversi sistemi che ha richiesto oltre 65.000 test e che è effettuato interamente all’interno del laboratorio presente a Täby. Un vantaggio competitivo enorme, in grado di porre Mips, non soltanto al di sopra di qualsiasi competitor, in termini di know-how e di capacità di R&D, ma di rendere altresì l’azienda svedese il migliore degli interlocutori per chiunque desideri iniziare ad equipaggiare i propri prodotti, con questo tipo di tecnologia. E tra le industry più interessate a questo tipo di collaborazione, non vi è dubbio che in cima a tutte vi sia quella impegnata nella produzione di dispositivi di sicurezza per motociclisti.
Le moto, lo sbarco in MotoGP
Come facile immaginare, tra le industrie maggiormente interessate all’attività di Mips, vi è stata, fin dal principio, quella motociclistica. Un interesse che, per un certo periodo, si è trasformato addirittura in partecipazione diretta, quantomeno per una delle più storiche aziende di questo settore. Ci riferiamo a Bell, brand americano che, fra le altre, può a buon titolo vantare di aver introdotto sul mercato il primo casco integrale per sport motoristici, nel lontano 1966. Bell (BRG) è stata azionista di Mips dal 2014 al 2016, prima che le loro strade si separassero quando Mips è stato quotato in borsa. Proprio Mips, infatti, non ha mai voluto rinunciare alla possibilità di fornire la propria tecnologia a chiunque ne facesse richiesta. L’ipotesi di rendere il suo sistema di sicurezza un qualcosa di esclusivo, di legato unicamente a un marchio, ha sempre cozzato con la vision di una società che porta nel DNA un approccio soprattutto scientifico, volto a risolvere un problema - per il bene dell’umanità, non soltanto per il profitto. Un approccio che traspare in maniera evidente in chiunque lavori a Täby e che fa di quest’azienda un unicum, in un panorama che è - giocoforza - solitamente orientato principalmente a logiche industriali.

Proprio in quest’ottica, sono molte, ora, le realtà di primo piano che stanno definendo gli ultimi dettagli per poter adottare la tecnologia offerta da Mips. Impensabile, infatti, ipotizzare di poter sviluppare internamente una soluzione che ne replichi le caratteristiche. Per poterlo fare, servirebbe troppo tempo e troppo denaro: troppi dati da raccogliere, troppo know-how da acquisire. Ecco, dunque, il motivo per cui una partnership risulta essere la soluzione migliore anche per quanti abbiano fatto della ricerca e sviluppo un proprio motivo di vanto.
A testimonianza della bontà della soluzione offerta, in questo ambito, vi è lo sbarco della tecnologia Mips, per la stagione alle porte, anche nella massima serie del motociclismo mondiale. Aleix Espargaró indosserà, per il 2023, un casco prodotto dalla giapponese Kabuto, equipaggiato proprio con un sistema Mips.
Il futuro di questa tecnologia
Cosa succede ai dispositivi di sicurezza quando ci si rende conto della loro efficacia? Solitamente diventano uno standard, tanto da divenire obbligatori per legge o comunque necessari per riuscire a superare i test di omologazione nei rispettivi ambiti di applicazione. Della prima categoria hanno fatto parte, in passato, invenzioni come le cinture di sicurezza (tra l’altro anch’esse nate in Svezia, grazie a Volvo), l’ABS o l’Airbag, giusto per restare all’interno di un settore a tutti ben noto. Del secondo fanno parte, invece, tutte quelle migliorie che possono trovare alcune varianti nelle rispettive modalità di impiego. Proprio a proposito di caschi, ad esempio, la nuova normativa europea ECE22.06 prevede la necessità di rispettare una serie di standard in termini di resistenza delle calotte, che ben può essere soddisfatta con l’adozione di differenti materiali o diverse tecnologie. È in quest’ottica e, ancora una volta, dando seguito a quella volontà di salvare innanzitutto più vite, a prescindere dal proprio tornaconto, che Mips sta svolgendo già da diversi anni un’attività di consulenza e lobbying, in seno alle più rilevanti istituzioni a livello mondiale, affinché venga resa in generale obbligatoria una tecnologia volta a preservare il cervello dalla rotazione dovuta agli impatti accidentali. È così che per le omologazioni ECE22.06 (caschi moto in Unione Europea), DOT FMVSS 218 e Snell M2015 (caschi moto negli Stati Uniti e UK), EN1078 (caschi bici in Europa) e CPSC (equivalente della EN1078, per gli USA), è stato introdotto un test volto a misurare la capacità di assorbimento degli urti a seguito di un impatto lineare. In questi casi, i caschi sottoposti alle prove devono trasmettere a chi li indossi un’accelerazione inferiore a 250 G. In particolar modo per le omologazioni ECE22.06 e FIM presentano anche un test sulle forze rotazionali che si sprigionano nell’impatto al fine di ridurre le lesioni celebrali. Sempre sul fronte moto, un’analoga attività sta proseguendo al tavolo della FIM, chiamata a fissare gli standard di omologazione dei prodotti racing (ben più restrittivi di quelli stradali). Ad oggi non è ancora stata prevista l’introduzione di una obbligatorietà, circa l’adozione di tecnologie di questo tipo, ma la direzione è oramai intrapresa.