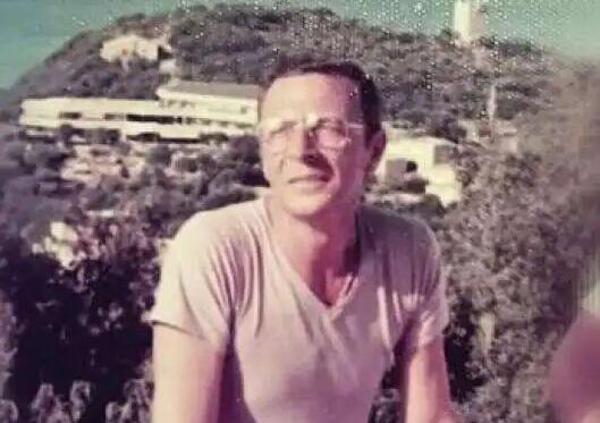Da quasi cinquant’anni, l’omicidio di Mino Pecorelli è sospeso in una zona grigia istituzionale, dove i passi delle inchieste si fanno lenti come quelli di un condannato a morte. Non per mancanza di piste, ma perché la verità fa paura. Andrea Pecorelli, suo figlio, ha rotto gli indugi sul sito di Osservatore Politico, erede digitale del settimanale fondato dal padre: “A nessuno interessa scoperchiare sto’ vaso di Pandora. Stavolta, però, ve lo dico in qualità di figlio… avete rotto il cazzo… addormiteve… tanto la verità, la scopro lo stesso”. Quasi cinquant’anni di archiviazioni, assoluzioni, rinvii e silenzi non sono un mistero irrisolto, ma una verità che viene evitata. Non è che non si sappia. È che non si vuole sapere. Pecorelli non era un giornalista qualsiasi. Scriveva di segreti veri, apparati, intrecci tra politica, intelligence, criminalità, massoneria. Aveva documenti. Aveva nomi. Aveva capito troppo. Ed è stato ucciso per questo. Tutto il resto è fumo negli occhi. Una giostra giudiziaria che non ha mai avuto un obiettivo reale, senza individuare mai esecutori e mandanti. Perché il punto non è chi ha premuto il grilletto. Il punto è chi ha deciso che Pecorelli doveva morire. E qui, sempre, si alza il muro di gomma.
Ogni volta che l’indagine si avvicina a certi ambienti, a certi equilibri, a certi segreti che non devono essere dissepolti tutto rallenta, e poi si ferma. Quattro anni fa, grazie al lavoro certosino di Raffaella Fanelli, si rintraccia la pistola usata per l’omicidio. Novità che dovrebbe far sobbalzare i titolari dell’inchiesta e spingerli a approfondire. Ascoltare Vincenzo Vinciguerra prima che sia troppo tardi? Macché. Comparare la pistola con i proiettili Gevelot rinvenuti nel corpo di Pecorelli? Nemmeno. Si lascia che il tempo scorra, preparando la strada per l’ennesima archiviazione. La domanda che nessuno osa fare è, perché non si è mai voluta una vera Commissione parlamentare d’inchiesta? Non una passerella, non un teatrino. Una commissione con poteri reali, accesso agli archivi, capacità di chiamare nomi pesanti. Per mettere a fuoco quanto questo omicidio sia legato a doppio filo con i casi Moro e Dalla Chiesa. Per richiedere i verbali secretati dell’Ucigos. Per scoprire, magari, che il memoriale Moro, quello vero, era finito nelle mani di Pecorelli.
La risposta è semplice e inquietante, perché farebbe saltare il banco.Emergerebbero responsabilità sistemiche, non solo individuali. Coinvolgerebbero pezzi dello Stato, e non solo. Metterebbero in discussione la narrazione rassicurante di un Paese che ha fatto i conti con il passato. Non è vero. Con il caso Pecorelli non si è fatto nulla. E si continua a non fare nulla. A chi fa paura la verità? Fa paura a chi ha costruito carriere sul silenzio, a chi ha protetto equilibri indicibili, a chi custodisce segreti che, se resi pubblici, delegittimerebbero interi apparati. Ancora oggi. Pecorelli non è un episodio. È una chiave. Capire chi l’ha ucciso significa capire come funzionava, e forse funziona ancora, il potere in Italia. E allora? Meglio lasciare tutto lì. Un altro morto eccellente, un’altra archiviazione, un’altra "verità giudiziaria" che non convince nessuno. Intanto, i familiari, sempre soli, vengono presi per il culo dallo Stato. E, in primis, dalla Giustizia. Il caso Pecorelli non è irrisolto. È sepolto. Finché resterà così, ogni discorso su legalità, trasparenza, memoria sarà solo ipocrisia istituzionale. Finché nessuno avrà il coraggio di rispondere, questa non sarà una democrazia adulta. Sarà solo un Paese che continua a scappare dai propri fantasmi.
More
La pistola che ha ucciso Mino Pecorelli è nel tribunale di Milano?