Il tutto, infine, ha l’effetto del coito interrotto, anzi, dell’interruzione senza coito, della madida insoddisfazione, madornale, da smadonnare. Dai, cazzo, fammi godere!, ti viene da sussurrare allo scrittore, criterio d’api nella narice sinistra, poi da urlargli addosso, infine ti spazientisci; niente, questo romanzo, pieno di moine, di mani sul pacco, di succhiotti irrichiesti, ammoscia. Corpi minori (Mondadori) – buono il titolo, copertina orrenda – racconta l’ossessione del narratore, insegnante di yoga per campare, universitario talentuoso ma incostante, che preferisce le pensatrici donne (Simone Weil, soprattutto), per l’amore. “Inspiro, ti amo? Espiro, non ti amo più”, dice il narratore all’inizio, sorta di mantra da manovale di Eros; e così ripete, verso la fine, asfittica.
Il narratore, cresciuto a Rozzano, sceglie di vivere a Milano, va in estro per svariati maschi, che dopo un po’ molla. L’ultimo – “Un ragazzo, il mio nuovo culto” – si chiama Marius, “occhi grandi e chiari, astuto compromesso tra il verde salvia e il nocciola” (!?!), è di origine rumena (il che fa prendere una cantonata filosofica al narratore: “Cioran era di origini rumene, sì, ma scriveva in francese”, scrive, scrivendo una mezza coglionata, visto che Cioran, autentico esteta della lingua francese, comincia scrivendo in rumeno, Al culmine della disperazione, ad esempio, uno dei libri più noti, “Pe culmile disperării”). Tutto sembra andare bene, ma finisce male. Detto questo, in una pasticceria di frasi zuccherate, letali, indigesti marshmallow verbali (“Quando ti innamori ti si centuplicano le forze e insieme rischi il collasso”; “Quando facciamo l’amore, la prima volta e le molte a seguire, sarà sempre così: non riesco a smettere di esplodere sorrisi, cercare i suoi occhi”; “l’amore vero non contempla compromessi”; “Ci rivedremo, mi scriverai? Non riesco a chiedergli niente”), detto tutto, leggete altro. Un paio di consigli – che vanno, prima di tutti, all’autore: scrivere è come forgiare un violino o una tazza del cesso, chiede perizia, artigianato, grazia, dunque, la ricerca dei maestri, lo studio, incessante, marziale. Intanto, Jean Genet: Querelle de Brest, Pompe funebri, per dire. In un’intervista che ho tradotto qualche tempo fa il narcisismo di Genet ha vertigini di cristallo: “Mi sono sempre sentito separato, anche ora, separato da tutto. Preferisco restare a distanza dagli esseri umani... Forse, dopo tutto, sono un impostore che non ha mai scritto libri. Forse sono un falso Jean Genet”. A confronto, lo scrittore di Corpi minori – a cui, leggo a pagina 281, piacciono da impazzire “Joyce Carol Oates, Rosa Matteucci, Teresa Ciabatti” – è un novizio, uno che non sa la differenza tra il selfie e uno specchio. Poi leggete Hervé Guibert: chissà perché l’editoria nostra se l’è dimenticato, ama le copie delle copie, probabilmente, gli scritti minori come Corpi minori, gli scrittori da oratorio, che catechizzano la società leccandole l’ano, che latrano di antispecismo con cardinalizia schifiltosità, ispirati, per lo più, dallo sfintere di una vana chiacchiera.
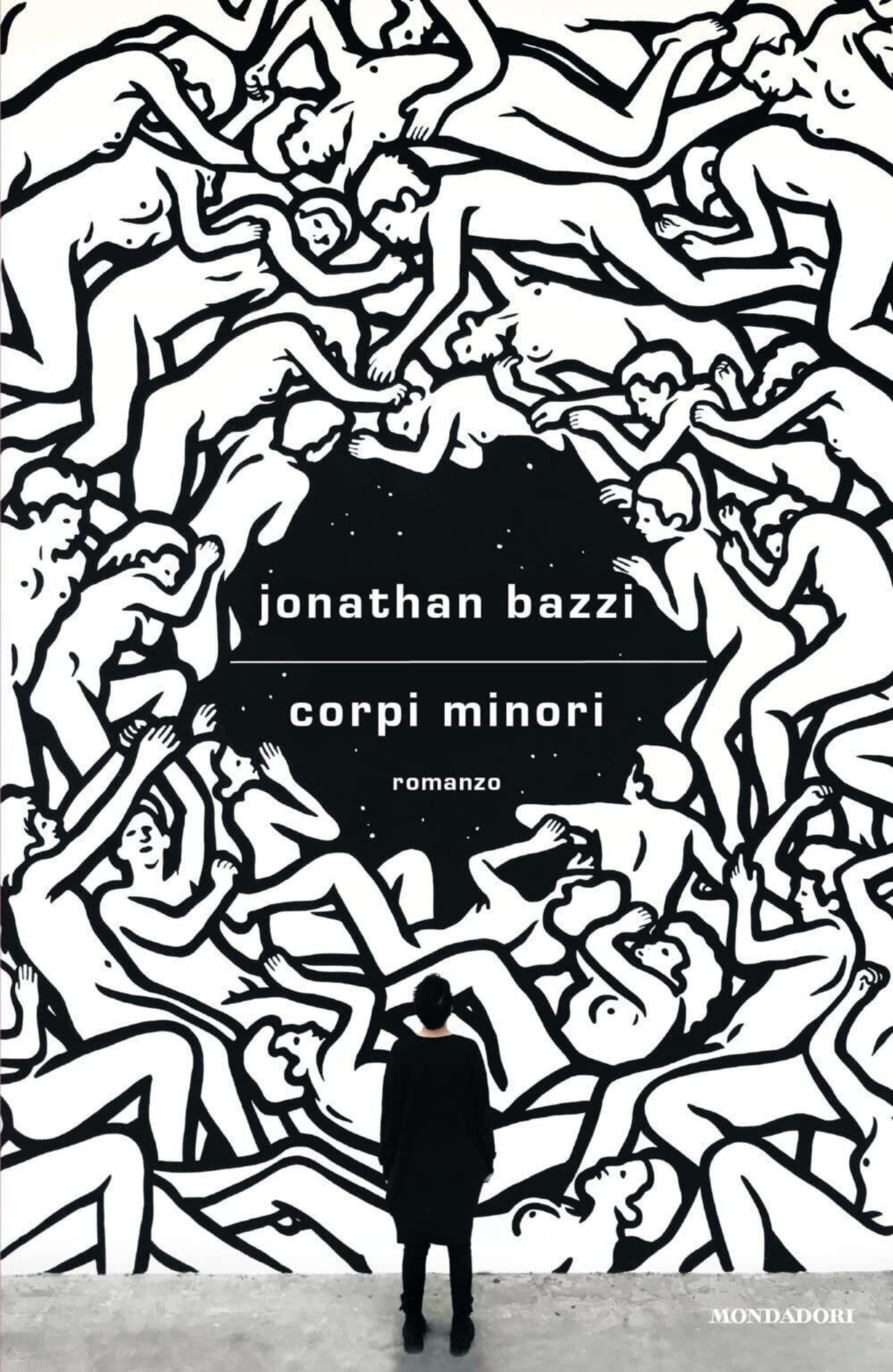
Ecco, Jonathan Bazzi, faccendiere d’amore, ci propina una letteratura della lagna e del piagnisteo (“Ho ventotto anni e non sono niente, ben più che fuori posto: non credo più esista un posto”), una narrativa postprandiale, che asseconda gli umori del post su Facebook; dovrebbe essere giovane & vispa, diversa, ma è vecchia, risaputa, defunta, con la tonsura di chi vuole il riconoscimento pubblico, civico, sociale. Non è esclusiva del narratore – che pare coincidere con l’autore – un’infanzia alla periferia di tutto, da poveri in canna, crudeli entro una gloria di meschinità: a noi, marginali, smangiati, aborti del proprio tempo, tutti, hanno dato del frocio, ci hanno rimpinzato di pugni per gioco, ad alcuni abbiamo replicato ad altri abbiamo risposto con la trigonometria dell’indifferenza, per sempre indifesi, orfani, bastardi. Anch’io, come tutti i confratelli del nulla, ho l’amico morto d’overdose troppo giovane, quello che spacciava e l’hanno beccato, aveva la madre che si prostituiva per arrotondare, e l’altro, che si faceva spompinare, maschi o femmine, pensionati o vergini era uguale; giocavamo a calcio e finiva in rissa, con il florilegio rossoblu della solita pattuglia dei carabinieri a scortarci in un altrove di bestie meridiane; ci siamo attrezzati alla vita consapevoli del sapore del reietto. Non basta per farne un romanzo; per fare un romanzo ci vuole la melma che diventa lingua, il vomito verbale, la grandezza nell’abiezione; ci vuole, per dire, Seminario della gioventù, Altri libertini, qualcosa di simile, non certo il libertinaggio nell’ovvio di Bazzi.
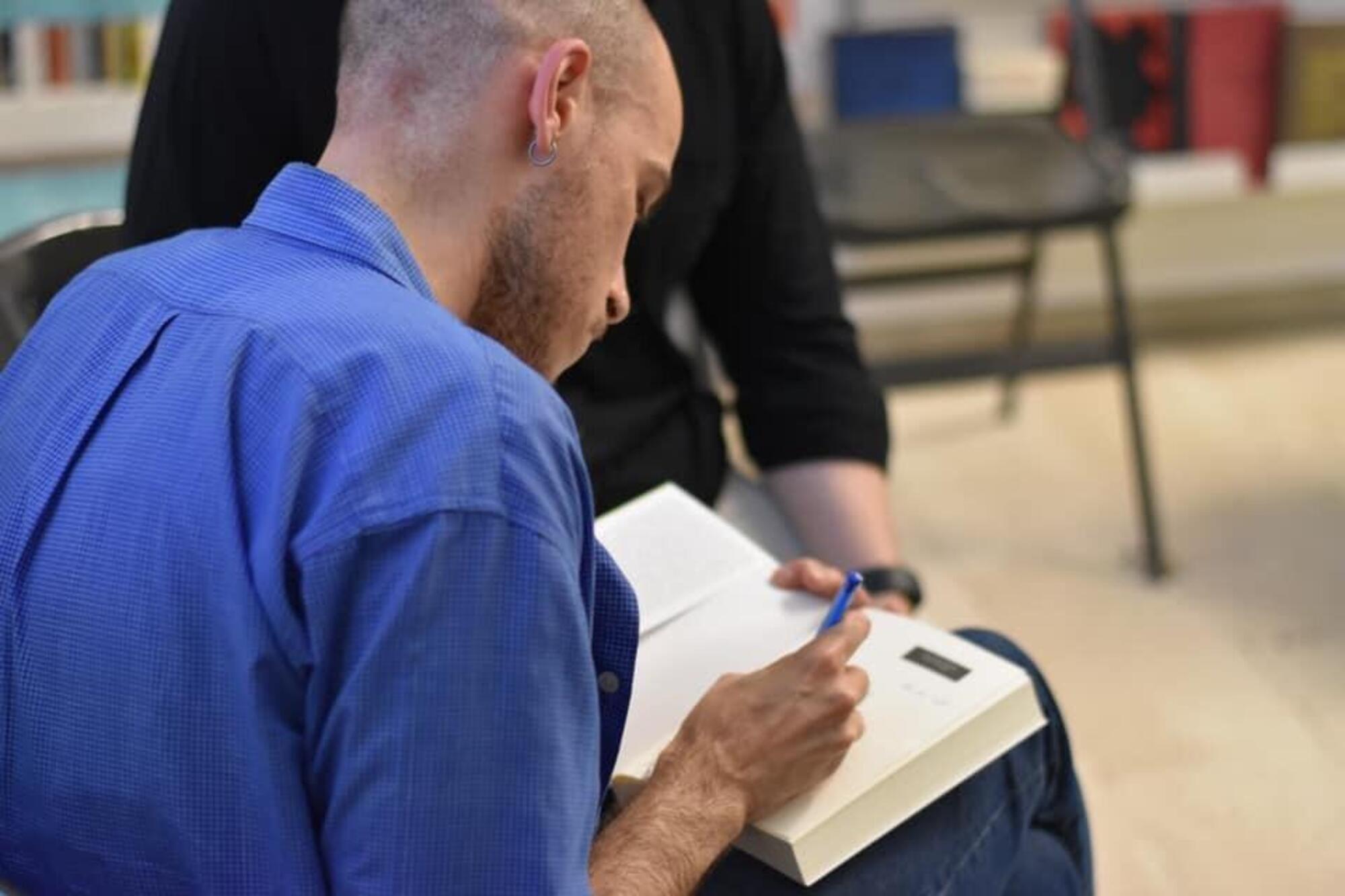
A credere ai titoli dei capitoli, topografici, il romanzo, per altro, dovrebbe parlare di Milano: in realtà, il vero, incensurato, censito protagonista è l’ombelico del narratore, largo quanto un tinello, più claustrofobico di un monolocale. L’egolatria, imperdonabile, inquina un libro, così, che ha parti non innocue, con qualche possibilità d’estasi: il pompino “tra camion parcheggiati e capannoni di fabbriche a prima vista abbandonate”; il pitone nutrito a topi vivi, “bisogna dargliene uno ogni tre, quattro settimane”; la morte di Minnie, con il semaforo che la centra in testa, scassandola; “le talpe di via Guido Rossa”, falangi di barboni, tossici, famiglie intere che vivono in “catacombe, gallerie infinite”, nei sotterranei della periferia, “la necropoli dei morti in vita”. Infine, il romanzo scema nell’insignificanza; i Ringraziamenti paiono una seduta psicanalitica.
Peccato: la derisione, lo scandalo, la protervia polemica, le estreme orbite degli anonimi e degli anormali, gli ultimi, i discordi, i figli dispari, i disagiati, i buchi neri, hanno sempre splendore romanzesco. Ma qui, bendati dal basso onanismo del narratore, è come assistere a Waterloo con il commento di Fabio Volo e una canzone di Blanco in sottofondo: l’epica del massacro è risolta in detergente intimo, la letteratura in un peto, venuto fuori per sbaglio, durante una cena a lume di candela.













