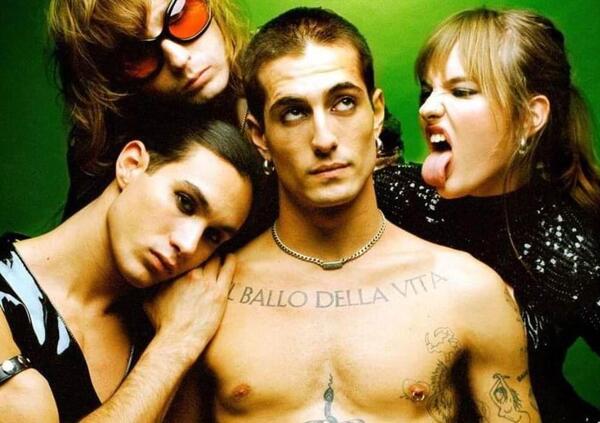“E malgrado questo, io e lei, la pallottola intendo, siamo ancora qui. Fino a oggi ci siamo addormentati e risvegliati insieme tutti i giorni, senza darci fastidio reciprocamente. Le sono grato. Ha seguito la traiettoria giusta: non si è fidata fino in fondo di me. Come ogni donna”. “Cosa farò da grande-I miei primi 90 anni”, autobiografia di Gino Paoli scritta con Daniele Bresciani e uscita per Bompiani, ha l’ineguagliabile dote della sfacciataggine. Una sincera sfacciataggine, privilegio di chi viaggia verso il secolo di vita, ma anche caratteristica quasi genetica di un genovese di razza che prima di raccontare ha deciso, prepotentemente, di vivere. Che pare ovvio, ragionevole: prima vivi, poi ce la racconti. In testi, in musica, in gesti, in fatti che squinternano le pagine di cronaca. E invece no, perché come ci hanno insegnato Benji e Fede con l’inutile “Vietato smettere di sognare” (2016), oggi prima si racconta tutto ma proprio tutto ciò che si è combinato in due/tre anni di fulminante “carriera”, poi si sparisce nel nulla lasciando in eredità un paio di canzoncine scadute. Gino Paoli è un’anima picaresca. Nelle prime tre righe del libro cita “Il cielo in una stanza”: “Sono […] uno dei ragazzi di Genova che hanno scritto canzoni. Forse pensate che io sia qui per raccontarvi i miei successi, mettendoli uno in fila all’altro come trofei placcati d’oro in una vetrinetta”. Non è così. Paoli ha conosciuto le tenebre e avverte: “Da queste pagine non potete imparare nulla”. Partiamo bene, il potenziale influencer definitivo (90 anni di aneddoti ed esperienza) non ci vuole influenzare. Così attacca una storia che per 300 pagine tiene i ritmi di un FrecciaRossa. Le fermate sono ben scandite (i successi, le donne, la politica, la boxe, gli amici), il ritmo costante. Da quando Paoli abbandona Sigla Effe – l’agenzia pubblicitaria dove lavorava fra la fine degli anni ’50 e i primi ’60 – è tutto un’avventura. Perché fino a quel momento Paoli aveva vivacchiato, da quel momento in avanti ha vissuto. Si definisce “un pigro mostruoso”, ma anche erede di “un tipo di umanità speciale”. “La nostra generazione, come ha detto una volta un altro ragazzo di Genova, Paolo Villaggio, ha mancato tutti gli appuntamenti importanti. La guerra? Siamo arrivati troppo presto. Il Sessantotto? Siamo arrivati tardi”, scrive. E allora cosa ha fatto quella generazione per definirsi? Ha vissuto davvero. A 18 anni Paoli se ne va di casa e scopre il mondo: la musica, i bordelli, i peggiori bar di Caracas (“Ho vissuto la strada, e la strada, specie in una città dura come Genova, ti insegna tanto. Ho anche fatto la fame”).

Scopre il rock n’ roll, che gli cambia la vita. Nel 1959 incide i suoi primi 45 giri (tra cui “Senza parole” e “Sassi”) con Nanni Ricordi. Poi si aprono gli anni ’60 e parte una giostra da vertigini. Il cielo in una stanza che tutti hanno fissato almeno una volta, il sapore di mare che tutti ricordano. Il decennio è folle. “Era il momento in cui la musica iniziava a dire qualcosa […]. Si poteva cominciare a esprimere un pensiero. A essere artisti, insomma”. Anche nella vita. Attraverso gli incontri. Dell’amico fraterno Luigi Tenco scrive, sovvertendo la narrazione per decenni imperante: “Luigi era un gigantesco caz*one, uno che amava gli scherzi, che magari si atteggiava a cantante maledetto, ma che poi nella vita di tutti i giorni era tutt’altro che così”. Ogni pagina del libro è priva di veli. Con “Il cielo in una stanza” Paoli voleva “descrivere un orgasmo” (non “rappresentarlo”, alla Donna Summer), con Ornella Vanoni, “la cantante della mala milanese”, il rapporto è stato fugace ma decisivo (i due si sentono ancora adesso, con il beneplacito di Paola, la moglie di Gino Paoli), con Stefania Sandrelli è stato “un amore a cento all’ora, a tutta velocità, in contromano. Per di più inseguiti dai paparazzi”. Paoli e i media. Oggi ci avrebbe chiamati “giornalai”. La stampa distrusse l’amico Umberto Bindi, lui non ha mai dimenticato: “L’hanno massacrato nel momento più alto della sua carriera, quando aveva già inciso brani splendidi come “Arrivederci” e “Il nostro concerto”. Il colpo di grazia glielo dette una giornalista che lo mise alla berlina per la sua omosessualità”.

Paoli riflette su una sfilata di grandi personaggi della seconda metà del Novecento italiano (Adriano Celentano, Lucio Dalla, Enzo Jannacci, Marcello Mastroianni, Fabrizio De André). Il tono però non è quello grave di una pedante celebrazione, piuttosto quello di un ricordo franco dentro il quale risiede un rapporto, una relazione, una forma di connessione (o disconnessione; vedi l’Adriano nazionale e il suo Clan). Umana e artistica. Il tutto immerso in una pozione vitale, spesso godereccia ma a tratti autodistruttiva. La pallottola, per dire: “La Derringer calibro 5 ha la canna lunga, più sostenuta. Per sicurezza, prima esplodo un altro colpo sul materasso. È quella giusta. Mi stendo, me la punto al cuore. Faccio un respiro. Premo il grilletto. Sento un dolore pazzesco, come se una montagna mi fosse precipitata sul petto, e poi più niente”. Ma ce n’è un’altra di pallottola, quella che uccise Tenco: “Se fossi stato lì con lui, le cose sarebbero andate diversamente, glielo avrei impedito a Luigi, gli avrei dato due pedate nel culo e la cosa sarebbe finita lì. Ma purtroppo mesi e mesi prima era successo quello che era successo”. Ossia che Tenco era andato a letto con Stefania Sandrelli, sabotando così la storica amicizia con un Paoli a cui la fama provocava anche grandi fastidi. Minacciò un redattore del rotocalco “Stop” di entrare al giornale (la sede era in pieno centro di Milano) e disfargli l’ufficio a colpi di mazza da baseball. Paoli, il viscerale. Il manesco. C’è anche lui, nel libro. Quello che, senza sapere chi fosse il suo avversario, fece a pugni col capo della mala del Brenta (“finì con una bella bevuta”). Paoli, il debole: “Per vent’anni me ne sono scolata una bottiglia al giorno (di whisky, nda). L’alcol mi cambiava, a volte mi rendeva aggressivo. Una mina vagante. E rischiavo di attaccare briga con le persone sbagliate”. Appunto. Si capisce meglio, oggi, perché tanti anni fa Paoli vide in Vasco Rossi una sorta di erede. Se “Cosa farò da grande” fosse un film, sarebbe un bizzarro e sguaiato incrocio fra “Amici miei” e “Milano Calibro 9”. Dino Risi o Mario Monicelli, il regista ideale a metterlo su pellicola. Con un finale, forse inatteso, sulle note della “Bohème”: “Nell’ultimo atto, quando lei muore ma tutti credono che stia ancora dormendo, io inevitabilmente piango. Ogni volta”.