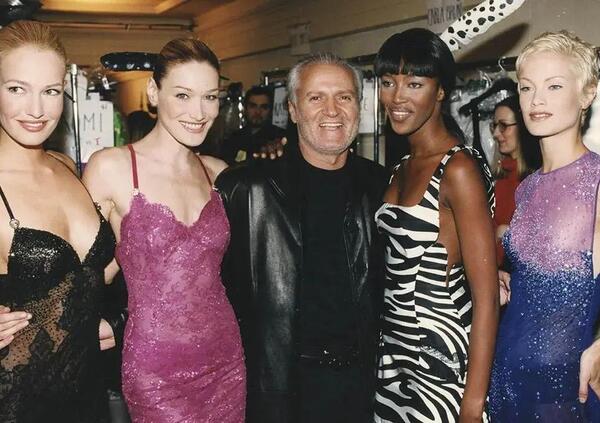“Senza pietà. Questo è un film crudo. Sì ok, le scene comiche degli esiliati nella Laf che sembra un manicomio stile nido del cuculo... ma sono novanta minuti di pugni in bocca. Fai che ti ritrovi sul ring contro Mike Tyson che ti cinghia di ganci e montanti per un'ora e mezza”. Questo è il commento che viene fuori fumando una sigaretta tra compari dopo aver visto il primo film di Michele Riondino, Palazzina Laf, starring egli medesimo e il socio Elio Germano, il primo caso di mobbing aziendale in Italia, avvenuto a fine Anni Novanta dentro l'acciaieria di Taranto, che era appena passata dall'essere la statalizzata Italsider alla privata Ilva della famiglia Riva. La vicenda è davvero triste: a seguito della ristrutturazione aziendale, alcuni dipendenti altamente qualificati (informatici, periti, ingegneri, impiegati) vengono demansionati e relegati in una palazzina abbandonata, la palazzina Laf (Laminatoio a freddo), nella quale passano le giornate senza poter fare un bel niente. Letteralmente otto ore di vuoto. La proposta dei vertici dirigenziali è: se volete tornare a lavorare davvero, venite a fare gli operai. Cokeria, forni elettrici, decapaggio, avete un’ampia scelta! Ah non siete operai e rischiereste di morire già durante l'affiancamento? Beh, si muore un po’ per poter vivere... I lavoratori non cedono. Non firmano accordi. Piuttosto impazziscono tra quelle quattro mura arrugginite e arrossate degli scarti di minerale. La narrazione cinematografica è semplice ma geniale: Riondino è Caterino Lamanna, operaio addetto alla pulizia forni che vive in una masseria diroccata, che diventa un delatore per conto di Elio Germano, aka Giancarlo Basile, un dirigente-kapò convinto, aziendalista nel midollo. Caterino passerà alla direzione Ilva informazioni sensibili sugli scioperi e sulle azioni di subbuglio che si svolgono dentro la palazzina LAF. Un infame al soldo del padrone, in pratica. Già dalla scena di apertura esce fuori la storia di Taranto: inquadrature potenti del mosaico nella chiesa Gesù Divin Lavoratore dei Tamburi raffigurante Cristo che si innalza sugli altoforni dell'Ilva e benedice gli accoliti operai, accompagnate dalle marce della processione dei Misteri di Taranto, un momento mistico e a tratti drammatico della religiosità ionica, che si svolge durante il periodo pasquale. Basta questa scena per dire ok, ci siamo, hai già vinto a mani basse Michele Riondì.

Ma c’è tutto un mondo, dietro. Palazzina Laf è un racconto sia universale che maledettamente territoriale. Universale perché mostra le nefandezze, lo schifo del potere padronale, dei pochi incravattati che pasteggiano sulle vite degli operai. Non può non salirti un moto di rivolta quando vedi gli abusi che subiscono i confinati nella Laf, devi trattenerti per non uscire dalla sala e sparare un paio di colpi di magnum 94 contro le portinerie dell'Ilva, o quantomeno di gettare una boccia d'acqua contro lo schermo del multisala. Territoriale perché non è uno spot per Taranto ma mostra ciò che ha fatto l'Ilva a Taranto, a livello ambientale e sociale. Non c'è un singolo momento cartolina dove si mostrino le bellezze di Taranto. Niente centro storico, niente lungomare, niente Circummarpiccolo o retaggi magnogreci. Solo strade sporche di minerale, pensiline sfondate, altoforni, campagne una volta rigogliose che vivono pett’a petto con la diossina, quartieri abbandonati, bar degrado. E così doveva essere. Del compatimento del pubblico che pensa “beh però ok le ciminiere ma Taranto sembra bellissima!”, beh, non sappiamo proprio che farcene, noi tarantini. Vogliamo che ci guardiate negli occhi per quello che siamo, non per quello che potremmo (potevamo?) essere. Volete capire i pervasivi e perversi meccanismi del potere che gestivano l'affaire Ilva di Taranto? Guardatevi ‘sto film. Volete farvi salire in testa un po’ di attitudine da barricaderos che lottano contro le malefatte del mondo? Guardatevi ‘sto film. È un film coraggioso. Perché parla di un argomento scomodo. Perché tutta la copertura mediatica non ha risolto ancora un bel niente della vicenda Ilva. Perché mostra la connivenza dei sindacati: è vero che grazie a un sindacalista la storia del film prende una piega risolutiva, finanche positiva, ma sono stati i sindacati a firmare gli accordi che hanno condotto alla gestione criminale dell'Ilva. Troppo spesso abbiamo sentito parole di stima verso la famiglia Riva che controllava l'Ilva, sebbene poi più processi ne abbiano accertato lo schifo combinato in termini di disastro aziendale e colonialismo lavorativo. Lo stesso Vittorio Feltri, dalla sua pacifica dimora nel bergamasco, sentenziava con frasi aride in stile sciacalli di Confindustria sull'Ilva e sulla gestione dei Riva. Dei signori, dei benefattori, della gente perbene, i Riva: “Meglio morire sicuramente di fame o forse di tumore?”, diceva in un editoriale. Il problema, Vittorio, è che questa scelta non dovrebbe proprio porsi. Meglio fermarsi qui, ché sennò ci arrivano querele.

E tiene ragione uno degli attori nel film, quando affacciato da un pontile osserva lo scenario intorno all'Ilva e dice: “Qua non ci sta manco una fabbrica di forchette e siamo l'azienda che produce più acciaio in Europa. Sai perché? Perché noi non ci arricchiamo. Noi produciamo ricchezza per gli altri e a noi rimane solo la monnezza”. Il malessere ti pervade durante tutto il film. L'ansia di entrare in un luogo e starci obbligatoriamente senza fare un cazzo per otto ore della tua vita, che man mano si accorcia sempre di più, giorno dopo giorno, la senti stretta attorno al collo in ogni fotogramma, come una garrota. In ogni scena. Nessuno dovrebbe vivere così. Nessuno dovrebbe lavorare inalando diossina, benzopirene e cocktail siderurgici vari. La cosa triste è che alla prima del film, a Taranto, la sala era pressoché deserta. Eravamo una quarantina di persone. Forse. Invece è un film che dovrebbe essere riprodotto sulle facciate dei palazzi, dovrebbero obbligare i tarantini a guardarlo tipo il trattamento Ludovico Van in arancia meccanica. “Vabbè, ci facciamo una birra?”, “No uagnu', devo rientrare che domani tengo il turno di mattina”. Taranto è umida, abbastanza vuota di giovedì sera. I lampioni pisciano luce arancione sulle strade bagnate. Coi compari ci salutiamo, amari e pensierosi. Ripensiamo alle manifestazioni ambientaliste, alle denunce prese per difendere la nostra città, agli striscioni, alle assemblee finite in malora. Nessuno ci ha mai fatto sconti, in questa città. Sarebbe anche l'ora, però, che presentassimo il conto da pagare a chi per anni ci ha vilipeso, inquinato e sfruttato. Un applauso a Michele Riondino per averci regalato un film cattivo, che grida verità, che rende onore a Taranto.