Non è facile scrivere un libro come Chi dice e chi tace (Sellerio) di Chiara Valerio, arrivato al Premio Strega come favorito. Le sciocchezze, le improntitudini, le banalità, gli errori più elementari, gli strafalcioni in italiano e le autentiche castronerie sono tali che nessuna mente normale è in grado di concepirle tutte insieme. Ci vuole talento vero. Sellerio, storicamente molto riluttante a spendere soldi preziosi in pubblicità, ha comprato addirittura pagine intere per promuoverlo, affastellando giudizi di “amici della domina” essi stessi degni di un premio speciale all’impudenza. Paolo Di Paolo, un altro Antonio D’Orrico che come lui vede capolavori dappertutto, scrive in evidente stato confusionale che l’autrice “gioca con il noir e un po’ lo trasforma o ne rivela l’essenza”; Valeria Parrella va oltre e parla addirittura di “rapporto tra Vita Sackville-West e Virginia Woolf” e ci vede (ma solo lei) “qualcosa di quell’eleganza e di quei giardini, di quella lentezza e di quell’antichità di frequentazioni”; Gino Ruozzi sul Sole 24Ore alza ancora di più l’asticella ed è pirotecnico quando parla senza rossore di “romanzo di seduzioni e reticenze che riprende accenti e atmosfere di Amado e García Márquez, María de Zayas y Sotomayor (una che scriveva solo racconti, nda) e Natalia Ginzburg”; Massimo Gramellini la butta come al solito sulla sick-lit e stabilisce che non essendo l’amore possesso ma cura, il romanzo è “una grande storia d’amore come cura”, lasciando al lettore di capire bene la terapia; Marco Malvaldi, debitore della Sellerio, trova una formula da mago brillo: “Le frasi di Chiara Valerio sono finestre piene di pezzetti di specchio e chi legge si trova lì, a cercare di distinguere tra il resto del mondo e se stesso” (cercare non i pezzetti di vetro, dunque?), ed effetto diverso non sortisce Antonio Manzini, altro devoto selleriano: “Formidabile meccanismo narrativo che non lascia scampo e che ci mette di fronte alle nostre ossessioni” (boom!). Dacia Maraini, sempre generosa ed eccessiva nel suonare il piffero a qualsiasi autrice, parla di “narrazione che incanta con le fantasmagorie”, mentre Jhumpa Lahiri scomoda oltre alla Ginzburg anche Leonardo Sciascia e Letizia Pezzali straparla di “romanzo letterario che è al tempo stesso alto e accessibile”. In altre parole né carne né pesce. Ed è in effetti questo il giudizio più appropriato.
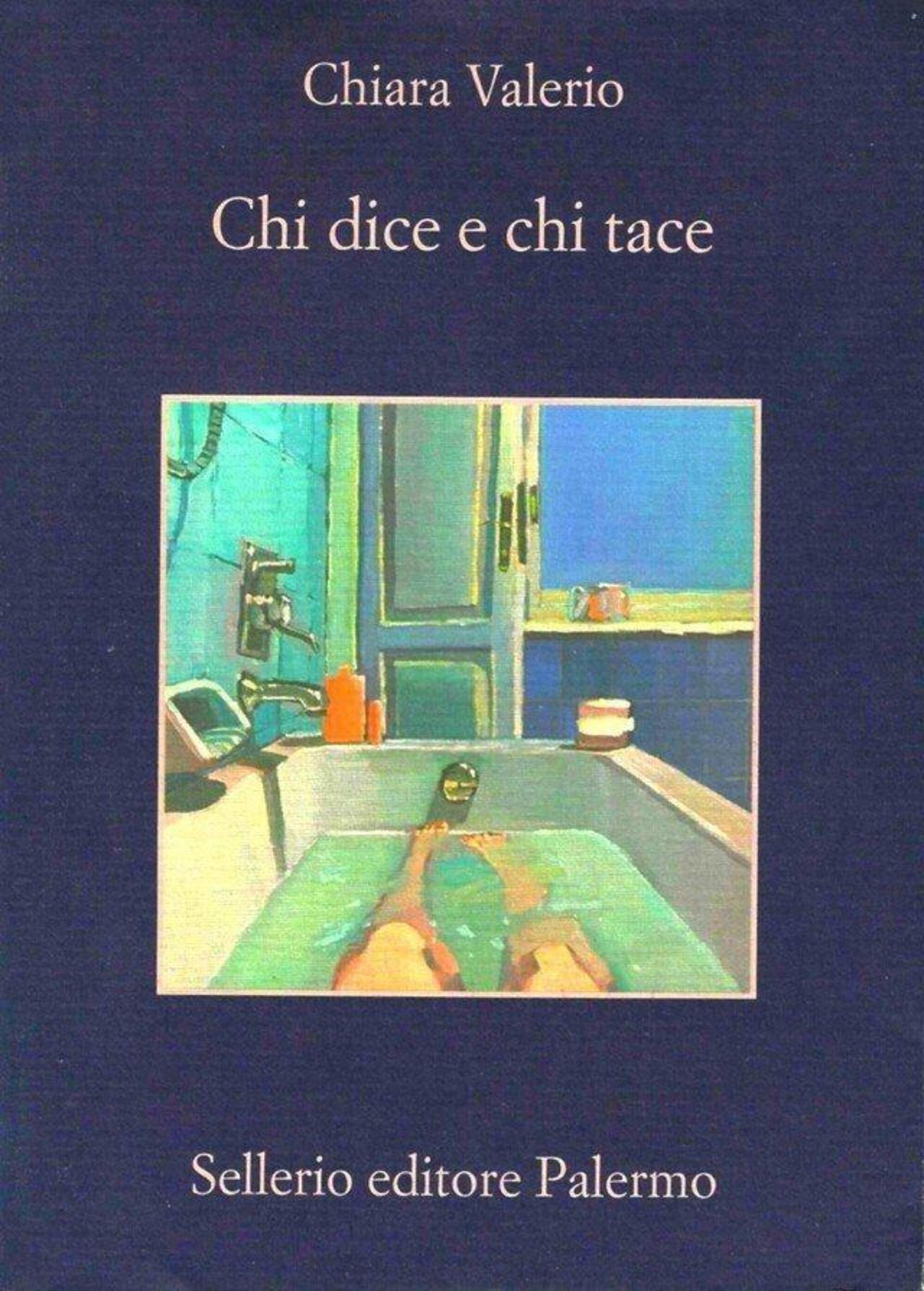
Sin dal titolo, il romanzo appare infatti un ibrido: vorrebbe essere un noir nella cui cifra stabilire “la metà oscura” di uomini e cose, o magari uno spaccato di tipo esistenzialistico, se non un thriller nel quale cercare un intrigo o un giallo che abbia un colpevole, oppure un mystery che circonfonda la realtà in una nebulosa sospesa tra realtà e astrazione, fatta di silenzi e reticenze, che dia conto di una comunità colta in una precisa epoca a cavallo degli anni Settanta e Ottanta, ma a conti fatti non è che uno sforzo, vano e velleitario, di fissare valori assoluti, cosmogonie, modelli generali. La scelta della Valerio, oggi divenuta di moda, di scimmiottare José Saramago senza averne le qualità, eliminando ogni punteggiatura che non siano punto, virgola e punto interrogativo, rende incomprensibile il testo, ancor più perché l’uso permanente del trapassato prossimo, gestito al di fuori di ogni consecutio temporum, e il ricorso a ripetute e improvvise analessi impediscono una scansione diacronica dei fatti che perciò risultano spalmati in una unica dimensione temporale. La gran confusione creata è aggravata dall’impossibilità di distinguere il tempo della narrazione da quello della scrittura. Trattandosi di un romanzo il cui narratore è una “io narrante”, abbiamo che se il primo è quello uniforme di un passato simile a una glaciazione temporale, il secondo è del tutto indeterminato, eppure è molto presente, dal momento che leggiamo passi del tipo: “Non sono più già in grado di dire”, “ci sono cose che oggi le donne possono fare e che quando ero ragazza io negli anni Sessanta non si potevano fare”, “il giardino della casa dove Mara e Vittoria vivevano non era bello come adesso”, “oggi come allora. Bandiere colorate, festoni”. Quand’è l’oggi? In che tempo insomma scrive l’io narrante? Quale distacco temporale tra i fatti narrati e il momento della loro narrazione il lettore deve immaginare? Se l’io narrante si identifica con l’autrice, che scriva quindi ai nostri giorni, dovrebbe essere quasi novantenne. E non lo è. Se invece l’io narrante è la voce di una narratrice che scrive a ridosso dei fatti, ciò che appare più plausibile, non si spiega la grande differenza che essa stessa pone nell’indicare i cambiamenti profondi di luoghi e di usi comuni. Il risultato è un totale frastornamento del lettore che perde sia la bussola per orientarsi nelle diverse età che la bilancia per pesare i tanti fatti intrecciati: anche perché, essendo il trapassato prossimo un tempo che implica un’azione avvenuta prima ancora di un’altra anch’essa passata, egli aspetta che l’io narrante torni prima o poi a quella meno remota, che costituirebbe il principale tempo della narrazione, ciò che però non avviene mai. Se ci si mettono pure la mancanza di un peritesto che aiuti la lettura con una punteggiatura adeguata, l’assenza del tempo della scrittura e l’uso della proposizione soprattutto nominale, asintattica, il celebrato romanzo della Valerio appare un testo del tutto illeggibile.

Quanto alla trama, la morte per annegamento nella vasca da bagno di una farmacista ultrasessantenne sui generis di nome Vittoria Basile, una che crea medicinali dalle erbe e dai fiori e quindi anche veleni, prefigura da parte dell’avvocato Lea Russo, l’io narrante, un’inchiesta che postula un omicidio o una fine avvolta in qualche mistero oscuro: per cui il lettore ne segue il racconto aspettando la svolta ed escludendo la soluzione che gli viene in mente sin dal primo momento, essendo davvero troppo banale, e cioè che la donna si sia suicidata con uno dei veleni che coltivava in giardino. Ritenendo che Lea Russo non sia una grulla, perché capirebbe subito quanto egli immagina appena sa di erbe coltivate in proprio e di farmaci galenici, il lettore aspetta la spannung, il colpo di scena o la mossa del cavallo. E invece non solo scopre che la donna si è suicidata come lui aveva supposto, ma si rende anche conto che Lea Russo indaga per sapere semplicemente se è stata davvero attratta da Vittoria, lesbica dichiarata, ex amante di un’altra lesbica, Rebecca, e compagna di una nuova, Mara, che rende erede. Dal noir che dunque si pensava di dover leggere si precipita al romance più sciocco e puerile. Dove il marito di Vittoria, un ricco avvocato, risulta un pervertito, e un’amica insospettabile, Filomena, appare in odore anche lei di omosessualità., salvo poi uscire allo scoperto e dichiarare che le piace “il pesce”. Un trauma se non è una presa in giro. Chiara Valerio ha scritto un romance camuffato in un romanzo a chiave, concependo una storia d’amore diverticolare e multiforme, tutta di genere saffico: che non è nemmeno di forti sentimenti e sentiti struggimenti, quanto di superficiali e scontate ricerche interiori, di processi di autoconoscenza, di banali interrogativi coscienziali, opera di donne che dicono mezze verità e tacciono grandi rivelazioni, da cui il titolo. Un romanzo dunque tutto femminile, fin troppo femminile, scritto con uno stile femminile e basato su una fabula sostenuta dalla coincidenza, elemento che non dovrebbe mai entrare in un romanzo. Il marito di Vittoria è lo stesso che da avvocato assiste un ragazzo romano, che è pure suo nipote, accusato di aver picchiato un coetaneo di Scauri difeso dalla Russo. La quale si trova per le mani una polaroid che mostra il primo ragazzo lanciare una bottiglia contro il secondo su una spiaggia dove si vede Vittoria che cammina. Potenza del caso! Più facile azzeccare un sei al Superenalotto. La trama è dopotutto un’infilata di sorprese al di là del verosimile. Lo stesso marito ha conosciuto Rebecca e Mara e con questa è stato pure a letto, anzi l’ha violentata, anche se è una prostituta, atto dopo il quale la moglie, Vittoria, dice a lei “ora mi occupo io di te” e se la porta a vivere per vent’anni a Scauri. Dove c’è Lea che fa l’avvocato e che, guarda caso, Vittoria ha voluto che avesse il suo testamento, nel quale dispone anche che una preziosa opera del Canova sia consegnata a una certa Rebecca. E che fa la nostra avvocatessa per trovare questa Rebecca? La cerca sull’elenco telefonico di Roma, due tomi grossi così che si porta pure a casa quando poi deve cercare anche una certa persona di cui ha solo l’iniziale e un indirizzo, Via Tagliamento, scritti su un biglietto di treno trovato nei pantaloni appartenuti a Vittoria che Mara le ha concesso di prendere in ricordo. Riesce a trovarla e quando Rebecca Lanza la riceve le dice che l’aspettava, certa che avrebbe seguito le tracce che portavano a lei. La vita è proprio incredibile nel romanzo della Valerio.

I suoi personaggi sono ancora più incredibili: tutti modelli pronti a indossare ogni abito, figurine con cento facce e quindi nessun carattere. Lea Russo è una che non sa nemmeno perché si chieda le cause della morte di Vittoria. Il fatto che Mara, la fidanzata di Vittoria, le dica all’inizio che lei piaceva a Vittoria (perché assomigliava a Rebecca, il primo grande amore) la porta a volere fare giustizia adombrando un omicidio di cui però non c’è oggettivamente il minimo indizio. È una che come tema di riflessione, nel pieno della sua indagine, si pone le mutande: se si tolgono con due mani abbassandole o prima da una gamba e poi dall’altra. È una che si dice: “Mi salivano domande che non mi sono mai fatta”, che pensa che “la madre non è certissima nel cattolicesimo. Di Gesù per esempio è più certo il padre”. Al funerale di Vittoria, vedendo gli scauresi da un lato e gli “stranieri” da un altro, è capace di concepire pensieri come questo: “Se la chiesa fosse stata un traghetto per Ponza e noi automobili sarebbe stato sbilanciato”. È una che avvicinandosi al marito per abbracciarlo scopre che “al calore del suo corpo si aggiungeva il tepore delle coperte dalle quali era uscito” e che, dopo l’espediente delle strisce di stoffa per tenere uniti i bambini inventato dalla maestra, pensa che “così i bambini sembravano i mille piedi di un millepiedi”. Non è poi donna di grandi letture, se per spiegarsi la grazia con cui i danzatori svolgono esercizi di grande fatica richiama un’intervista di Carla Fracci che diceva di guardare i loro piedi e non Baldassarre Castiglione e la sua “sprezzatura”. E come avvocato si capisce perché ha un solo cliente, il padre del ragazzino pestato: invece di “transazione” parla di “conciliazione economica”, confonde il procedimento penale con la causa, chiama “dichiarazione limpida di intenzione” quella che giuridicamente è “manifestazione di volontà” e arriva a sostenere con un altro avvocato (che non le dice in faccia “asina”, anzi in un’altra occasione le fa “visto che le piace tanto la legge”) che l’usucapione si possa trasferire ai conviventi. Nemmeno una matricola. Quest’altro avvocato, anche lui un’arca di scienza, è Giorgio Pontecorvo, il marito di Vittoria che non vede da vent’anni, che non ha mai cercato e della quale alla morte vuole però il corpo da seppellire a Roma, senonché questa intenzione non si sa che epilogo abbia, perché l’autrice se ne dimentica. Dice che non tornerà mai più a Scauri e poi ci torna altre due volte. Difende un nipote manesco e offre quindici milioni di lire per transarre così da non “insozzare la fedina penale”, espressione che un avvocato non userebbe mai. È un galantuomo dai modi ricercati avvezzo in età più agile a ubriacarsi, a tenere festini dai quali si torna a casa nudi, un crapulone che gode sapendo che la moglie va a letto con altre donne e che fa battute da saputello di seconda media: quando apprende che le Onoranze funebri di Scauri si chiamano “Paradiso” esclama: “Voi quindi a Scauri quando morite andate tutti in Paradiso?”, oppure dice così a Lea che gli oppone che il suo assistito voleva con un colpo di bottiglia spaccare la testa al proprio: “Come ci insegna Machiavelli per colpire un bersaglio devi mirare più in alto, dunque tecnicamente il mio assistito non ha mirato alla testa ma sopra la testa del suo assistito”. E dopo che Lea gli dice che “Roma non era la casa che Vittoria aveva scelto”, domanda: “Sineddoche o metonimia? La casa per me o me per la casa?”: Ovviamente Lea, stordita, cambia discorso. Vittoria poi, l’ambiguità fatta persona. Ha un pollice verdissimo, è una brava farmacista che crea medicinali, un ottimo medico, un’appassionata di nautica e una imbattibile giocatrice di carte. Il paese la ama, ma poi è padre Michele il primo a dire che è morta e pace all’anima sua. Quando scopre di avere un tumore terminale al pancreas decide di suicidarsi con un suo intruglio e si lascia morire per qualche motivo nuda nella vasca da bagno: però non vuole che la sua giovane Mara sappia del cancro (e perché?) preferendo evidentemente che si faccia mille domande, che sia pure sospettata di omicidio da Lea, e finisca per diventare una alcolizzata. Un gesto il suicidio che una come Vittoria non avrebbe mai commesso, ma serve alla Valerio per innescare una parvenza di thriller che si ferma poi alle sole intenzioni. Il romanzo fa acqua da tutte le parti, ma per Grandi&Associati, l’agenzia proponente, e la Sellerio è perlomeno da Premio Strega. I dialoghi sono la parte peggiore, come tra sordi o svampiti, prova di totale incongruenza. Dice per esempio Mara a Lea: “Non importa il senso in cui ti piace qualcosa, importa che ti piaccia e alla fine, quando ti piace e ti avvicini abbastanza, ci finisci dentro”. Il concetto vale anche per le persone: avvicinandosi troppo ad esse ci si finisce dentro. Però, secondo la filosofia dell’io narrante, “quando si è amato assolutamente, ci si può ignorare assolutamente”, quindi si può finire dentro le persone ma si può anche uscirne? La stessa Mara dice poi a Lea: “Tu fai un lavoro dove non esiste né la verità di Dio né quella delle mani (sic!), esiste solo la verità del processo, no Le’?” e Lea dovrebbe rispondere ripetendo quanto ha già detto a Vittoria, cioè che per lei “il diritto è un luogo dove la verità non vale più niente”, invece tace sdegnosa. I dialoghi tuttavia impallidiscono di fronte alle tirate alle quali l’io narrante indulge a ogni piè sospinto. Bastano alcuni brani deliranti. “…E la mia voce che ricordava Sono stati amanti. Così, per togliere di mezzo almeno me stessa, avevo sussurrato espirando insieme al fumo Sono stati amanti, e a quel punto avevo capito. La comprensione era un peso in mezzo alle gambe e in uno sforzo di equilibrio non avevo sentito arrivare Luigi”. Quando decide di aprire da sola il testamento si fa venire un’idea per giustificarsi: “Avrei detto, se qualcuno me lo avesse chiesto, che ero in uno stato di confusione e che quella confusione era dovuta a una profonda emozione. Scorgevo il nastro di una vita possibile e inattuata che mi si era srotolata (la vita?, non il nastro?) a fianco leggera, fraintesa come un fiore di lycra tra i seni.” Ancora: “Quando lo scalpiccio dei passi oltre la porta aveva scacciato i ritocchi dell’orologio che aveva scandito le nostre reticenze, Pontecorvo si era voltato rapido come un serpente e di un serpente aveva gli occhi”. Dei professori universitari che a Napoli chiamano avvocato anche le matricole, l’io narrante spiega che lo fanno “allungando la seconda a fino quasi a perdere senso e suono ma regalandoti l’idea che qualcuno ti veda già lungo il corridoio lucido di un tribunale, vincitrice, dopo una causa”. “Nemmeno la salsedine riusciva a coprire l’odore di stantio che le stava attorno come un cane zoppo ma fedele”. “Mia nonna mi aveva mandato a Minturno a comprare due loculi, uno per lei, uno per nonno, quando avevo dieci anni”. “Mara si era alzata ed era uscita, seguita da Filomena. Non aveva detto arrivederci e non aveva fatto rumore. Aveva raggiunto la sua voce fuori”. Non è per niente facile. Sorvoliamo sulla lingua italiana (“una cane latrava”, “pleid” anziché plaid, “sole donne” invece che “soltanto donne”, “febbri tifoidi” piuttosto che tifoidee, “sterrare il corpo” e non riesumare, bottiglie che riverberano suoni), ma come si spiega il prodigio di Lea Russo che, mentre apre con la chiave un portone, vede a distanza scendere da una macchina “un uomo elegante e anziano, alto, dinoccolato, con gli occhi di un verde slavato, il dorso delle mani macchiato dal tempo e l’interno dell’indice e del medio della mano destra scuri di nicotina”? La nostra protagonista ha mille difetti, ma certo ha un occhio di falco. Qualcosa da salvare? Una frase soltanto, se non è una citazione: “Per essere belli bisogna tramontare”. Ma non può valere da sola nemmeno la candidatura allo Strega.














