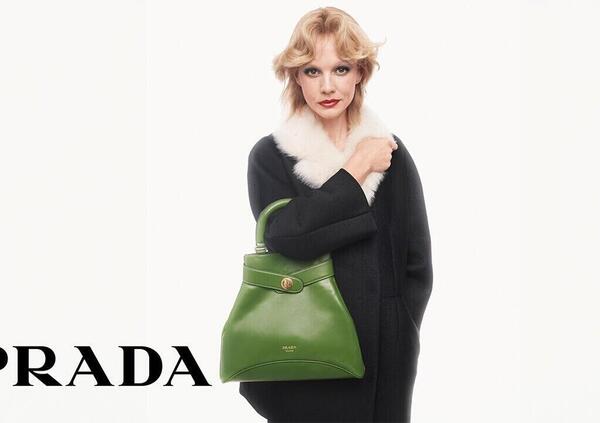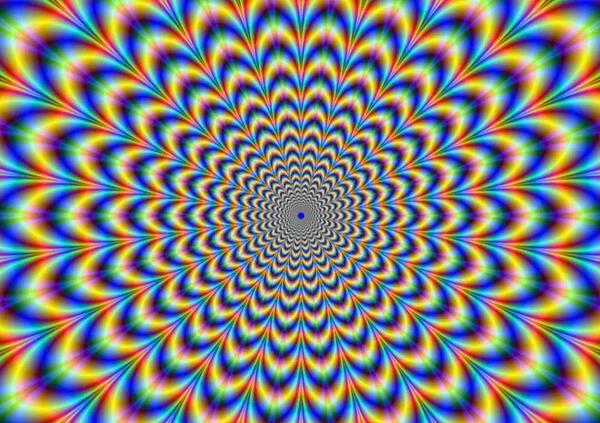I Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes vennero scritti e raccolto, secondo il loro autore, per una necessità lampante: “Il discorso amoroso è oggi d’una estrema solitudine”. E pare proprio che La mediocrità illustrata ai cocker spaniel di Fulvio Abbate risponda a questa solitudine, a questo isolamento volontario (che non è autoesilio, è più un’autocoscienza; anche se il termine, ineludibilmente hegeliano, potrebbe non piacere all’autore). Una prima nota storico-cronistica a favore di questo giudizio, che è invece estetico: il libro è stato rifiutato da Quodlibet edizioni, la casa editrice degli allievi di Giorgio Agamben, nota per titoli pirotecnici e copertine monocolore, ma soprattutto per un catalogo della filosofia che fu, Emil Lask, Enzo Melandri, Emilio Garroni. Allora, la sua Mediocrità, Fulvio Abbate ha scelto di pubblicarsela da solo, con Capitano Sicuro Editore, seguendo la provocazione (ma anche intuizione) dello scrittore Ottavio Cappellani, che ha, come si dice in gergo, scalato le classifiche dei libri più venduti su Amazon. E anche Abbate cresce, com’era inevitabile che fosse. Poi, dopo la nota di cronaca, la nota musicale, un’assonanza strana: autocoscienza e autopubblicazione, cioè due forme dell’estrema solitudine su cui pare poggiare quest’ultima riflessione di Abbate, che non riguarda davvero, come si potrebbe credere dal titolo, la mediocrità, ma l’intelligenza, quasi reinventando con maggior sense of humor quelle 309 stanze, rimaste anonime, di un poema di fine Quattrocento. Insomma, alla maniera situazionista.


Così, nel “fragmentarium” di Abbate trovano spazio non solo la Scuola di Francoforte, a suo modo sconfitta, o perché suicida (Walter Benjamin) o perché rifiutata (Theodore Adorno) o perché sussunta dai moti e dal movimentismo (Herbert Marcuse); ma anche Giulio Giorello, un genio dal talento rocambolesco, che sapeva tenere insieme Tex, la fisica quantistica, la matematica, le nuove logiche, la storia della filosofia e il liberalismo (si pensi al suo Lo spettro e il libertino). E ancora: Feyerebend, che è un po’ il detonatore filosofico della strategia bellica di Abbate ai tempi del Grande Fratello: “Ospite di un reality televisivo concentrazionario l’uomo è accusato di cambiare spesso opinione sui residenti della ‘casa’. Fiducioso nelle qualità intellettive altrui, cita allora il filosofo austriaco Paul Feyerabend, cui si deve il concetto di ‘anarchismo metodologico’, testualmente: ‘La coerenza appartiene a chi non ha idee’. L’Ospite, per dare forza al discorso, aggiunge che la frase appena pronunciata appartiene a un ‘epistemologo’ (sic)” [frammento 22]. Come si vede, si parla di mediocrità attraverso uno sfoggio di intelligenza, un divertisment quasi allegorico, perché ironico, intertestuale. Si potrebbe quasi dire, del modo di ragionare di Fulvio Abbate, ciò che Marx diceva del comunismo: una negazione della negazione. E la negazione della società in cui si vive sempre in trend, cioè sulla cresta dell’onda, o comunque sulla cresta di qualcosa, in superficie, (e tutto questo è, appunto, una negazione), è proprio l’estrema solitudine dell’essere persona: “la Persona è bene che sostituisca le merci” [frammento 30]. E ancora: “Essere persona” [frammento 31].

Tra le righe di questo “discorso amoroso” verso l’intelligenza e avverso alla mediocrità, ci sono poi intuizioni da estrapolare. Come l’idea di un progresso che, alla maniera delle religioni monoteiste, potrebbe aver fermato il Tempo, o potrebbe aver sposato la causa dell’immutabilità [frammento 37]. O come l’idea che il fascismo sia questa elevazione della mediocrità, “quasi che il ‘gallone’, i ‘baffi’, detto in gergo da porta carraia, palazzina comando, armeria e ufficio maggiorità, restituisca effettiva autorità, pensiero” [frammento 38]. Dopotutto non è mediocre chi pone le domande che gli altri non pongono (mentre gli altri si chiedono, come scrive sempre Abbate: “In che senso?” [Frammento 26]). Per esempio eccone una: “Chissà se Padre Pio, orco santo del Meridione eternamente contadino, di cui si dice sia apparso d’improvviso in volo a un pilota di cacciabombardiere Alleato convincendolo a non liberare il suo carico sul Gargano, era ‘intelligente’?” [Frammento 58]. Ecco il sottile filo del discorso (che è forte in sé, non è chi lo tira a essere forte, parafrasando Antonio Porchia): se la mediocrità oggi è alimentata dalla società del trend, dalla società dei social (una negazione), e se la mediocrità è pure virtù (ed è virtù solo in quel contesto) fascista, cioè dell’obbedienza e della gerarchia, allora sarà possibile individuarne la traccia nei fossili moderni di questo nuovo impero fatto di immagini e sintesi: “L’intera storia del pensiero filosofico, della letteratura, dell’arte cancellate in un soffio dalle emoticon. L’emoticon, segno di complicità, sospende il pensiero critico, reificandolo in ‘pensierino’. L’emoticon nega il conflitto” [Frammento 96].