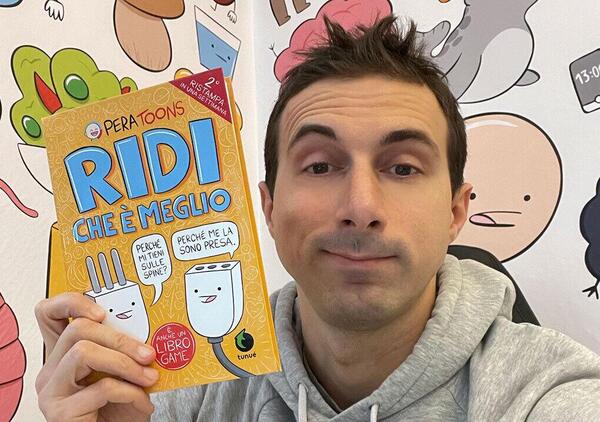Raggiungo telefonicamente Giancarlo Dimaggio mentre sta guidando ed è un fiume in piena. Psichiatra e psicoterapeuta, socio fondatore del Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Roma, risponde alle domande, argomenta, controbatte, ride. Ride spesso. Col suo ultimo libro Un attimo prima di cadere (Raffaello Cortina) si mette a nudo e racconta sé stesso. Spiega l’importanza di fermarsi un attimo prima di crollare perché è lì – in quell’attimo – che si può generare un big bang emozionale che può dar vita a una nuova versione di noi. Una versione migliore.
Partiamo dal titolo del tuo ultimo libro. Cos’è l’attimo prima di cadere e come lo riconosciamo?
L’attimo prima di cadere è un concetto centrale per la psicoterapia, ma anche per la vita di tutti i giorni. Lo riconosciamo quando mettiamo in atto dei tentativi di autocura che servono a proteggerci da forme di dolore nucleare o da emozioni negative che abbiamo su noi stessi e che pensiamo di non riuscire a gestire.
Facendo un esempio?
Immagina di voler uscire con una ragazza che ti piace tanto, la inviti ma poi all’ultimo momento disdici perché una parte di te è certa che ti troverà noioso o ridicolo. Ecco, noioso e ridicolo sono i concetti nucleari che hai di te, quindi ti vergogni e quindi fuggi.
E dov’è l’attimo prima di cadere?
L’attimo prima di cadere è il momento in cui riesci – grazie alla terapia - a riconoscere che stai per mettere in atto quegli automatismi di difesa. Se resisti si apre una finestra sul concetto nucleare che hai di te e ci puoi lavorare sopra, migliorarti, assumere il controllo su ogni tua azione.
Un’innovazione per la psicoterapia?
Diciamo che con questa lettura la psicoterapia può diventare più incisiva ed efficace. Mi spiego: io posso andare a ritroso, parlare dei rapporti con i genitori, con i fratelli, ma questo deve diventare un’informazione per capire cosa accade nella mente della persona nell’attimo prima di…

Il libro viene presentato come metà saggio e metà romanzo.
Dobbiamo partire dalla motivazione che mi ha portato a scriverlo che è il non voler cedere alle sterzate della vita. Penso alla perdita di mia moglie. Avevo voglia di utilizzare quel dolore per poter dire qualcosa nel mondo della ricerca. Ho sperimentato su di me che determinate tecniche sono state molto più efficaci di alcune metodologie vecchie, ma dovevo capire come raccontarle. Non volevo scrivere un saggio scientifico. Avevo bisogno di raccontare questa parte emotiva e non me la sentivo di fare un semplice romanzo. Ho trovato questa soluzione ibrida e devo dire grazie all’editore che pubblicandomi ha dimostrato grande coraggio.
Si parla molto di corpo nel libro. Cosa pensi delle relazioni senza corpi, nella fluidità della rete?
Ho una posizione ambivalente a riguardo. Da un lato le chat, le app di incontro e via dicendo hanno un’utilità enorme in una società frammentata come la nostra dove è difficile incontrare persone affini. Avere accesso potenzialmente a tutto il mondo ti crea uno spazio salvifico e di respiro, anche in periodi di difficoltà come questo.
C’è ovviamente un altro lato della medaglia.
In quanto essere umani siamo selezionati dall’evoluzione per lo scambio intersoggettivo. Noi ci coordiniamo con gli altri attraverso le interazioni del nostro corpo e gli atteggiamenti. Senza questo scambio la comunicazione umana non ha significato. Se ti insulto di persona poi devo fare i conti con la tua faccia incazzata, con la tua reazione. Se ti mando un messaggio seduttivo devo poter capire dal tuo corpo se può iniziare qualcosa. Davanti a uno schermo invece basta un click per tirarsi fuori e diventa un gioco del quale si faticano a comprendere regole e responsabilità. La realtà a un certo punto deve rispecchiarsi nelle nostre azioni. Io posso essere forte a quanto voglio al Fantacalcio, ma è quando ho la palla tra i piedi che devo dimostrare di essere capace.
Quindi “non demonizziamo le relazioni digitali, ma…”
Quel “ma” deve ricordarci che se restiamo solo in quella dimensione non è una relazione vera.

Sempre parlando di corpi: da un anno non ci abbracciamo, non ci baciamo, abbiamo imparato a capire se una persona sta sorridendo da come si muovono le orecchie. Siamo cambiati?
Il cambiamento c’è e non deve essere per forza nocivo, perché in tutto sappiamo trovare delle opportunità. Ad esempio io ho scoperto la possibilità di poter tenere dei corsi online e ho incontrato persone che erano interessate a quello che facevo, ma che non potevano raggiungermi. Il punto è che c’è stato un impatto pazzesco su tutte le forme di sofferenza soggettiva; penso a depressione, ansia, ossessione, disturbi postraumatici e il danno è evidente perché siamo privati della connessione dello scambio fisico. Quando questa viene meno la mente automaticamente registra stress, preoccupazioni, reazioni difensive primitive.
E sul lungo termine che ripercussioni vedremo?
Non ne ho la minima idea, ma siccome determinate modalità di funzionamento sociale intersoggettivo sono biologicamente scritte dentro di noi mi viene da pensare che una volta finito tutto queste dinamiche si rigenereranno automaticamente.
Un intermezzo del libro si chiama “Vorrei le ginocchia di Batman”. Tra tutti i supereroi (e ce ne sono tanti) hai scelto il più dilaniato dai conflitti interni. È soltanto un caso?
(Ride nda). È l’ultima domanda al mondo che mi sarei aspettato, ma te ne sono grato perché mi costringi a pensarci. Diciamo che ci sono tanti motivi. Uno è quello che dici tu: Batman ha una capacità rara di rendere il rapporto fra eroe e vulnerabilità. Lui è il bene, ma è continuamente allo specchio col suo doppio negativo. Un rapporto col mostro che ti fa riconoscere la parte oscura dentro di te. Un secondo motivo è che nessuno nel mondo del fumetto ha le ginocchia forti come Batman. E va detto. E infine mi sono accorto che in realtà il mio è un atto di pura invidia. Io in un’altra vita sono Miller o Moore o Gaiman. Sono stato la new wave del fumetto americano. E questo libro mi ha dato l’opportunità di inserire Batman in una cosa scritta da me. Un omaggio se vuoi.

Nel libro dici che Il terapeuta deve inceppare i meccanismi protettivi messi in atto dal paziente ma che al tempo stesso il paziente deve darti il permesso di mettergli i bastoni tra le ruote. Scrivendo tanto di sport sono abituato a raccontare del valore educativo del fallimento. Ma è anche terapeutico?
Continuo nella metafora sportiva: tu che apprendi lo sport, per dare all’allenatore la possibilità di insegnarti, devi aprirti, devi mostrare l’errore e devi dire io questo non lo so fare e insegnami a farlo meglio. In altri termini devi autorizzare l’allenatore a forzarti nella ripetizione del gesto. Allo stesso modo il terapeuta deve essere messo nelle condizioni di farsi dire aiutami a capire, aiutami a prendere delle decisioni coscienti sulle mie azioni, portami lì. Devi esporre una parte vulnerabile di te a autorizzare l’altra persona ad aiutarti, a interrompere un meccanismo. E la terapia oggi ha bisogno di questa consapevolezza in cui il cambiamento terapeutico è frutto di un accordo consapevole cosciente e continuamente rinegoziato.
Hai seguito la vicenda di Alex Schwazer? Mentalmente come ci si rialza?
La vita di un atleta è limitata negli anni. Tu hai un numero di anni in cui il tuo corpo funziona al meglio e non hai seconde occasioni. In questi anni di stop il danno all’immagine lo recuperi. Quello che ha perso come atleta invece rientra nell’elaborazione del lutto. Si tratta di qualcosa che hai perso, che non torna indietro e non per colpa tua. E non esiste una risposta predefinita per superare quel dolore. Ognuno di noi si rompe in maniera diversa secondo delle linee di frattura predefinite. La sua reazione dipenderà da chi era prima di questo stop.