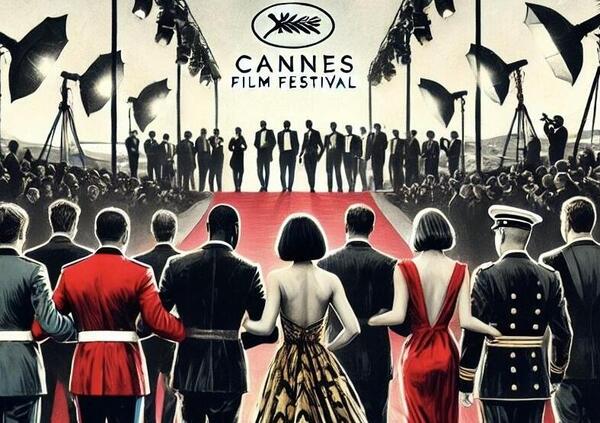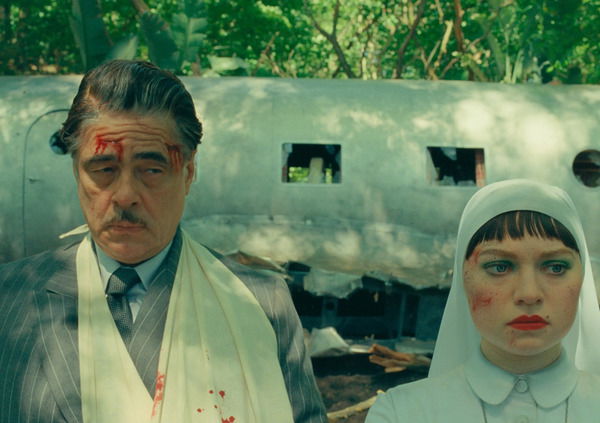Come sta il cinema italiano? Maluccio. Ve ne abbiamo parlato parecchio in queste settimane, in cui – per una volta – la cultura è stata davvero al centro del dibattito pubblico. Muccino, Avati, Germano e molti, moltissimi altri hanno preso parola, manifestando la loro preoccupazione per le sorti di ciò che, domani, potrà ancora essere chiamato “cinema”. Allo stesso tempo, però, non sono mancate analisi critiche sulla presunta “contradditorietà di questi artisti”, che – parlando a nome di operatori realmenti sfiniti da produzioni che non partono – avrebbero percepito comunque stipendi o cifre significative per i propri progetti. Appunto che tuttavia, per chi scrive, suona curioso. Dato che alla fine, quelle stesse polemiche mosse dagli artisti – da Moretti a Venezia con in mano il Leone per Ecce Bombo come miglior restauro, alle invettive più recenti prima e dopo i David di Donatello – sembrano piuttosto rivolte, con chiarezza, alle realtà più piccole. A chi il cinema comincia a farlo senza grosse garanzie dietro le spalle. Esattamente come ha detto Pupi Avati durante la cerimonia di premiazione più seguita d'Italia. Ad ogni modo, Libero ha posto l’accento sui cachet e sui numeri da capogiro in termini di finanziamenti e stipendi ricevuti da molti artisti recentemente intervenuti nel dibattito. Sul quotidiano si legge: “Sette miliardi e duecentocinquantacinque milioni più spiccioli. Questo è quanto il governo ha dato a fondo perso al cinema dal 2017, anno di grazia della pellicola grazie alla riforma dell’allora ministro alla Cultura, Dario Franceschini. È lui il messia che le star rimpiangono, l’uomo che ha moltiplicato gli incassi.” Naturalmente, il giornalista Pietro Senaldi non si riferisce agli incassi del botteghino, ma ai fondi pubblici stanziati per “rivitalizzare il settore”. Risorse che, circa nove anni fa, pare ammontassero a 400 milioni e che, nel 2021, dopo la pandemia, sarebbero cresciute fino a 980 milioni. “Oltre un miliardo e cento milioni nel 2023, per arrivare poi alla piccola correzione del 2024, quella che ha gettato nel panico i nostri vip delle sale.” E così, arrivando ai giorni nostri, la questione centrale è ancora l’annoso dibattito intorno al tax credit, lo sconto fiscale del 40% per le produzioni cinematografiche. Un meccanismo che, secondo molti, ha generato un’escalation non più sostenibile, portando il settore a una nuova crisi. Per Libero, questi dati dimostrerebbero che lo sforzo economico non ha risolto il problema del cinema italiano, ma è servito solo “a dopare un cavallo sfinito”, che ora non riesce più ad andare avanti se non “continuando ad aumentare le dosi.” Cifra importante anche lo stipendio di Elio Germano, che – per il ruolo in Berlinguer – avrebbe percepito 300mila euro, interpretazione che gli è valsa il David di Donatello come miglior attore protagonista. Numeri che, come anticipato, hanno alimentato ulteriori polemiche, sia dentro che fuori il mondo dello spettacolo.

Ma allora, perché oggi si torna a parlare così tanto della crisi del cinema? La maggioranza degli lavoratori del settore accusa il governo di tagliare i fondi all’arte. Perché? Libero ha una teoria precisa: “Le star la buttano in politica: non volete finanziarci perché siamo di sinistra.” Ma, come si legge nell’articolo, la spiegazione potrebbe essere anche un’altra. Tra i vari finanziamenti e aiuti alle sale cinematografiche e altro ancora, la causa di tanta criticità del settore andrebbe ritrovata “nel miliardo e 167 milioni che dal 2018 al 2024 le case di produzione hanno ottenuto dallo Stato sotto forma di tax credit (oltre il miliardo), contributi selettivi (più di 125 milioni) e reinvestimenti automatici (circa 35 milioni).” Quante opere sono state prodotte? Circa 1030. E poi proseguendo nella lettura, arriva un dubbio: “Tutto il carrozzone è costato tre miliardi e mezzo, visto che lo Stato ce ne ha messo 1,1 e gli incassi sono stati di mezzo miliardo, è possibile che produttori e registi ci abbiano smenato due miliardi?”. Il giornalista si interroga ancora. E se i costi in alcuni casi fossero stati inizialmente gonfiati per ottenere sconti fiscali su spese mai realmente sostenute? “E che quindi tutto si trasforma in un finanziamento indebito alle case di produzione meno oneste?”. In quest’ottica, ecco che le modifiche introdotte dalla sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, mirerebbero a portare più trasparenza: “Congruità dei soldi richiesti per prestazioni e divieto di appalti a cascata e fatture con nome dell’opera.” Tra le varie novità introdotte anche quella legata alla distribuzione. I film pare debbano impegnarsi a rimanere in sala il più possibile. Ancora, ridefinizione delle aliquote e i criteri di accesso al tax credit. Norme che forse non dovrebbero spaventare nessuno, in quanto atte a controllare gli sprechi, ma che comunque sollevano riflessioni. Perché viene da chiedersi se le restrizioni e i vari limiti introdotti colpiscano più i pesci piccoli, anziché i progetti dei grandi maestri. Come riporta Agi, l'avvocato Christian Collovà ha specificato dove potrebbe risiedere la falla. “Le nuove regole hanno identificato come criterio di discrimine quelle produzioni che al box office incassano meno rispetto all'investimento e lo ha trovato nei produttori indipendenti, che molto spesso dedicano invece le proprie energie a prodotti che non garantiscono un ritorno commerciale certo. Nell'assegnazione del tax credit si è così finito per preferire quei prodotti ad alto budget che sono sì prodotti da società italiane, ma di proprietà straniera, che continuano a beneficiare del tax credit di cui gli indipendenti italiani non possono più invece godere”. Giusto perché alla fine il rischio è che in tutto questo polverone a pagare – o a restare a casa – più che Avati o Moretti siano sempre i nuovi, i giovani, il cinema di domani. Stiamo a vedere.