Le emoticon e le emoji annienteranno la letteratura, uccideranno il romanzo, lo hanno già soppresso. Dunque, il pensiero, la dialettica, la filosofia stessa. Se fosse possibile estendere al linguaggio la legge che impedisca la ricostituzione d’ogni partito di ispirazione fascista, emoticon ed emoji andrebbero vietate; e un corpo speciale di vigilanza presto impiegato a punire (con sequestro di cellulari e d’ogni altro palmare) coloro che dovessero farne uso nella convinzione d’essere così empatici, “simpatici”, “ganzi”, “carucci”, “caruccetti”, cioè in possesso di opinioni attendibili, degne di nota sull’esistente.

Le emoji, cominciando dalla faccina che sussurra un cuoricino (e sue infinite varianti), da qualche tempo rappresentano una risposta a qualsiasi messaggio, affermazione, meglio se irrilevante, di tipo amicale. Accompagnando la fine della complessità e del Discorso stesso, come apoteosi semmai della comunicazione interpersonale più modesta, muretto virtuale. Che ve ne siano disponibili anche molte altre in apparenza iconicamente più dialettiche, pronte per l’uso lì nella tastiera, nella tasca virtuale, nella “sacchetta”, nel borsello, nella trousse dei cellulari (si pensi alla faccina che vomita verde bile), nulla toglie alla necessità, sia detto per misericordia e rispetto minimo dell’intelligenza, di abrogarle.
Le emoji rappresentano infatti il caposaldo di una prassi, un’ideologia portatile, presunta vicinanza sottobraccio, che in tutta evidenza è definibile “amichettismo”. Un fenomeno che, se riferito all’ambito letterario, governa ormai addirittura il presente romanzesco femminilizzato, treccine e forcine, portatore di un pensiero inutilmente ridente, in nome di una non meno stupida e compiacente complicità a sua volta sprizzante ancora amichettismo. In questo modo ogni affermazione, ogni post, “messaggino” si fa subito “romanzo”, a maggior ragione se brillante di inenarrabili banalità, trovando una sequenza indistinta di emoticon di plauso; incoraggiamento a persistere nel nulla. Il patto di comunanza, supportato dalla banalità di cui sopra, è infine salvo, e la comunità, la “cerchietta”, ciò che al tempo delle canzoni del sole da pullman era la “comitiva”, si conferma salda e complice nelle proprie assolute certezze men che irrilevanti, un qualcosa che semplificando potremmo definire pop, gusci vuoti degni delle icone tautologiche di Andy Warhol.

L’amichettismo di cui l’emoji è bandiera, metafora, logo, brand immediati e assoluti, lo ribadiamo, è il fenomeno letterario prevalente del decennio: narrazioni costruite su prevedibili e stentate autobiografie, destinate a produrre un grado meno zero di identificazione sentimentale, abbracci zoppicanti. La scrittrice amichettistica, già in adolescenza aspirante attrazione, metti, del vivaio di “Non è la Rai”, nutrita da “Lady Oscar” e “Heidi”, sente la necessità interiore di consegnare alla propria “amica”, lettrice siamese e complice, la propria storia che impone immediata identificazione. Ne seguono mozziconi di frasi che mostrano il plusvalore di una ulteriore complicità, patto di sangue e Nutella e Girella: “… dai, anche a me esattamente così, hai descritto alla perfezione quello che sentivo!” Segue emoji, faccina con cuoricino o piuttosto mani giunte, supplici, tra plauso e comprensione devota. La storia intera della letteratura, dall’Iliade a “L’uomo senza qualità”, in un attimo eccola cancellata dalle emoji.
L’emoji è segno di complicità, di adesione incondizionata al nulla, sospende ogni pensiero critico, lo tramuta in “pensierino”, ancor peggio nel caso in cui la faccina dovesse mostrare una lacrima o piuttosto la mano sul gomito a indicare perplessità…
L’emoji nega i conflitti, perfino quando mostra un teschietto o la pozione di veleno, non conserva memoria della storia pregressa, racconta un qui-e-ora insignificante, un qualcosa su cui neppure un maestro della semiologia quale Roland Barthes proverebbe a carotare; perfino la cartolina più ordinaria sul cui verso un tempo i ragazzi in bermuda e canottiera con la biro segnava una freccia accompagnata dal “Noi siamo qui!”, fosse anche la veduta del Lago di Resia con il campanile sommerso dalle acque, aveva più potenza dialettica di una qualsiasi faccina il cui intento è affermare una finta pace sociale, il penoso trionfo amicale, di più, una tombale pace letteraria, se è vero che le emoticon hanno sostituito perfino la critica letteraria, e chi dovesse muovere un’obiezione al “cuoricino” si sentirà dire che sta “rosicando”; e chissà com’è fatto l’emoticon di chi “rosica“ agli occhi delle amichette perdute in un’infinita adolescenza che si incammina sorridente verso il funerale appunto dell’intero pensiero critico, analitico.
Così a dispetto di Harvey Ball, l’inventore dello smiley, paradigma d’ogni emoticon o emoji a venire, peccato che inizialmente la sua faccina gialla fosse tra le icone della “controcultura”. Povero Ball, già eroe di Okinawa, insignito del titolo di "Veteran of the Year" dalla Worcester Veterans Council, che dopo la seconda guerra mondiale, inventò gli smile nel 1963, per una compagnia di assicurazioni con lo scopo di “accrescere il morale dei lavoratori, soprattutto se impegnati con i clienti”.
In nome delle emoji il lettore si ritrova infine trasformato in “groupie”.
Vero che la memoria può comprendere ogni cosa insieme al rimpianto, ma esistono pesi e misure, il pensiero non potra mai essere contenuto insieme alla storia della filosofia da nessuna emoticon. Alla fine è solo l’icona di un marketing sentimentale, amichettistico, ricattatorio, come mostra bene il capolavoro di Felpa Iemma, intitolato appunto “Le amichette”, la scrittrice che ha provato inutilmente a spiegare che l’emozione abita in un Altrove liberato dall’insincerità gne-gne, cip-cip, smack-smack.
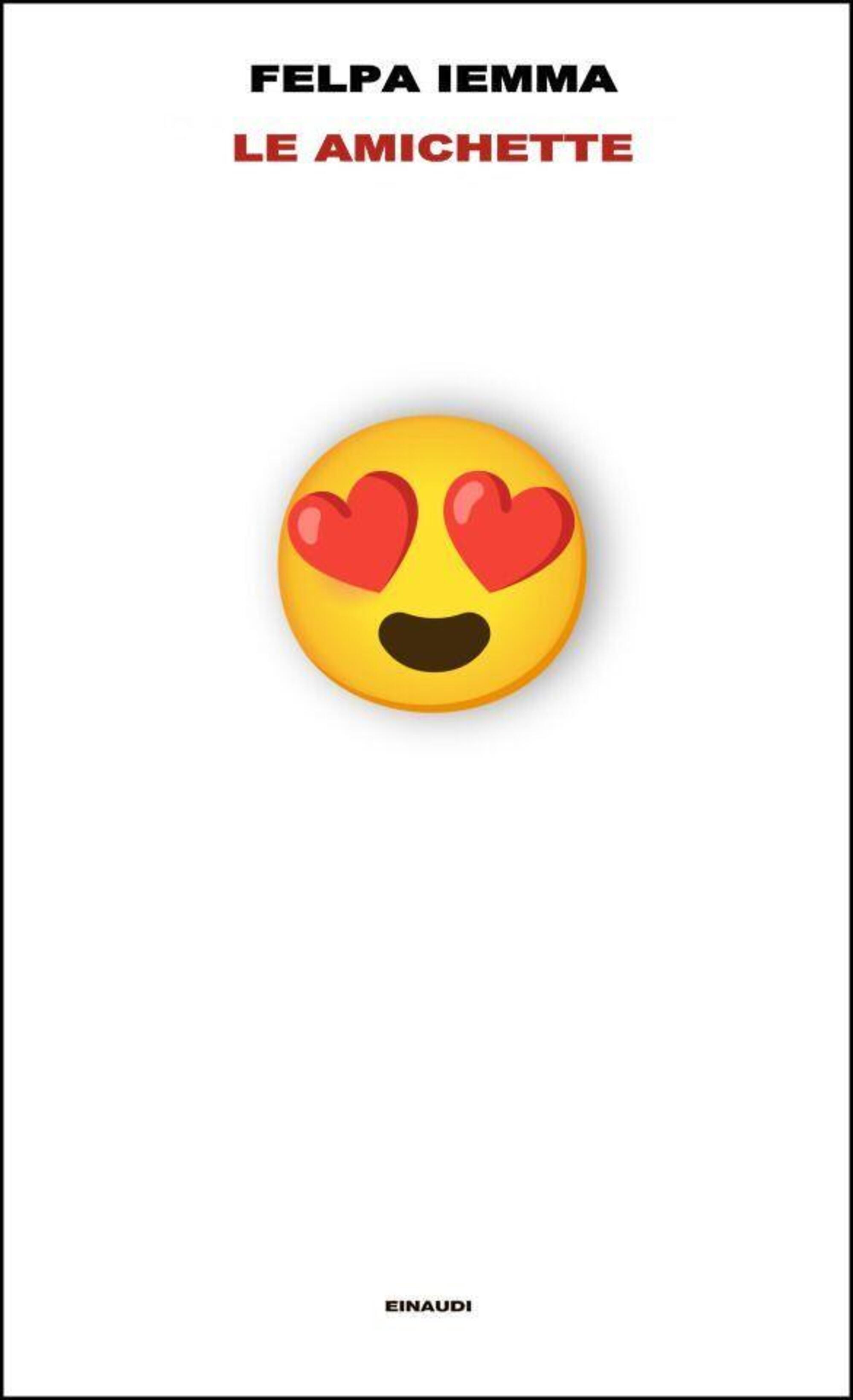


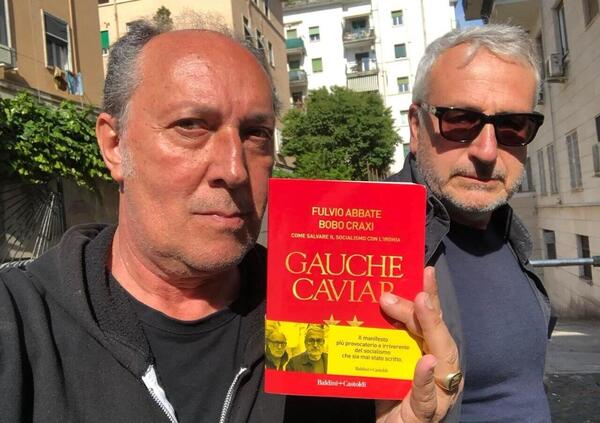









![Perché non è possibile dimenticare Raffaele La Capria? Ce lo spiegano tre poeti napoletani [VIDEO]](https://crm-img.stcrm.it/images/28848554/HOR_STD/600x/raffaele-la-capria.jpg)