In molti trasformano le parole in immagini, o almeno ci provano. Ma quando si ha di fronte un autore cult, che in più proviene da una cultura a noi lontana e per certi versi misteriosa, l’approccio è ben diverso dal solo “disegnare”. Lo sa bene Emiliano Ponzi, uno degli illustratori italiani più apprezzati al mondo, che però si è trovato di fronte una sfida impervia persino per lui: trasformare in immagini le parole di Haruki Murakami.
Lo scrittore giapponese, nei suoi romanzi e racconti ha creato un’infinità di mondi, e ne ha svelato ogni segreto ai lettori. C’è però una dimensione in cui non si è quasi mai avventurato: la sua vita. E con Abbandonare un gatto (Einaudi) per la prima volta ha raccontato della sua famiglia, in particolare di suo padre. Un ritratto toccante, il racconto sincero del «figlio qualunque di un uomo qualunque» e forse proprio per questo speciale.
E così non è stato facile tradurre in immagini questo delicato racconto autobiografico, come ci ha spiegato lo stesso Emiliano che abbiamo contattato per parlare di questo lavoro così importante (e perfettamente riuscito) e di come un illustratore deve approcciarsi al mondo di oggi scoprendo che, dopo aver cercato ispirazione in moltissimi elementi, non deve far altro che “guardarsi i suoi piedi”.
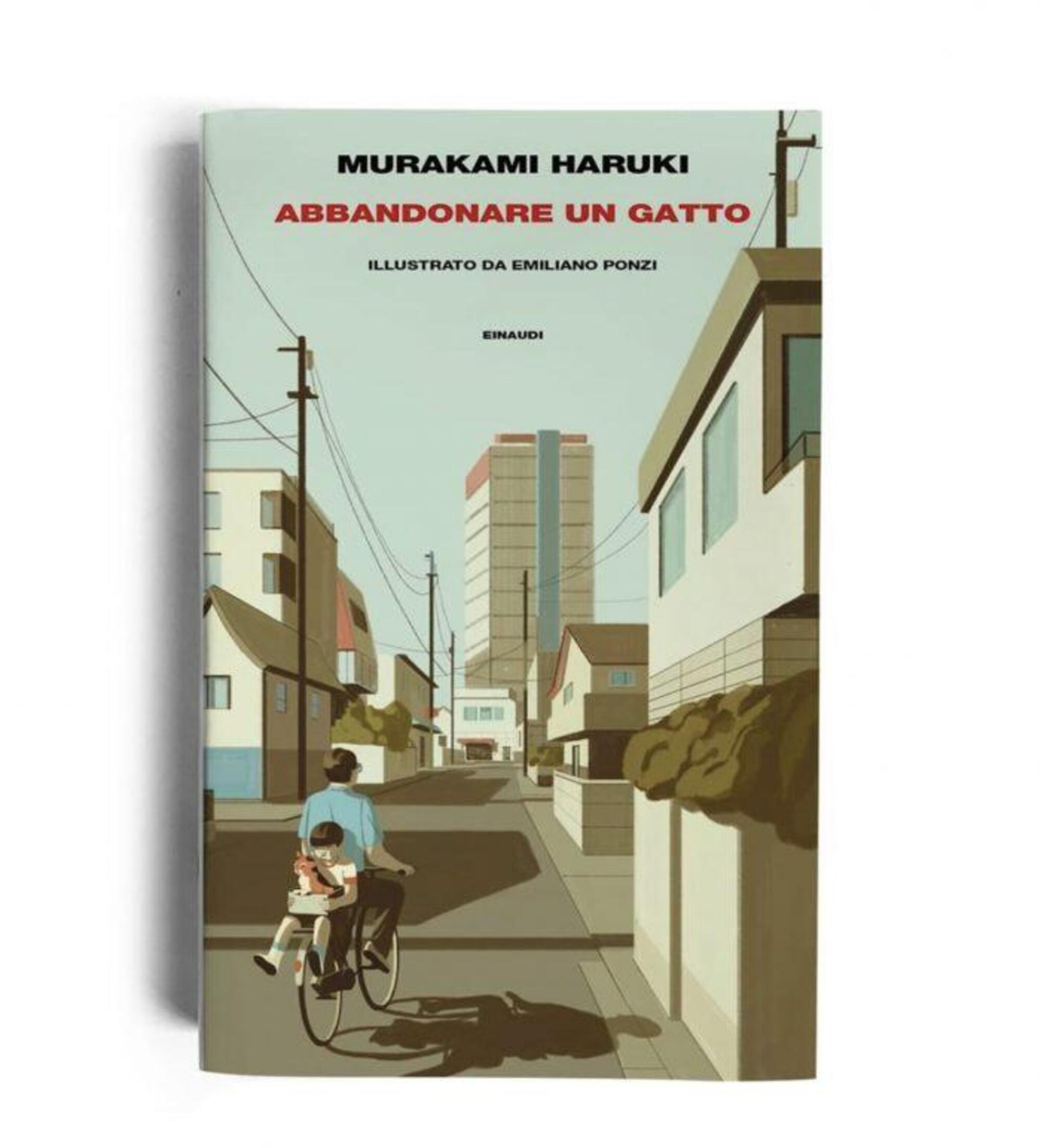
Emiliano, intanto come è avvenuto l’approccio con un autore così importante come Murakami?
Per il New Yorker avevo illustrato un estratto del romanzo uscito sul magazine in lingua inglese e quell’immagine era piaciuta a Murakami. Così si è realizzata questa congiunzione astrale, anche grazie a Einaudi con la quale già collaboro, e abbiamo iniziato l’avventura. Mi rende particolarmente orgoglioso che quando Murakami ha ricevuto tutto, ha risposto in un paio di giorni, mentre di solito ci mette molto di più, e non ha voluto cambiare nulla ma, anzi, ha subito chiesto di avere delle copie del libro. Interessante, poi, che Einaudi, un editore considerato molto classico e per un autore così importante, abbia scelto anche di realizzare un filtro Instagram, il “filtro Murakami”, con dei gatti che strizzano l’occhiolino e si moltiplicano proprio dalle mie illustrazioni.
Quali sono state le difficoltà maggiori di illustrare un romanzo così intenso?
Murakami è lo scrittore più importante del Giappone e il più tradotto al mondo, con uno stile riconosciuto. In più questa volta avrei dovuto rispettare una delicatezza del testo, che a differenza dei suoi precedenti non è fiction ma autobiografico. Infatti, parla dell’intimo rapporto con il padre, all’interno di una tradizione giapponese, la storia è ambientata al tempo della guerra, per cui ero di fronte a tutta l’iconicità di quelle atmosfere, di un mondo distante dal nostro e una ambientazione del passato. Quindi, ho recuperato molto materiale iconografico cercando di interpretarlo in modo credibile, sia per le situazioni e i sentimenti raccontati che per un libro che esce nel 2020.

Insomma, non basta saper disegnare per lavorare a questi livelli.
Saper disegnare bisogna darlo per scontato. Non stiamo parlando di livello buono o ottimo, perché disegnare “bene” è la conditio sine qua non e, sembrerà strano, c’entra poco con questo tipo di lavori. È molto più importante l’aspetto razionale. Per tenere un “tono di voce” in una serie di illustrazioni, cioè quando si parla di serialità, è necessaria una progettualità gigantesca: devi avere in mente i colori, le inquadrature, i personaggi, una coerenza stilistica che dia un senso a tutto quello che accompagnerà il testo. Le immagini devono essere in relazione al testo e fra di loro.
Come ti disse la photo editor Elisabeth Biondi: “un’immagine, sia essa foto o illustrazione, non deve raccontare il testo ma lo deve completare”.
È vero, ma fino a un certo punto. Questo vale per i magazine. Però penso anche che lo step successivo arrivi quando l’illustrazione riesce a vivere anche senza il testo. Il testo viene prima in certi casi, ma per dare pari dignità all’immagine bisogna cercare di farla camminare con le proprie gambe anche dopo. Cioè rendere un’opera senza un prima e senza un dopo.

Quali sono le tue ispirazioni?
Il viaggio è un vettore notevole di ispirazione perché scopriamo un “altro” da noi stessi. A me per questo lavoro con Murakami ha aiutato un viaggio di quasi un mese in Giappone. Ci sono dei silenzi, dei vuoti, che rimandano nello specifico a quella cultura. Ma la mia ispirazione più grande è l’essere affascinato da qualcosa che non c’entra niente con il lavoro che mi hanno commissionato e poi cercare di riportarlo nell’opera. Per esempio, le mie ossessioni per i colori vintage, per le tinte pastello, per le polaroid invecchiate, per le foto lasciate nel cassetto dalle nonne, erano perfette per sviluppare il libro di Murakami.
So che per un autore è sempre difficile, ma se dovessi scegliere un solo lavoro al quale sei più legato quale segnaleresti?
È un po’ come chiedere a quale figlio si vuole più bene, ma se avessi la pistola alla tempia, anche se sono passati 7 anni, sceglierei la serie di copertine per i libri di Bukowski per Feltrinelli. È stato da una parte un investimento di fiducia da parte dell’editore, poi ampiamente ripagato, dall’altra un gigantesco lavoro progettuale dove abbiamo deciso che lo scrittore sarebbe sempre stato presente come un attore sul palco. Ci sono nella vita dei gradini, nella nostra curva dell’apprendimento, e quello fu uno di quegli step. Quindi sceglierei quella serie.
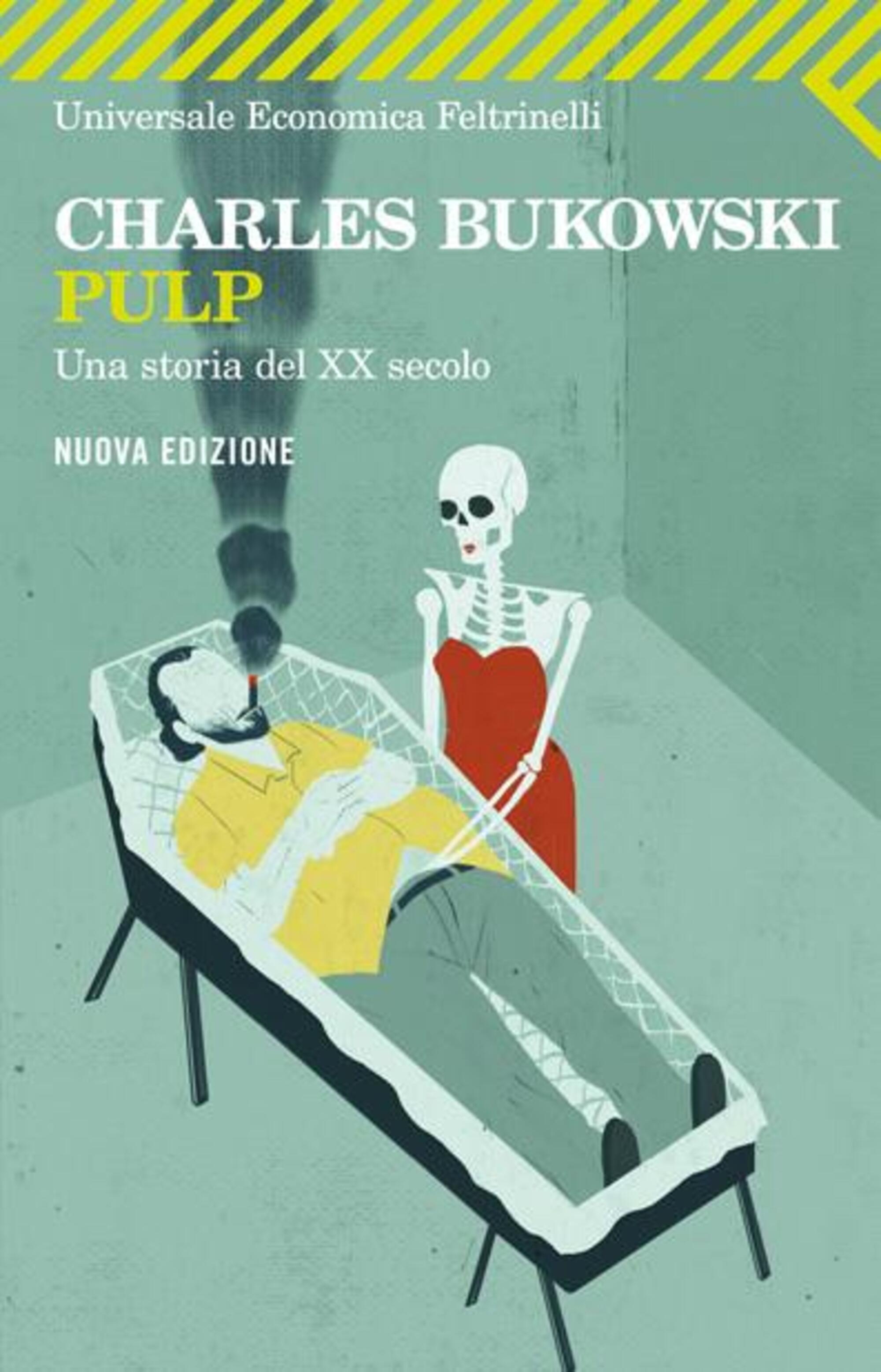
Con "Cronichles from the red zone" hai raccontato agli americani cosa gli sarebbe accaduto a breve a causa della pandemia, prendendo spunto da ciò che avveniva in Italia. Ora che siamo tornati in quell’incubo, per caso stai lavorando a qualcosa di simile?
Quel libro ha raccontato agli americani cosa li aspettava, visto che allora si sentivano al riparo. È stato un progetto abbastanza unico, visto che per noi era il primo lockdown, quindi raccoglieva emozioni vive, anche in negativo, visto che potevamo pensare che fosse una semplice influenza o che la fine del mondo. Se ora facessi qualcosa di simile mi sembrerebbe di speculare sulla pandemia, ho persino bloccato le presentazioni di quel libro e deciso che non toccherò più questo tema perché è passata quella sensazione corale che ci portavamo dentro.
In America molti magazine e da anni utilizzano le illustrazioni, mentre in Italia ci siamo arrivati solo da qualche anno. Siamo molto indietro?
Siamo tutto sommato a un buon livello, ma forse in Italia pecchiamo di provincialismo. Anche per ragioni pratiche, visto che quello americano è un mercato molto più grande di quello italiano. Per esempio, il New York Times chiama con disinvoltura illustratori molto diversi fra loro, una varietà dettata da ragioni culturali. Tendenzialmente in Italia c’è poca varietà culturale, per cui non viene vista come un valore aggiunto. Ma questa è una responsabilità di chi è nella “sala dei bottoni”, noi illustratori diciamo solo “sì” o “no” alle chiamate che ci arrivano.
A un giovane che si affaccia al mondo dell’illustrazione oggi, che consiglio daresti?
Di guardare a tutto quello che succede attraverso i social, ai trend di come viene rappresentato il mondo e poi di fregarsene. Deve provare a crearsi un suo linguaggio a prescindere, alla fine l’unico modo è “guardandosi i piedi” per durare nel tempo e riuscire a costruire un “tono di voce” che funzioni anche quando la moda del momento sarà finita.
Se siete arrivati fino a qui seguiteci ance su Facebook e su Instagram











