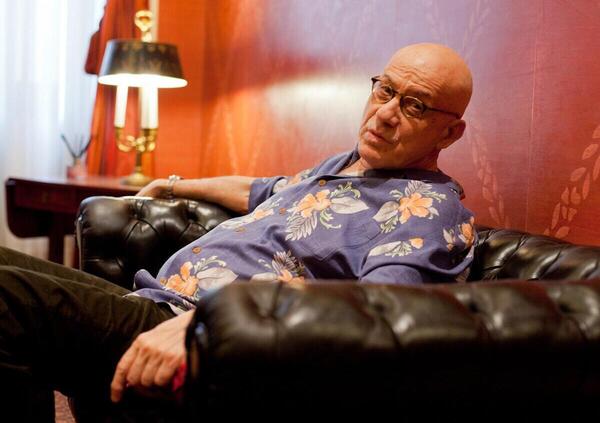Abbiamo incontrato Seba Pezzani in un piccolo caffè di Fidenza, cittadina vicina a Parma che sa come creare un’atmosfera con quattro strade, due botteghe e un bicchiere. Seba è innanzitutto un traduttore, ma scrive tanto. Da sempre. Giornalista, autore. Da anni è anche direttore artistico di uno splendido festival blues musical-letterario intitolato “Dal Mississippi al Po”, piatto prelibato offerto alla provincia piacentina. Collaborava con “L’Unità”, da circa 20 anni collabora con la pagina culturale de “Il Giornale”, oggi scrive anche per la rivista online “Globalist”. Con i RAB4, quando il tempo glielo concede, propone un rock “rootsy”, filologicamente americano. Perché la sua vita è intrisa di stelle e strisce, è intrisa dei pensieri e delle gesta dei tanti autori tradotti (Joe Lansdale, Jeffrey Archer, Jeffery Deaver, Anne Perry…), della tanta musica ascoltata e vissuta.
Sei un uomo di sinistra, da sempre. E collaboratore de “Il Giornale” da 20 anni circa. Come ti trovi?
Bene, mai avuto particolari problemi. Ci sono stati momenti più intensi di altri, ma questo è normale quando sei a contatto con una redazione. Ricordo ancora, anni e anni addietro, l’allora direttrice della pagina culturale che mi disse, con piglio bonario: “Mi raccomando, non parlare male di Bush, Putin e Israele. Ah, e di Berlusconi”. Così, quando scrivo per “Il Giornale”, sono abituato ad essere meno politico. Ma per me non è un problema. Mai avuto tessere di partito, e infatti anche oggi non mi identifico con l’attuale centro-sinistra. Sono un uomo di idee, non di partito. Con origini particolari, in questo senso…
Quali?
Vengo da una famiglia democristiana, anticomunista. Due genitori figli della guerra. Se guardavo alla famiglia di mia madre vedevo addirittura una Dc di destra, tipo “meglio il Duce che i comunisti, al governo”. Da parte di padre qualcosa di più soft, più sfumato. Mio padre poi, negli anni, è diventato antiberlusconiano.
Riferimenti che hai abbandonato presto.
Ma sì. Lo spauracchio comunista, in Italia, io non l’ho mai visto davvero. Ci sono più basi Nato da noi che nel resto del mondo, praticamente. Gli Stati Uniti ci avrebbero mai lasciati in mano ai Rossi?
Eh, appunto: gli Stati Uniti. Li hai letti, vissuti, tradotti, scritti. Come te la spieghi l’America di oggi?
Non me la spiego. O meglio, me la spiego ma con fatica. Dalla prima volta in cui ci sono andato (1996), ho visto le cose peggiorare. L’undici settembre fu un grande acceleratore della crisi, ma il declino era già iniziato. Oggi è un Paese sempre più avvitato su sé stesso, sempre più convinto della propria intrinseca superiorità e della perfezione del proprio modello politico. I miti del self-made man, il sogno americano. Tutte cose ancora reali, in parte, ma sempre più difficili da vedere concretizzate nella realtà. È un Paese distante dal resto dal mondo, “brainwashed”. Quando un americano si allontana dai propri confini per studiare rimane quasi esterrefatto. Si rende conto che c’è un altro mondo, una visione – o più visioni – che a casa propria sfiora appena.
Un atteggiamento che vedi riflettersi anche sull’attuale situazione mediorientale?
Certo. Si è immediatamente sposata l’idea che il 7 ottobre scorso l’attacco a Israele sia nato così, per caso. Che non esista un prima. Hamas, pur non rappresentando l’intera Palestina, è portavoce di una rabbia diffusa. Chiedi a un palestinese medio se si senta di condannare quanto è accaduto: non so quanti ti risponderebbero di sì. I palestinesi sono stati vilipesi e calpestati da quando esiste Israele. E Biden? Non sta neanche in piedi e la prima cosa che fa è andare ad abbracciare Netanyahu. Con i leader arabi, invece? Niente, nessun incontro.
E il famoso “americano medio” alla Homer Simpson, esiste?
Sì, ed è più ignorante dell’italiano o dell’europeo medio. Perché pensa di poter tranquillamente fare a meno del resto del mondo.

In tutta la letteratura americana che hai tradotto, hai rintracciato punti di vista meno geocentrici?
Certo che sì. Perché uno che scrive, in genere, ha vissuto. Ha una cultura. Però fondamentalmente l’americano si nutre di sentimenti patriottici. Una volta punzecchiai Joe Lansdale. Gli chiesi: ma se voi non foste sempre così aggressivi, a livello di politica estera, se allentaste il vostro controllo sugli altri, non credi che il gradimento su di voi crescerebbe? E lui: “Sì, ma abbiamo fatto un sacco di cose buone”. Stop. Anche perché poi loro sono affezionati all’idea che “fare un’opera di bene” cancelli tutto il resto. Situazione tipo: la Fondazione “x” distribuisce il pane ai senzatetto. Va bene, ma anche lo Stato dovrebbe farlo. Anche perché la Fondazione – si sa – fa solidarietà sociale per levarsi di dosso un po’ di tasse, per cui fa anche sorridere pensare che il poveraccio – che spesso è tale anche perché il presidente di quella Fondazione è ricchissimo – debba pure ringraziare il magnate privato che gli allunga un panino. E poi qui c’è una domanda assolutamente basic che si impone…
Quale?
La democrazia “migliore del mondo” non riesce ad esprimere due candidati più credibili, solidi e affidabili di Donald Trump e Joe Biden?
Qualcuno, ad esempio, che possa immaginare degli Stati Uniti diversi? Che si ponga in modo diverso davanti all’ennesima “imprevedibile” strage (penso a quella recentissima per mano di Robert Card, nel Maine: 18 morti, 13 feriti)?
Sono stragi orribili, a cui mai mi abituerò, ma non sono affatto sorprendenti. La politica americana, nella sua interezza, non ha alcuna intenzione di risolvere la questione. Sentire Biden chiedere al Congresso di far passare una nuova legge che renda ancora più vincolata e sorvegliata la vendita di armi fa ridere. Sa benissimo che non accadrà nulla. Non ha la maggioranza, ci sono decine di parlamentari e senatori democratici che gli voterebbero conto. L’ultima volta in cui ho davvero sperato che potesse cambiare qualcosa è stato in occasione della strage nella scuola elementare di Sandy Hook, nel Connecticut (2012). Ma anche in quella circostanza, dopo il lutto, lo scalpore e lo sdegno, nulla cambiò. Il primo giorno, stranamente, la National Rifle Association tacque. Questo fece credere a un momento di reale riflessione. Il giorno seguente diramò il suo solito comunicato con le solite vaccate di sempre: il problema, secondo loro, era che non c’erano i vigilantes davanti alla scuola, che gli insegnanti non erano armati fino ai denti, che le finestre non erano antiproiettile o a chiusura ermetica. E così via. Quindi nulla può cambiare. Anche perché la stragrande maggioranza degli americani cresce con l’idea che vivere armati sia normale. A un mio amico (americano), per il compleanno, il padre regalò una pistola. Lei non la desiderava, né tantomeno se l’aspettava. Ma sei scemo?
La politica americana ti irrita più di qualsiasi traduzione particolarmente ostica, ma quali sono gli autori che ti hanno fatto sudare di più?
Davanti a tutti Mark Twain. Scrittura molto stratificata, vari livelli di lettura a seconda di come calibra il suo umorismo. Doppi e tripli sensi. Tosto. Poi tempo fa mi ero imbattuto in un testo sul jazz di Nate Chinen. Difficilissimo, fitto di slang jazz spesso intraducibile. Il periodare era barocco, frasi di mezze pagine senza punteggiatura. Non so se lo tradurrei ancora.
E Jeffery Deaver, che hai già più volte portato in giro per l’Italia?
Non così semplice. Joe Lansdale, ad esempio, scrive come parla. Deaver invece si adagia su canoni abbastanza fissi che diventano particolarmente impegnativi soprattutto quando si sposta sulle indagini forensi. Malgrado lo conosca bene, a volte mi mette in difficoltà.

L’accusa che spesso si fa ai Deaver, ai Grisham, ai King, è di seguire fedelmente una formula.
Nel caso di Deaver il problema non si pone perché lui è il primo a non rigettare questo tipo di accusa. Lui ti spiega serenamente quale sia la formula del suo libro. Quali sono gli ingredienti utilizzati, quali sono i passaggi ineludibili. Però il colpo da maestro di genere lo piazza quasi sempre.
Nonostante i thriller italiani, i thriller nordici, tutti i thriller possibili, gli americani in questo genere continuano a essere leader. Perché? Questione di lingua, di mercato o territori?
È un genere che abbiamo importato da loro. Oltre all’americano, lingua che si presta molto ai dialoghi serrati, nei loro testi c’è la vivida rappresentazione di una cultura inimitabile. Noi siamo qui a parlare in un baretto di provincia, abbarbicati a un tavolino. Un luogo simile, negli States, lo trovi a malapena a New York. Magari due come noi, in questo esatto momento, in America, stanno dialogando seduti a un lungo tavolo rettangolare, in un diner fermo a “Happy days”, con fuori le insegne al neon. Un diner sperduto in un paesotto calato nel nulla, vicino al deserto.
“Happy days”… Hai fatto da interprete anche Henry Winkler, Fonzie.
Sì, Winkler ha scritto tanti libri per ragazzi dislessici. Lui stesso è dislessico. Siamo stati in giro tre giorni insieme: è una star, ma è gentilissimo, disponibilissimo, soprattutto con i ragazzi e le loro famiglie.
Ne hai accompagnati in giro tanti, di autori. Qualcuno con cui non è scattata alcuna scintilla?
Accompagnai Michael Crichton (“Congo”) a RadioDue. Lo trovai antipaticissimo, respingente, un fascistone. Stava facendo promozione per un romanzo in cui negava il problema del riscaldamento globale. Una volta, invece, al telefono, James Patterson, alla domanda del mio collega/amico Luca Crovi sul perché avesse tanto successo, rispose con un lapidario “perché sono bravo”, che a mio avviso è la risposta peggiore, quella che non dovresti mai dare. Poi parliamone, tra parentesi, della bravura di Patterson…
C’è qualche autore che ti piacerebbe tradurre?
Stephen King, che mi affascina molto, ma di cui ho letto poco. Fra poco, però, inizierò a tradurre il nuovo testo (“The distant echo”) di un’autrice scozzese, attivista LGBTQ+, che mi piace molto, Val McDermid. Di lei ho già tradotto “1979”, che presto uscirà anche da noi.
Visto che hai citato la comunità LGBTQ+, ritieni che le istanze e le politiche Woke stiano influenzando il modo di scrivere e di fare letteratura?
Mah, non c’è una nuova parola “ne*ro”, qualcosa che prima si poteva dire e adesso è tabù. Però lasciami dire – perché presumo tu voglia arrivare lì – che il politicamente corretto l’ho sempre visto come un modo, per i benpensanti di destra, di negare l’esistenza di un problema. E sulla cancel culture ti dico: io non abbatterei mai una statua, ma spiegherei chi è il soggetto di quella statua. Esci dalla stazione di Parma e nel parchetto davanti trovi la statua di Vittorio Bottego, figura ottocentesca, una sorta di eroe cittadino. Ecco, sotto quel simulacro piazzerei una targa in cui c’è scritto che Bottego è stato certamente un grande esploratore del continente africano, ma che là si è macchiato anche di diverse nefandezze. Non abbattiamola, la statua, ma spieghiamo qualcosa. Dopodiché ritradurre un libro di cento anni fa in cui si parlava di “ne*ri” e sostituire il termine incriminato con “afroamericano” mi sembra ridicolo, perché cent’anni fa non si parlava così. La Storia non si cambia, semmai si spiega e si contestualizza.
Anche attraverso il rock dei RAB4?
Anche. Quest’anno siamo usciti con “A dream away”. Ma ho anche altro per le mani: insieme a Tommaso Ghidini – uno dei massimi dirigenti della European Space Agency, ottimo divulgatore (ha anche pubblicato “Homo caelestis” per Longanesi) – ho portato lo scorso maggio al Planetarium di Amsterdam un progetto intitolato “Rocking space”. Io e i RAB4 eseguiamo brani “spaziali” (“Starman” di David Bowie, i Pink Floyd…) e Ghidini racconta al pubblico lo spazio, perché sia ancora importante viaggiare nello spazio. Lo scorso settembre abbiamo replicato qui, a Fidenza; nel febbraio 2024 saremo a Mannheim, in Germania. L’idea sarebbe di riuscire a toccare alcune capitali europee.