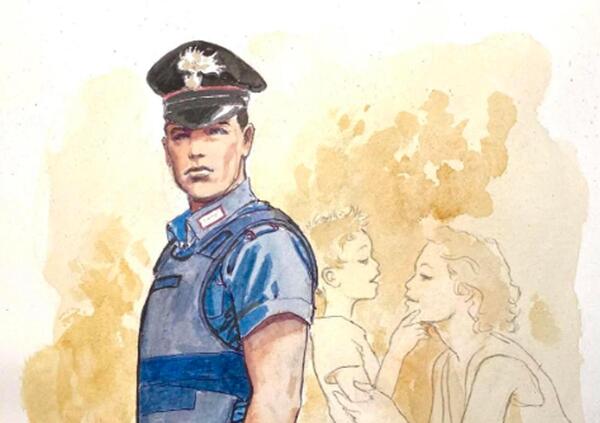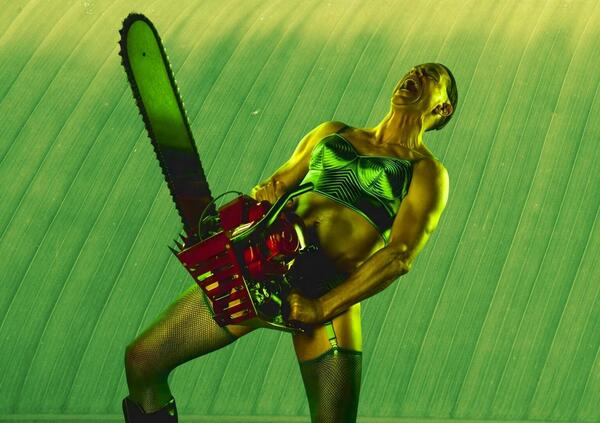Sono a Valencia per un ciclo di conferenze universitarie. Ovunque vada, qui tutti mi parlano di Remedios Zafra: "Devi leggere i suoi lavori". Cerco in rete e scopro che i suoi libri, non ancora tradotti in italiano, affrontano temi di urgenza capitale con un approccio inedito: una critica radicale al sistema burocratico e lavorativo che genera il "maltrattamento cognitivo" contemporaneo. Le scrivo, fissiamo un incontro, e sono sicuro che molto presto il suo lavoro diventerà centrale anche nel dibattito italiano.
In che misura la tristezza burocratica rappresenta non solo un sintomo del lavoro intellettuale oppresso dalla produttività iperbolica, ma una forma di alienazione esistenziale che erode l'essenza stessa dell'essere umano come creatore di idee e legami?
La tristezza burocratica non è una mera frustrazione emozionale, ma uno degli affetti che traduce la perdita del legame tra il pensare e il vivere, tra un lavoro intellettuale con senso e un lavoro intellettuale addomesticato. Per questo entrambe le suggestioni che proponi sono presenti, ma il rischio di erosione a cui alludi è il più inquietante. Nel mio libro [El informe] questa tristezza è un segnale del rischio di disaffezione nei lavori intellettuali. Un pericolo che pongo come asse centrale del testo, in quanto ciò che ci mobilita in questi lavori proviene da una passione creativa verso la ricerca di valore e senso, in ciò che facciamo e per coloro che ci circondano. La possibilità di cadere in un'alienazione esistenziale è qualcosa che mette a rischio non solo i lavoratori intellettuali, ma anche la società e la sua aspettativa nei confronti di questo lavoro, potendo disconnettere il pensiero (sottomesso alla logica della tecnoproduttività) dal suo potere creatore e relazionale. Credo che entrambe le considerazioni definiscano molto bene una problematica che non può essere semplificata come mera sovraccarico burocratico. Al contrario, qualcosa non funziona quando il nostro tempo non può essere dedicato allo scopo principale del nostro lavoro. Penso che il pericolo di distacco da esso sia una questione importante che non solo pone sul tavolo la possibilità di alienazione dei lavoratori, ma anche il rischio di invalidare la loro pratica, quando questa si converte in un surrogato, in numeri o in produzione senz'anima.
Come possiamo conciliare il "sì e no" che Lei propone – no alla violenza burocratica, sì alla liberazione del tempo proprio – con la tensione filosofica tra obbedienza e ribellione, evitando che il lavoro intellettuale si riduca a una mera sottomissione meccanica?
Viviamo un tempo che evita la tensione del contraddittorio, che nelle reti applaude la chiarezza di un posizionamento pacificatore e spesso manicheo, che stia in questa o in quella casella. Per me quell'allusione a Camus è un modo per valorizzare la necessità di formule che escano dalla catalogazione escludente, e che ci permettano di affrontare con ribellione il rifiuto di un'irrazionalità accettata come la pressione burocratica, ma che al contempo lo faccia in modo costruttivo senza cercare di distruggere il sistema amministrativo e pubblico in cui essa abitualmente si insedia. Ciò che propongo ha a che fare con la tentazione che abbiamo visto in questi anni da parte di governi e movimenti ultraliberali di stigmatizzare (e persino spettacolarizzare) la burocrazia, cercando sempre di equipararla all'amministrazione pubblica, volendo danneggiare tale sistema attraverso un attacco frontale e semplicistico alla burocrazia stessa. Ciò che propongo in El informe è una critica che parte dalla trasformazione e dal miglioramento, mossa da coloro che amano e difendono il sistema pubblico. Da un punto di vista critico, la ribellione può avvenire attraverso la disobbedienza critica o attraverso un'obbedienza insubordinata, intendendo che il lavoro intellettuale autentico non si piega né al potere né al capriccio, ma si mantiene nella frizione, nella tensione tra fedeltà al pensiero e resistenza al dispositivo che pretende di neutralizzarlo.
La disumanizzazione tecnologica descritta nel Suo libro evoca l'ombra del panottismo heideggeriano: le tecnologie contemporanee sono strumenti di emancipazione o catene invisibili che perpetuano il distacco tra individui, trasformando il sapere in mera amministrazione?
Le tecnologie contemporanee sono una struttura polivalente che può essere usata in modi molto diversi. Sebbene la tecnologia digitale mediata dagli schermi sia da tempo sottomessa al dominio mercantile di aziende che le gestiscono e le propongono come un miraggio di spazio pubblico, incoraggiando i cittadini al loro uso, generando dipendenza e conversione del soggetto in merce. Il predominio di queste forze non annulla le possibilità della tecnologia per accedere al sapere e alla comunicazione, così come per migliorare la vita di molte persone; tuttavia, l'attuale contesto digitale nelle reti pone un grave condizionamento essendosi normalizzati gli spazi, le piattaforme, le reti e i dispositivi senza il necessario controllo etico e senza la trasparenza richiesta. Come effetto, tendono a favorire l'individualismo e la disarticolazione comunitaria, ma anche il sapere nell'amministrazione. Forse una delle sfide del pensiero nel XXI secolo consiste nel restituire senso umanistico e valore etico alla tecnica di fronte al dominio mercantilista dell'algoritmo e dell'amministrazione del sapere.
Se il tempo proprio è il terreno fertile per generare idee migliori e un impegno per la giustizia e la cura, come giustificare filosoficamente la sottrazione di questo tempo da parte di un sistema burocratico che privilegia la quantificazione sul valore qualitativo dell'esistenza?
Mi sembra che la giustificazione per i processi di disumanizzazione possa essere intesa solo come parte del loro processo di disumanizzazione. Nella burocratizzazione del tempo si consuma il paradosso per cui la ragione che cercava di liberare e aiutare finisce per gestire la vita come se fosse un fascicolo e quindi disumanizzandoci. Quando si scopre l'errore, anziché mettere in discussione la ragione burocratica, si mette in discussione l'incompetenza delle persone, proiettando su di esse il sospetto e la colpa. Non riesco a immaginare una prigione maggiore che vivere in questa catena che si appropria di tempi per il buon lavoro e per la vita. Mai un sistema sostenuto esclusivamente o prevalentemente da logiche cumulative e quantitative potrà essere un sistema giusto per gli umani, per i quali il dubbio, l'ombra, la contraddizione e la complessità sono quotidiane nel loro approccio al mondo e alla loro esistenza come umani e non come ingranaggi automatizzati. Ed è curioso che, mentre molte tecnologie dichiarano di umanizzarsi con l'IA, molti umani si sentano meccanizzarsi in condizioni di lavoro e vita precarie.

Nel Suo lavoro, la tristezza amministrativa emerge come un affetto collettivo: è possibile interpretarla alla luce della filosofia delle passioni di Spinoza, come una tristezza passiva che diminuisce la potenza di agire, o piuttosto come un invito a una gioia attiva contro l'indifferenza sociale?
È molto interessante questa conversazione che suggerisci. Ed è fondamentale l'appunto di definire la tristezza amministrativa come qualcosa di "collettivo", ma aggiungerei che, pur correndo il rischio di spegnere la potenza di agire, questa tristezza si propone qui come una campana, come un richiamo all'attenzione che aiuti a sollevare molte braccia, molti "succede anche a me", come modo per attivare una molla comunitaria contro la rassegnazione. In questo senso, credo che per la filosofia questa tristezza potrebbe essere vista sia come il segno di una servitù affettiva, sia come uno stimolo per la libertà nel sapersi comunitaria e condivisa, e quindi in condizione di essere reclamata, rivista e trasformata.
Chi, secondo Lei, dovrebbe assumere il ruolo di “disturbatore” che ricorda all'essere umano la sua umanità, come si chiede nel libro? Questo non rimanda forse alla figura socratica del filosofo come tafano, disturbatore della comodità etica nel mondo del lavoro intellettuale?
In questo libro la figura del disturbatore che aiuta ad attivare la coscienza risiede nei lavoratori intellettuali e, se essi adempiono al loro compito, in una cittadinanza emancipata. Quel ruolo che nella filosofia classica spettava al filosofo è oggi ampliato a una moltitudine di agenti che si occupano di rendere il mondo riflessivo nell'educazione, nel pensiero, nell'arte e direi anche nella creazione di immaginari. Mi sembra importante che questi lavoratori assumano l'importanza del loro fare con senso e valore sociale per aiutare una società più libera. Ma che, come società, comprendiamo anche che è necessario che questi lavoratori (un tempo filosofi) non vengano addomesticati e spenti dalle routine tecno-produttive e competitive che ostacolano la loro azione. L'esercizio della perturbazione di cui parlo fa parte dell'attivazione di disagio necessaria per pensare le cose, per affrontare il mondo con estraneità e curiosità, per essere coscienti di un'esistenza veramente assunta. In alcuni dei miei saggi ho sviluppato questa idea come "il malessere buono", dove l'audacia del pensare opera come una forma di cura reciproca.

La Sua critica alla competizione e alla precarietà nel lavoro creativo digitale risuona con il concetto marxiano di alienazione del prodotto del lavoro: come possiamo trasformare questa alienazione in un'opportunità per una critica femminista e intersezionale che ridefinisca il valore del prendersi cura e del creare?
Sebbene in El informe non si approfondisca questo legame tra femminismo e critica all'alienazione a partire dal lavoro, sono questioni che per me sono correlate. Di fatto, dal mio libro Frágiles ho stabilito una serie di analogie tra patriarcato e tecnocapitalismo, cercando di posizionare il femminismo come orientamento verso un cambiamento sociale in cui la cura e la creazione acquistano un valore rinnovato. È un'idea che sviluppo anche in testi recenti sulla sintonia tra l'ascesa antifemminista degli attuali movimenti reazionari e la loro ascesa anti-intellettuale. Penso che pensare insieme lavoro intellettuale e femminismo sia ispiratore. Come pilastro di questo parallelismo risiede il modo in cui il patriarcato ha trasformato le donne in custodi di una morale più esigente per loro stesse, allo stesso modo in cui oggi ci fanno sentire che "ci va la vita" nel lavoro e che siamo responsabili di auto-sfruttarci. Altri punti in comune riguarderebbero: l'inimicizia (patriarcale) tra donne in relazione alla rivalità competitiva tra lavoratori; la legittimazione del capitale simbolico come pagamenti sufficienti; l'isolamento nella sfera domestica, ora connessa; o il legame delle donne con un destino di infelicità – confondendo il malessere critico con l'infelicità – anche nel tecnocapitalismo si corre il rischio di disattivare la coscienza emancipatrice, proprio là dove la critica può essere motore di autonomia e libertà. Queste sono alcune delle somiglianze su cui sviluppo la mia argomentazione.
Liberare il tempo proprio dal “fare meccanico” che genera disaffezione: filosoficamente, questo non implica una rilettura dell'otium aristotelico, opposto alla burocrazia oziosa moderna, per riscoprire il tempo come spazio di contemplazione etica e politica?
Liberare il tempo proprio dal fare meccanico non è per me, semplicemente, un gesto individuale di riposo, ma un atto politico ed etico, un recupero del tempo come spazio di senso, di immaginazione, di deliberazione e di cura del comune. E sebbene liberare il tempo dal fare meccanico implicherebbe idealmente riaprire la possibilità di quell'"otium" (aristotelico) inteso come un tempo liberato dalla pressione dell'utilità, ciò che oggi predomina è un tempo (l'ozio) "svuotato solo per essere riempito", voglio dire, preparato per riprendere le forze per la centralità del lavoro e per essere colmato di attività di consumo che ostacolano il senso più intimo dell'otium, per la contemplazione attiva, dove pensare, prendersi cura e deliberare tornano a essere gesti della stessa libertà. Questo senso del tempo aiuterebbe a recuperare il tempo come territorio dell'umano. E qui pongo un paradosso lavorativo contemporaneo che mi sembra pungente: il lavoro che sembrava più libero (lavoro intellettuale e creativo) è, in realtà, uno dei più precarizzati (specialmente nei tempi) ed emotivamente più dipendenti dalla tecnologia.
Nel contesto della Sua opera più ampia, come si intreccia la tristezza burocratica con le fragilità digitali esplorate in Frágiles? È una tristezza che, come suggerisce Camus, può condurre all'assurdo e, quindi, a una rivolta creativa contro l'ordine amministrativo?
La fragilità di cui parlo in quell'altro saggio allude a una vulnerabilità che si fa collettiva a partire dall'autocoscienza condivisa (le lettere, la conversazione, l'incontro di una moltitudine di lavoratori solitari che non si vedevano tra loro). È all'interno di quella fragilità che si danno appuntamento i malesseri contemporanei, tra cui abita questa tristezza. Capisco che la risposta di Camus all'assurdo non sia la fuga, ma il risveglio della coscienza tragica. E che, trasposto nel presente, il suo pensiero potrebbe leggersi come una critica anticipata alla burocratizzazione del senso. In un mondo in cui la vita viene gestita e il pensiero viene quantificato, la tristezza dell'assurdo riappare come resistenza affettiva, ma questo non sarebbe altro che il sintomo di un'umanità che "non" si rassegna. Così, quando la tristezza si lega a quell'assurdo e nel dispiegarsi della vita che sta nascondendo (che è l'esercizio narrativo che cerco di sviluppare in El informe) riesce ad assumere la sua lucidità, può diventare una rivolta creatrice. Questa almeno è la mia motivazione.
Infine, se il lavoro intellettuale cede all'obbedienza, come Lei avverte, cosa è in gioco per l'emancipazione collettiva? Questo non evoca la domanda levinasiana sull'alterità: chi disturberà il nostro ego burocratico per ricordarci la responsabilità verso l'Altro, il pianeta e la cultura?
Quando il lavoro intellettuale si meccanizza e il lavoratore obbedisce soltanto, l'emancipazione si ferma, la ragione diventa calcolo e la cultura si fa pratica amministrativa. È un quadro in cui il limite tra l'umano e il non-umano si sfuma e corriamo il rischio di persistere nelle nostre docili inerzie produttive trascurando il legame con gli altri e con il pianeta. Di fronte a ciò, direi che l'alterità è una risposta interessante in quanto aiuta a interrompere ciò che è sempre uguale. E che la sua "possibilità di deviazione" è un'interruzione. In tal senso l'alterità può aiutarci a tornare alla responsabilità, ad assumere la sfida emancipatrice, non più di organizzare il mondo, ma di rispondere al mondo. Così, in questo contesto e pressati da un ordine tecno-burocratico, la tristezza qui non sarebbe un fallimento, ma piuttosto il primo segno che la vita resiste ancora alla sua stessa domesticazione, un interruttore che cerca di accendere la responsabilità e l'azione collettiva. Ancor più quando rivendichiamo il potere della cura in collaborazione con il lavoro intellettuale. Non riesco a immaginare sfere più sensibili alla tristezza come meccanismo che punge l'empatia e che può riaccendere quella responsabilità verso gli altri e verso il pianeta.