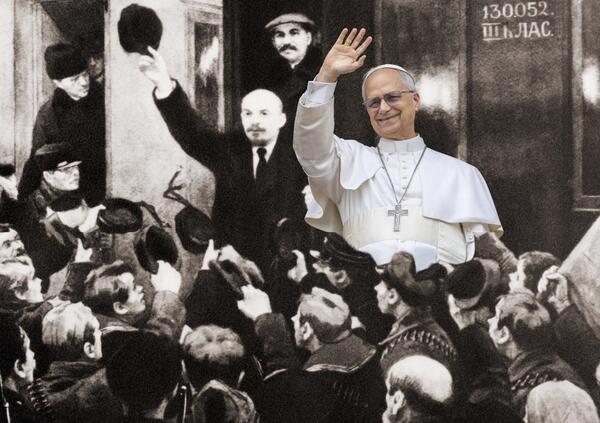Roma, ottobre 2025. Ho concordato con Anna Negri un appuntamento nella sua casa romana, a due passi dal centro, per discutere del suo ultimo film, Toni, mio padre, presentato alla Biennale di Venezia. Ho studiato per una vita il lavoro del padre, Toni Negri, ma questo film non è un atto di devozione di una figlia a un papà. È un modo per restituire un conflitto, fatto di femminismo e decostruzione, dove Toni diventa una soglia per comprendere qualcosa dell’Italia, del mondo, del personale che si fa politico e—soprattutto—viceversa.

Inizierei da quel punto di cui discutevamo prima che accendessi il registratore. C'è un momento del film che ho trovato molto interessante, in cui tu e tuo padre discutete di femminismo. Lui si dice essere stato uno dei primi ad averlo intercettato come pensiero critico, rivoluzionario degli anni '70. Però poi, nella discussione che avete, emergono tutte le contraddizioni e i problemi del caso. C'è proprio un momento in cui lui si stizzisce e ti manda a quel paese.
Io lo mando a quel paese in continuazione nel film, però ci sono delle volte in cui lo fa anche lui, che proprio si irrigidisce e dice: "Allora non si può parlare di femminismo con te!". C'è questo momento di tensione. Lui, in realtà, è come se ammettesse che il femminismo è una cosa che gli è capitata. Dice: "C'erano queste donne nel mio dipartimento di Scienze Politiche che hanno iniziato a fare femminismo già alla fine degli anni '60". Lì io tento di investigare su come ci fosse un'accettazione teorica di questa cosa, ma poi un'accettazione personale che era molto più difficile, proprio perché loro come intellettuali maschi non erano abituati. E questa cosa, secondo me, è un conflitto che è continuato ed è stata una delle grandi contraddizioni del movimento rivoluzionario di cui ha fatto parte Toni. Sì, il femminismo chiedeva una pratica che era anche quotidiana e che molti uomini, molti compagni, non erano disposti a dare.
Ho percepito, sia nel libro che avevi scritto (Con un piede impigliato nella storia), sia in questo film, un attraversare anche la figura di tua madre, e questo dibattito continuo che avete sul suo ruolo. Lui, pur avendo questo afflato femminista, ha avuto in tua madre, in voi, le sue contraddizioni più grandi. Nel film, che valore ha l'attraversare queste contraddizioni?
Secondo me lì c'è uno dei nodi centrali: questo femminismo è il rapporto politico interno col movimento. Quello che dico anche a mio padre è: tu non puoi lottare per un mondo migliore, eccetera, eccetera, però nel tuo privato non vedere che ci sono dei rapporti di potere ancora dettati dalle vecchie convenzioni.
Quanto questo ha inciso non tanto su tua madre, ma su di te, nel liberarti dell'eredità scomoda, o complessa, che è stata? Tu lo racconti anche con la sofferenza di una bambina, di una ragazza, in quella parabola, in quel momento in cui dici: "Dopo un po' che ero finalmente liberata da questa eredità, sono tornata in Italia contemporaneamente all'uscita del mio primo lungometraggio, e ancora una volta si parlava di mio padre, del suo ritorno dall’esilio …".
No, ma lì, però, è un altro livello: è il livello del trauma. Non tutti hanno vissuto un trauma del genere. Il suo modo di rimarginare questo trauma è stato tornare in Italia e riaprire il discorso politico degli anni '70, gli anni di piombo. Un peccato che di fianco c'ero io con la mia piccola storia, di una che invece è stata in esilio spontaneo, che è riuscita a imparare un'arte, a metterla in pratica, che torna per fare il suo primo film e guarda caso questa cosa deve coincidere proprio con il ritorno del padre nel dibattito pubblico. Questo mi rimette dentro un circuito traumatico... Però questo non è un problema di femminismo, è la grande storia che si scontra con la piccola storia mia. È il continuo conflitto fra un'ideologia così forte che non può stare a guardare i bisogni delle singole persone.
E nel film tu questa cosa la mostri. Io lo considero anche una finestra sulla Storia. Mi sembra che il pretesto di parlare di un padre che è stato uno dei protagonisti indiscussi di quel periodo, sia anche un modo per aprire la finestra su alcune cose che probabilmente tanti della mia generazione e quelli che sono venuti dopo non hanno idea siano esistite. Quando mostri le locandine del festival all'Idroscalo, quel certo tipo di destrutturazione dei rapporti interni alle famiglie, la decostruzione di un certo tipo di visione sulla monogamia, sembra esserci un laboratorio di cambiamento totale. In qualche modo però, attraverso la parabola di tuo padre, si intravede anche il fallimento di una storia personale.
Noi avevamo litigato su questa cosa. Io mi chiedo: "Ma com'è che voi che eravate così intelligenti e non vi siete accorti di questo treno che vi stava arrivando addosso a schiacciarvi?". Probabilmente avevano più fiducia nello Stato di quanto non avessero la stessa fiducia i membri dello Stato stesso. Certamente non si aspettavano di essere imprigionati e accusati di una cosa che non avevano fatto.
C'è quel momento, che ho trovato meraviglioso e centrale, in cui siete seduti a un tavolo, forse con tuo figlio. C'è questo conflitto triangolare in cui poi tuo figlio ti fa notare: "Guarda che lui fa con te quello che tu fai con me". Mi sembra una bella metafora del cosiddetto conflitto generazionale degli anni '70, rivista oggi.
"Cioè, tu mi fai sentire come mi sento io quando litighiamo" mi ha detto.
E in questo scontro tu provi a chiedergli delle cose e lui riparte sempre con la filippica del comunismo, della liberazione, del proletariato. A un certo punto dici: "Va bene, per parlare con te, pure per parlare dei fatti nostri dobbiamo sempre passare da lì". Quanto ti ha condizionato il personale è politico?
Beh, c'è tantissimo, però c'è anche il fatto di due che non si conoscono e che si iniziano a conoscere e a parlare veramente dopo quarant'anni per tutto quello che è successo. Questo è un altro elemento, è molto forte. Mio padre mi è stato strappato.

Sembra che questo trauma sia stata poi la base della creatività che hai messo in campo come regista.
Sì, certo, come tutti.
Beh, non tutti hanno avuto un trauma, e non tutti quelli che sono creativi l'hanno avuto. Tu l'hai avuto, però, il trauma. In che modo questo film è parte di una terapia per affrontarlo?
Beh, sì, lo è molto. D'altra parte, se non avessi superato il trauma non sarei riuscita a fare il film. Soprattutto al montaggio, è stato un tira e molla costante: quanto mostro, quanto non mi espongo… Raccontare questo trauma significa superarlo, sì, però nello stesso tempo devi anche esserci ancora dentro, perché sennò non riesci a comunicarlo.
A proposito di montaggio, come ha funzionato? Non si capisce com'è possibile che la telecamera fosse accesa in certi momenti, in cui ci sono delle litigate assolutamente naturali, spontanee, private.
Ah, perché, beh, intanto quando ci sono anch'io in scena, c'era Stefano Savona a filmare, ed è molto bravo a essere invisibile. E poi, a un certo punto, eravamo talmente presi dalla discussione che dimenticavamo di essere filmati. Succedeva proprio così.
È vero che a un certo punto non lo volevi più fare?
Per me è stato un inferno fare questo film. Mio padre aveva avuto la capacità di farmi sentire inadeguata sempre, a maggior ragione quando mi sentiva messa in discussione. Nonostante questo, comunque, ho tentato. Avevamo una specie di patto di fondo, ma io tantissime volte volevo mollare tutto. Mi sentivo però in dovere di continuare per le persone che mi avevano dato fiducia.
Ma cosa ti ha spinto poi a completarlo?
Per me era proprio una vittoria sul trauma. Riuscire a intraprendere un dialogo con mio padre era molto importante, molto importante prima che mi morisse.
È riuscito a vederlo?
No. È morto una settimana dopo la fine del montaggio.
Eppure, almeno nel film, lo filmi mentre ti dice: "Facciamolo questo film". Sembrava essere un tuo super fan.
Lui era un super fan, però era anche una persona estremamente dialettica, e quindi quando si iniziava a parlare, lui doveva vincere la discussione. Però, secondo me, nel film ci sono anche dei momenti di comunicazione reale.
C'è un momento molto bello in cui lui ti dice – e non so se è vero – che non è più interessato al fatto che tu scopra qualcosa di lui, ma è molto più interessato a scoprire qualcosa lui di te. Quanto è vero questo desiderio?
Sì, diciamo che ci siamo conosciuti a vicenda. Ed è vero che lui era dubbioso su di me. Probabilmente si immaginava che io avrei fatto un film molto più apologetico. Non lo è per nulla. Si è accorto, questo credo sia chiaro in un'ora e mezza di film, che io mi sono sentita comunque libera di metterlo in discussione.
Il tuo film non è apologetico. Anche se a me non sembra che tu critichi così tanto tuo padre nel libro o in questo lavoro.
Secondo me il problema non è la critica. Il problema è che tutte le volte che si mostra il lato umano di un pensatore, automaticamente uno si rende conto che dietro anche le forme di pensiero che sembrano più coerenti e perfette c’è l’umanità più semplice. Non bisogna confondere il prodotto delle persone con la persona. Comunque, credo che anche nel film mio padre venga fuori come una persona eccezionale, con un rigore intellettuale ed esistenziale molto forte.
Sì, viene fuori soprattutto il coraggio. Tu racconti uno spaccato della società italiana di quegli anni abbastanza terribile: come i media percepivano il caso giudiziario di tuo padre, come tu ti trovavi ad andare a scuola con le peggio cose scritte sui giornali. Un misunderstanding continuo e voluto dei giornali, pure compagni, che rappresentavano tuo padre come un mostro, e dietro c'erano le vostre esistenze. Tu te ne sei andata all'estero a studiare. Come ti è venuta voglia di tornare? La società italiana di oggi sembra, pur nelle differenze, molto simile a quella che racconti.
Volevo conoscere questo paese, volevo viverci. Era comunque il mio paese, ma mi sentivo come monca a non conoscerlo.
Quanto quel clima che racconti nel film c'è ancora?
Non tanto, però so bene di cosa è capace il potere, quello sì. Lì è stato un momento particolarmente esagerato: a causa del terrorismo hanno dovuto criminalizzare il movimento e l'hanno fatto con tutti i mezzi necessari. La vera grande colpa di quel periodo politico è stata l'invasione dell'eroina su tutte le piazze italiane, che doveva tenere sotto il "disagio proletario" ma che è uscita dalla scatola ed è stata una cosa interclassista che ha distrutto una generazione.
Che cosa ti sta scocciando della percezione del film o delle recensioni?
Il film è tanti film; ogni persona che lo guarda lo vede in maniera diversa. C'è uno scontro, come dire, padre-figlia, maschile-femminile, e alcune persone invece non vedono questo scontro che è simbolico. Io alla fine ho scritto un grande romanzo familiare, dove tutti i personaggi sono simbolici di quello che era lo spirito del tempo. Invece, vogliono vedere nel film un atto di dedizione in realtà, al di là della mia messa in discussione. È vero che c'è un ritrovamento di un amore per un padre che mi è stato sottratto, e una parte bambina che è stata bene a fare il film per poter passare del tempo con mio padre. Dall'altra parte, però, c'è anche una donna adulta che ha fatto un lavoro molto complicato di scelta dei materiali e del montaggio per far venire fuori un'operazione molto più complessa di un atto di dedizione.