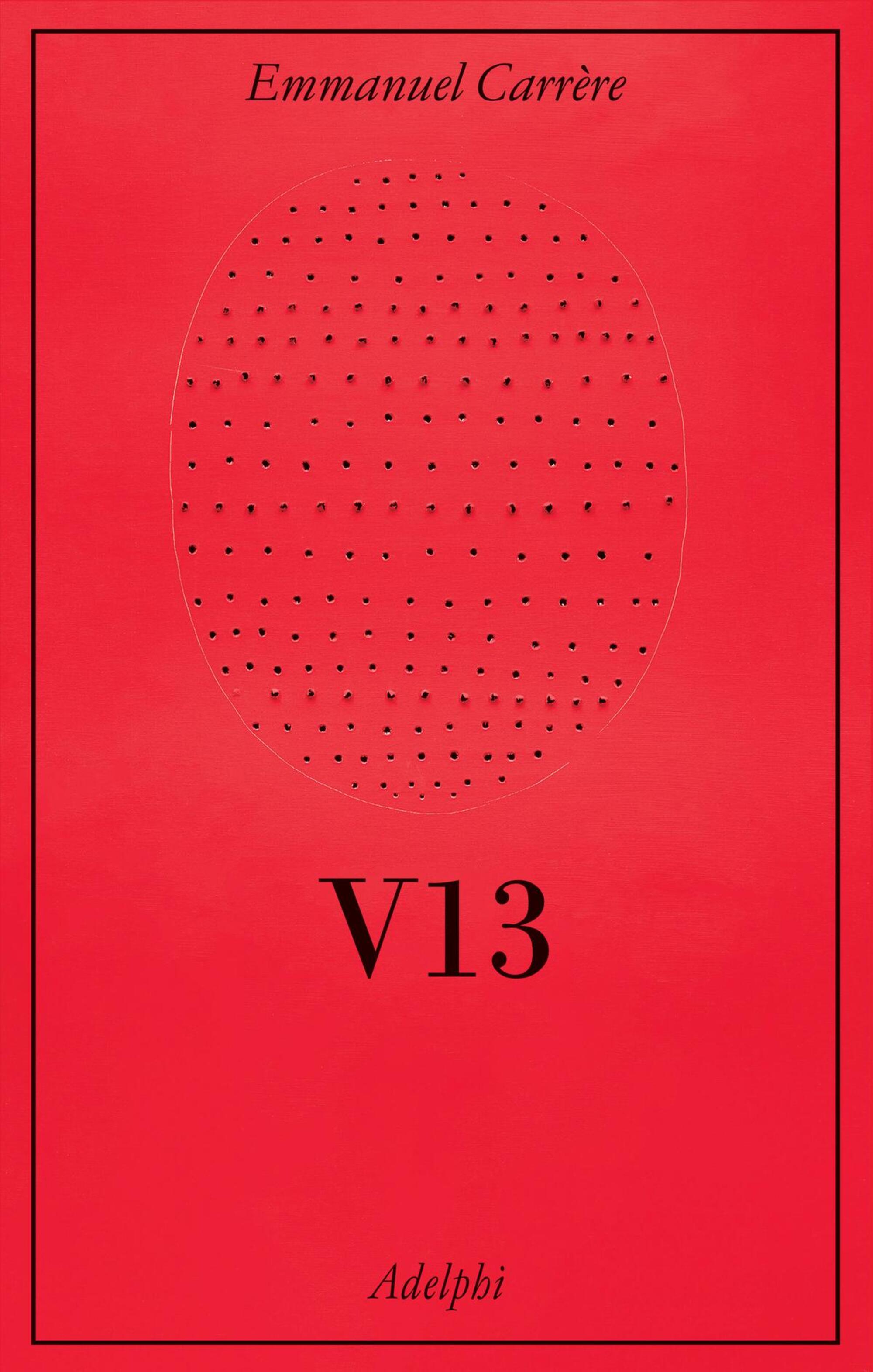13 novembre 2015. Ricordiamo tutti quel giorno. È il giorno in cui un commando di terroristi dello Stato Islamico ha causato nella capitale francese 131 morti e 350 feriti tra teatro del Bataclan, bar e bistrot e lo Stade de France. Protagonista della nuova fatica dello scrittore Emmanuel Carrère è quello che viene definito “il processo del secolo”. Processo che si è tenuto in uno spazio costruito ad hoc nell’atrio del palazzo Giustizia all’Île de la Cité, a Parigi, perché non vi era tribunale in grado per capienza di ospitare tutti i coinvolti. Gli imputati effettivi erano solo una decina, i minori, quelli che possiamo considerare di scarsa consistenza materiale e intellettuale: i responsabili diretti sono tutti morti. Si sono fatti saltare in aria o sono stati uccisi. Chi rimane è qualche fiancheggiatore, qualche amico, chi ha falsificato documenti, e uno che ha cambiato idea all’ultimo. Non si è fatto esplodere. Le parti civili, invece, erano a centinaia. Carrère, per quasi un anno, ogni giorno si è presentato al processo. Ed è così che torna una delle voci più limpide del panorama contemporaneo e lo fa nelle vesti nelle quali ci ha abituato ultimamente, quelle di ri-elaboratore di cronaca. Se Carrère ci aveva sconvolto attraverso il microcosmo del singolo con il romanzo L’Avversario, raccontando la storia dell’impostore Jean-Claude Romand, qua si cimenta nell’impresa della descrizione di una vera e propria degenerazione collettiva. Ad ogni modo, in entrambe le opere, è chiara la spinta intrinseca e la motivazione: la scrittura è per Carrère disvelamento di un mondo interiore, il luogo dove per eccellenza non si può mentire. Ed è per questo che cita in più parti importanti filosofi, tra i quali spicca Spinoza: il precetto massimo è di comprendere soltanto, non giudicare, non correggere, nemmeno odiare.

Così come scrittore si mette a disposizione di una rinnovata e matura comprensione. Certo, questo processo risulta essere ai limiti dell’umanamente possibile. Ci fa riflettere che tale concetto esca direttamente dalla bocca di Salah Abdeslam, uno degli attentatori: quello di cui si lamenta è che non si fa nessuno sforzo per capire i jihadisti: “È come se si leggesse soltanto l’ultimo capitolo di un libro: il libro bisognerebbe leggerlo dall’inizio”, dice. Abdeslam doveva farsi saltare in aria come il fratello minore di Brahim Abdeslam. Non si sa se si sia inceppata la cintura esplosiva o se abbia rinunciato alla follia all’ultimo momento. Solo lui può dirlo, e non lo farà. Il libro da leggere dall’inizio risulta ancora più ostico. Così, si tenta attraverso esperti e studiosi di ricostruire la storia personale di chi ha compiuto il gesto del terrore e la storia politica e civile dei paesi che da questa ondata di terrorismo sono stati sconvolti in primis. Il processo empatico non è una storiella che ci possiamo raccontare, come se fosse semplice. Carrère sottolinea l’impedimento della vicinanza a costoro, la fatica che costa la comprensione: “È la logica del «noi e loro» allo stato puro. Noi, pacifici democratici, persone oneste sulle quali il V13 fa l’effetto di un potente meccanismo generatore di senso della comunità, di legami, di identificazione. Noi ci somigliamo, ci capiamo, ci riconosciamo. Dal lato opposto, loro”. Non è più facile prendere semplicemente le distanze? V13 raccoglie gli articoli pubblicati a cadenza settimanale sul quotidiano francese Obs, e poi ampliati in questa nuova uscita editoriale. Ci si presenta suddiviso in tre macro-capitoli: le vittime, gli imputati, la corte. Quello che ne risulta è un resoconto implacabile di vita e di morte e un calderone denso di domande irrisolte. Quella fondamentale riguarda la responsabilità degli imputati, la quale non è in discussione, la faccenda chiave è la loro prossimità al male.

La questione sulla responsabilità si accoda a una serie infinita di racconti di chi è stato vittima, di chi ha subito questo male. Immagini raccapriccianti di puro terrore si alternano a episodi di altruismo puro, piccoli gesti di gentilezza, di umanità. Carrère prende in prestito ancora una volta dalla filosofia. “Il male immaginario è romantico, romanzesco, vario; il male reale incolore… desertico, noioso. Il bene immaginario è noioso; il bene reale è sempre nuovo, meraviglioso, inebriante”, diceva Simone Weil. Questo male di cui siamo testimoni in lontananza è concreto. Così come lo è l’immagine forse più scandalosa che il libro riporta, quella dei coriandoli di carne che cadono, come in una festa blasfema, a ricoprire l’orrore del massacro. Cos’è questo libro? Romanzo, reportage, articoli, testo sulla giustizia. E sulla sua limitatezza. Questo è stato il processo del secolo, nella sua monumentalità, e nella sua incapacità di giungere a una comprensione definitiva e totale. In effetti, il protagonista è il processo stesso inteso come l’unica riparazione possibile – che altro si potrebbe fare? - a tutto quello che è accaduto quel giorno di novembre. È il tentativo di riscatto di una società civile, di una giustizia che tenta di risollevarsi. In definitiva della contrapposizione fra una fede cieca, annebbiata, insensata e una fede nella non vanità del mondo. V13 ha raccolto il senso di questo processo, quello di dare voce a una coralità di motivazioni, di storie, di una sofferenza che possa essere finalmente ascoltata.