Margaret Mazzantini è un’ottima scrittrice. La sua è una lezione di scrittura, soprattutto quando lo stile si lega a trame esposte quasi sotto dettatura, tra pause, tempo di riscriverle nella propria mente, correggerle. Sergio Castellitto è un ottimo attore, basti pensare ai recenti (e diversi) Dante di Pupi Avati e Il talento del calabrone di Giacomo Cimini. Insomma, due professionisti che si fanno voler bene. Ma come non prendersela con loro e chiedere il loro scalpo, se decidono di alimentare, al di là di qualsiasi freno critico, le velleità artistica dei figli? Non parliamo de Gli iperborei di Pietro Castellitto, primogenito i cui meriti letterari non sono neanche scrutabili all’orizzonte. Ma della giovanissima Maria, classe 1997, che esordisce con un romanzo pubblicato da Marsilio, Menodramma, candidato allo Strega (per ora nella selezione più vasta e, quest’anno è il caso di dirlo, incomprensibilmente sovrabbondante).
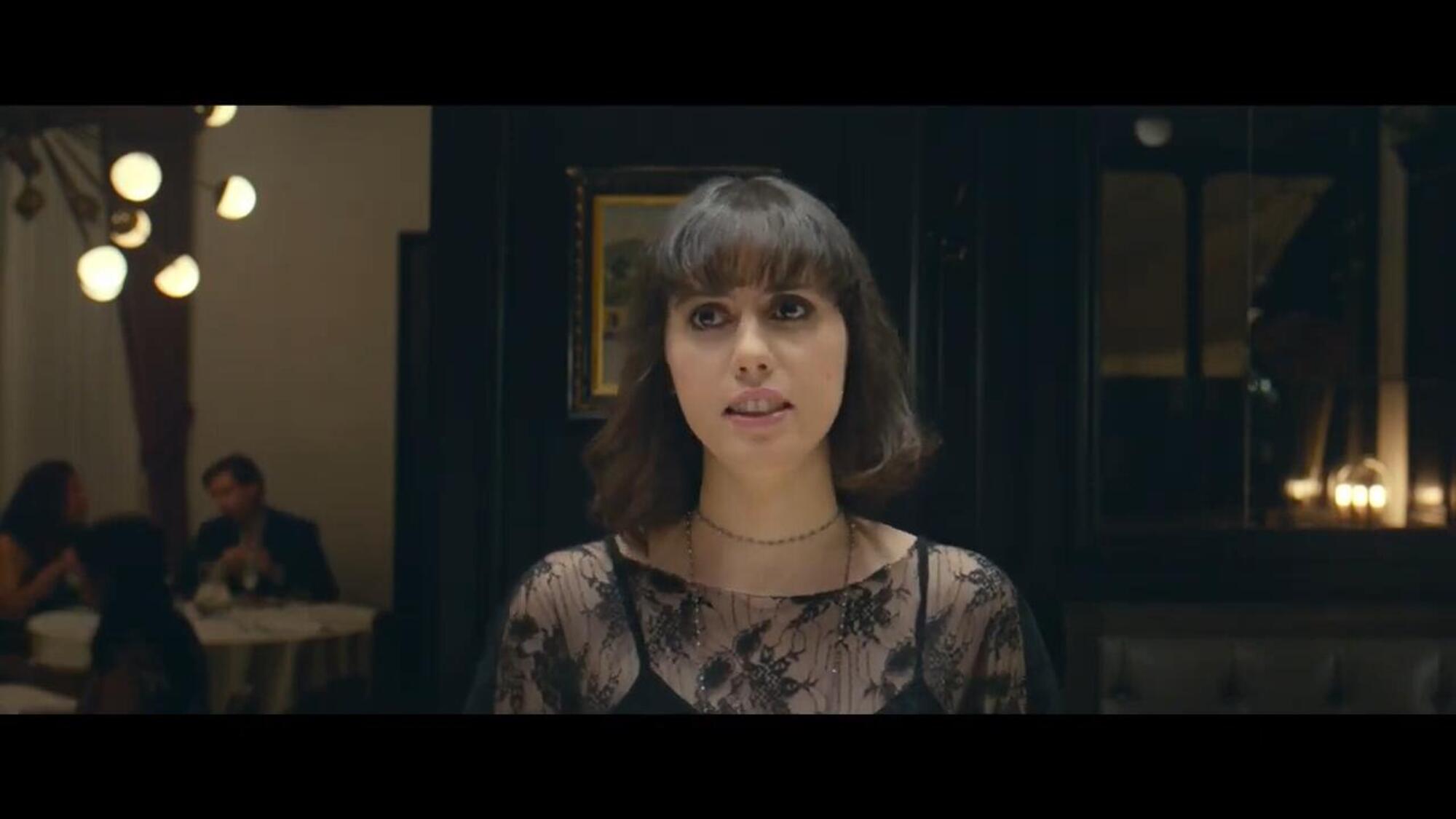
Parliamo di lei non perché sia bella (non lo so), simpatica, impegnata (forse è tutto questo), ma perché ha tutti gli ingredienti per essere masticata e risputata da un ambiente che cerca sempre di più o lo spettacolo o l’attivismo. Lei, giovanissima, potrebbe infatti diventare attivista di qualcosa (compiacendo così quella parte di pubblico che grida al capolavoro leggendo il libro sull’apocalissi climatica di Paolo Giordano – di recente divenuto anche commentatore della tragedia ucraina – o la lagna di un Desiati o un Bazzi che ti parlano di fragilità, estromissione, stigma, ma senza essere Hugo o Balzac; nonostante ci sia chi li fa sentire così). Per ora, invece, può venire incontro alle esigenze di chi legge soltanto – o quasi – enfant prodige, ricalcando quel mito – infantile – del genio, manco fossimo di fronte ai giovanissimi Marx o Rimbaud, scrittori completi già sotto i 30. Ha 25 anni, è figlia d’arte (quindi gli agganci, quindi gli editori, quindi i recensori che vogliono diventare amici dei genitori), è laureata (alla SOAS, la School of Oriental and African Studies di Londra), ha già scritto per Il Corriere della Sera. Lei dice che il padre ha letto tutte le stesure del romanzo. E la madre? Sergio si è calato nella parte tanto da averle mandato anche una foto vestito dal “regista Vittorio Solenni”, il padre della protagonista, Duna. Dicevamo, qui le smagliature della fama sono evidenti, non si possono coprire neanche con la carta rosa della copertina, che parrebbe quasi voler dare – così, senza immagini – una parvenza di serietà a un libro che serio non è.
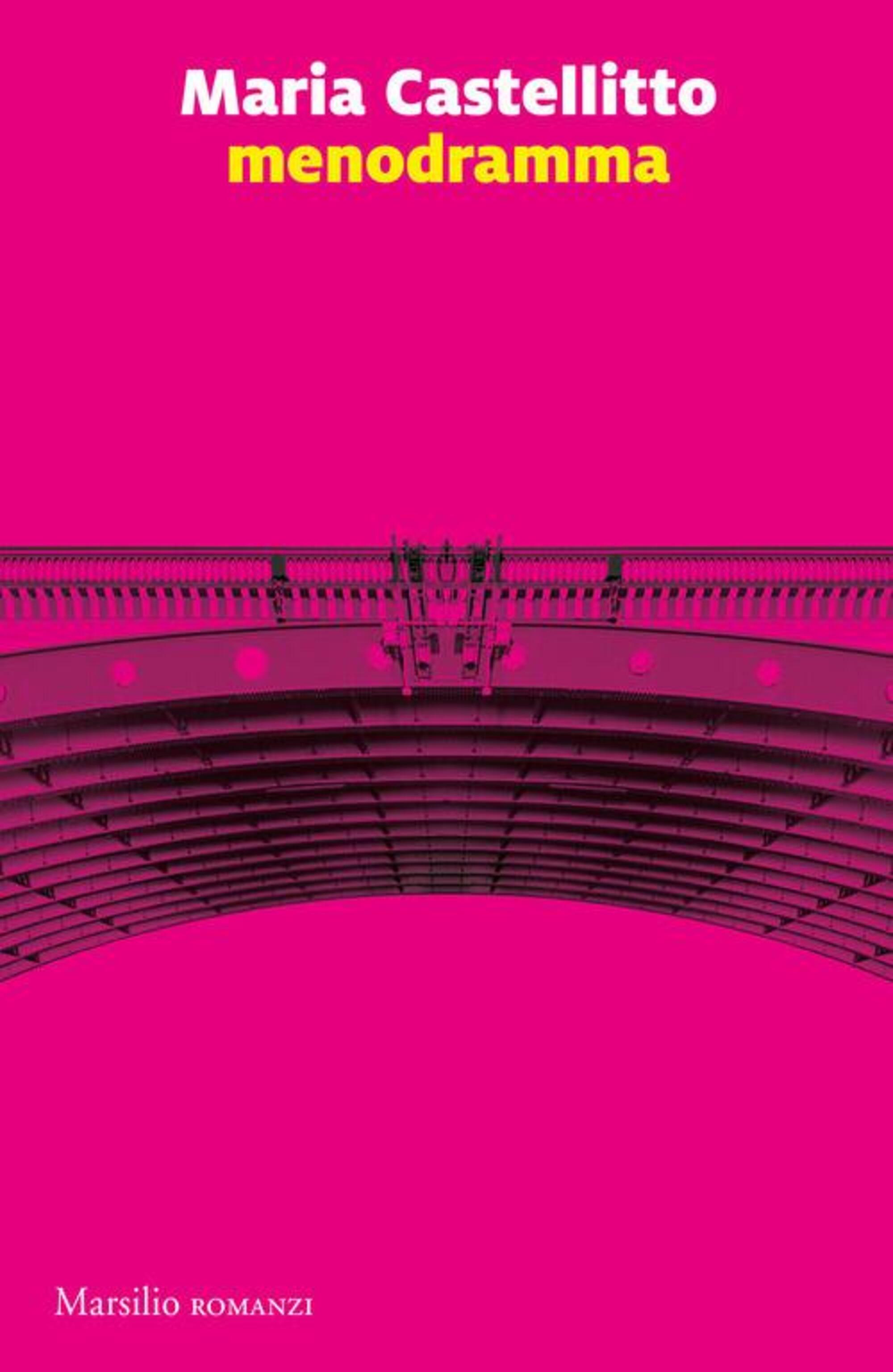

Il problema non è scrivere. C’è posto per quasi tutti, soprattutto se l’editore è grande (salvo poi essere Aldo Busi e non riuscire a pubblicare quello che sicuramente sarà l’ennesimo capolavoro, ma va bene così). Il problema non è essere una “figlia di”, una “nepo baby”. Potrebbe esserlo se vi si contrapponesse un qualsiasi senso di giustizia presente in altri ambienti, per ora non pervenuto. Il problema non è che la madre non l’abbia avvicinata, magari sedendosi accanto a lei su un letto, per dirle che no, questo romanzo dovrebbe essere riscritto mille volte per essere almeno passabile. Il problema è che non è colpa sua. Vogliamo tutti essere scrittori, geni, artisti, pittori, musicisti, attori. E tutti lo facciamo. Più con la poesia, è chiaro, perché cinque versi non sono duecento pagine in prosa e ci sembra più facile (non lo è) riempire un taccuino di “t’amo” e cieli stellati. La colpa non è neanche dei lettori. La colpa è di mamma e papà, che hanno smesso da tempo di essere sinceri con i loro figli.

La storia ha un po’ di tutto, ragazzi soli, un malato psichiatrico, Alexander, la giovinezza che se ne va. Un potpourri in salsa Gen Z, dove l’ironia viene scambiata con certo, purtroppo presente, piattume giornalistico (qua e là una battuta e per il resto totale mancanza di espressività, la cronaca di un incidente andato a buon fine, la chiosa di un articolo di gossip che non può finire con una citazione; cose così). Lei dovrebbe aver studiato filosofia, ma non lo dà a vedere. Parla di isolamento, sentimento autodistruttivo, ma non ci leggi Sartre, non ci leggi Camus, nemmeno Cioran. Ecco una frase dal libro: “Ogni tentativo di suicidio è anzitutto un tentativo irrazionale di salvezza, per scappare dal mostro, non per morire”. Scommetto che basterebbe aprire Wattpad per trovare mille frasi identiche e altre mille frasi migliori. Sembrano parole di un pezzo trap pessimamente scritto.

Altri esempi: “Basta poco a sentirsi vivi e ci si ammazza per niente”; “Mi gira la testa e la testa di Sylvia Plath nel forno mi entra in testa”; “Credevo di stare meglio oggi, ma una forza a me esterna unita a un mal di stomaco improvviso mi ha spinto a bussare alla porta di uno degli studi dei dottori”. La totale assenza di musicalità, la mancanza di ritmo, legati a una storia che ha il sapore del già sentito. Dove sarebbe la novità? E, in caso non si volesse essere nuovi in nessun modo: dov’è il vecchio fatto ad arte? Se prepari una ricetta tradizionale guai a bruciare il soffritto. Insomma, il libro fa l’effetto di quelle cover band delle feste di paese, quando uno dei musicisti alla fine si incazza perché capisce di essere lì a fare la figura dello scemotto e tira un cartone al cantante. Solo che in questo caso Menodramma è la cover band dei suoi genitori, forse più del padre attore che non della madre scrittrice. E non è per essere cattivi. La cattiveria sarebbe stato definirlo una cover band del romanzetto del fratello.











