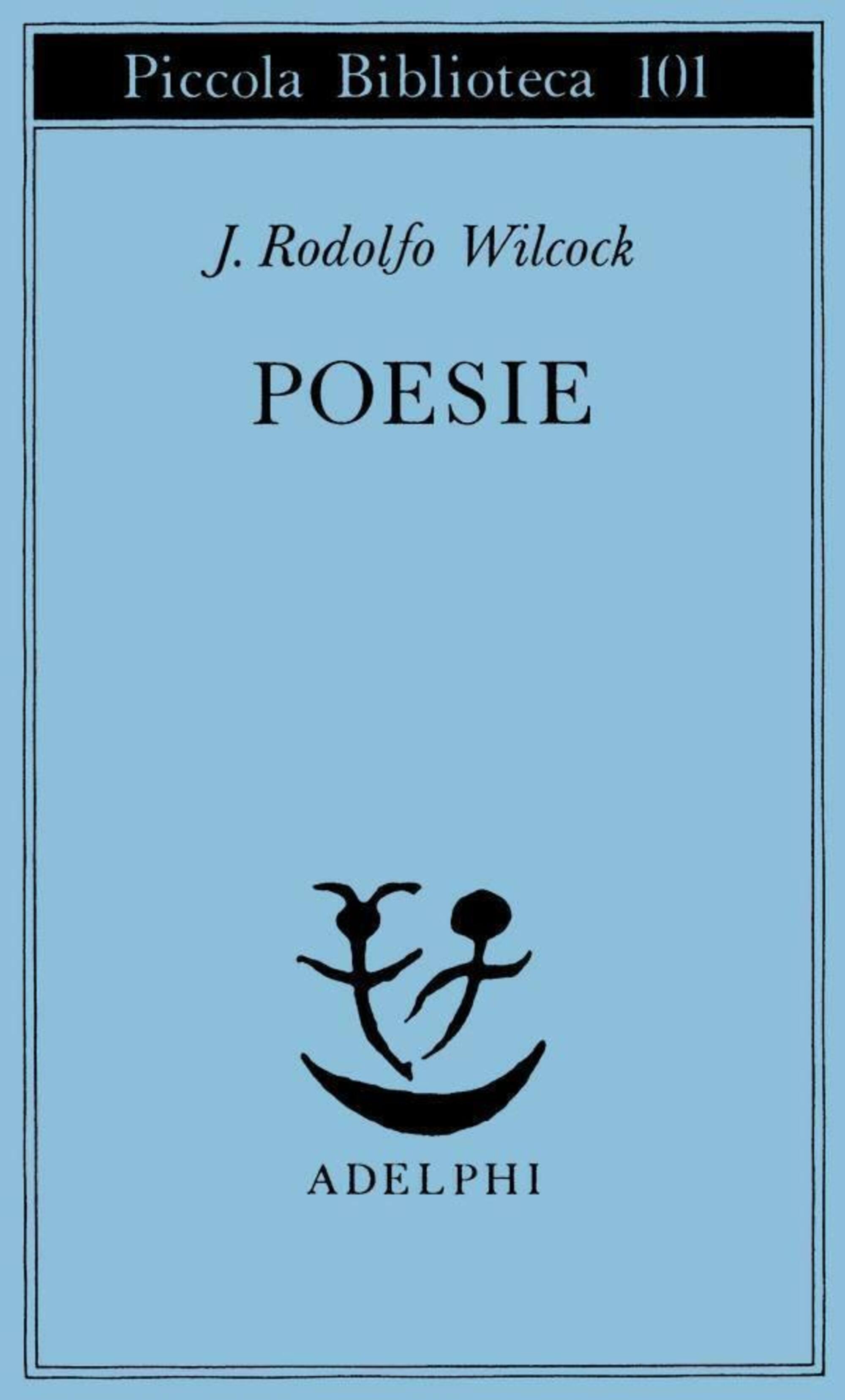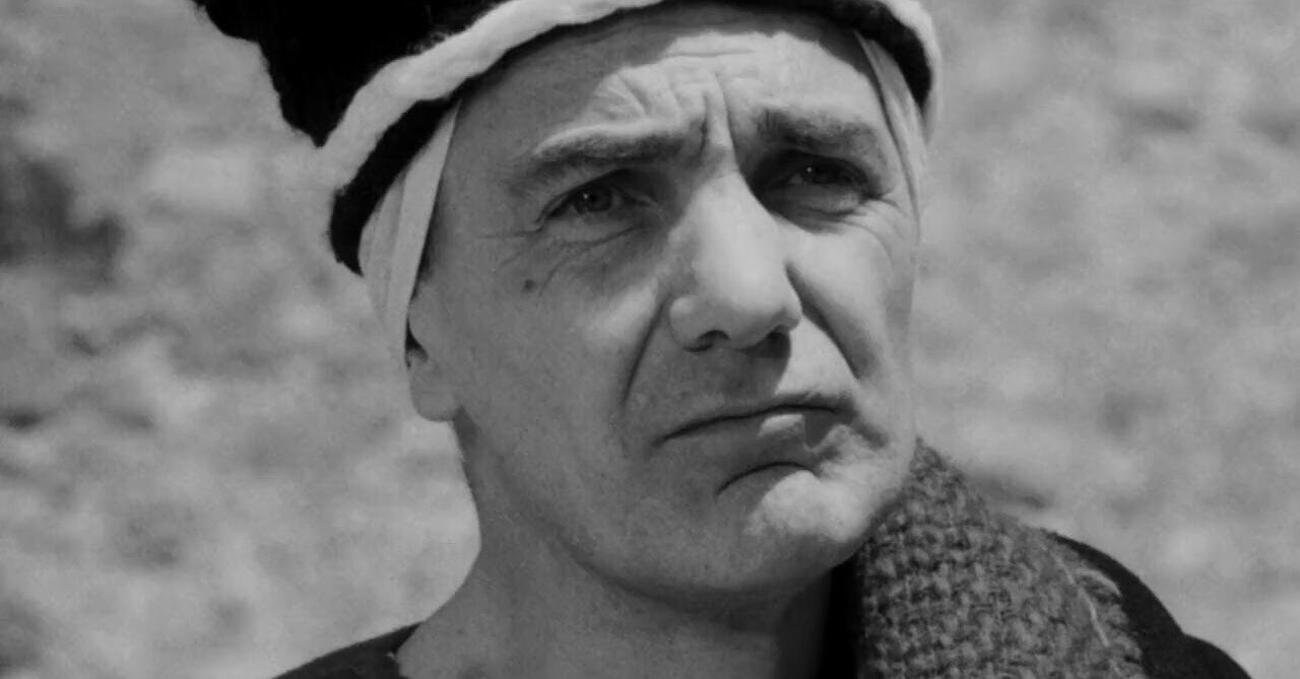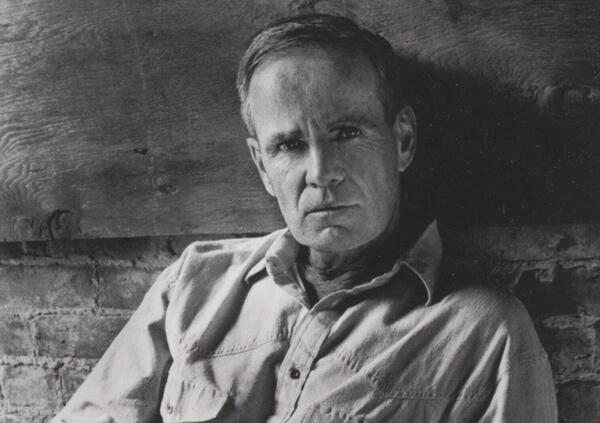Morì quando sparì Aldo Moro. Questo, si crede, ne offuscò riconoscimenti ed elogi post mortem. Juan Rodolfo Wilcock non incarna nulla, non è, come Moro (e come alcuni scrittori) simbolo di qualcosa se non di sé stesso. Anzi, è stato una forza anti-simbolica. Lo era già come giornalista dell’antigiornalismo con i suoi Fatti inquietanti. E ancora di più lo sarà con la sua opera poetica in italiano, che Adelphi sceglie di ripubblicare dopo la prima edizione del 1980. Semplicemente Poesie. Lui, che negli anni è stato apprezzato più come prosatore (da Bolaño per esempio) che non come poeta, ci ha dato nel Novecento un esempio unico di cosa voglia dire scrivere poesie forzando le maglie dei simboli, ovvero dei diamanti di senso che, grazie ai limiti della forma restituiscono un significato calibrato, come molta poesia “asciutta” ha saputo fare. Preferendo gli amuleti, i versi-oggetti donatori di realtà (perché tu hai dato loro senso). In altre parole, non una poesia oracolare, la cui direzione è dalla parola al mondo, ma una poesia che dal mondo va nella parola e la gonfia fino a farla scoppiare. Per questo le accuse di verbosità, per queste poesie fiume, devono essere rigettate. Non tanto perché, come è normale che sia, nell’opera di Wilcock troviamo anche versi ordinati, più lirici, e quindi un “poeta di poche parole”; ma perché dove c’è abbondanza il confronto non fa fatto con gli schemi classici della letteratura quanto con il mondo. Un mondo, quello italiano, che ha scelto volontariamente Wilcock, che permette di scavare incessantemente strato dopo strato.

È anche un poeta d’amore. Di quelli che oggi non pubblicheremmo più. “Amore è orbite piene di terra” e poi: “Amore è morte più visibilmente”. Si riconosce l’incarnato spagnolo. Quella visione di fondo che intrappola i grandi, per altro diversi, scrittori d’amore, da Salinas a Neruda. Quella tentazione a non rinunciare a un linguaggio abusato, che pare fatto di assoluti: abiezione, morte, vita. Ma, a differenza della purezza di Salinas (e forse dell’eccesso di simbolismo di Neruda), Wilcock riesce a mediare l’alto con la vita reale: “Ma io mi sciolgo davanti a uno snack-bar se solo so che dentro ci sei tu”. Se Wilcock ha raccontato in prosa le “stranezze” della cronaca, cioè della Storia dal punto di vista dei vivi, con la poesia ha cercato di navigare a vista sopra “l’umana effimera fantastichezza”. C’è, d’altra parte, un senso di impotenza setacciato da una saggezza gioiosa, da polymath quale era, che sa attingere alla poesia tanto quanto ai tempi impoetici della vita, quelli dell’Italia che si affacciava a tutt’altro tipo di stimoli, gli anni tra l’altro della contestazione politica (Italienisches Liederbuch 34 poesie d'amore è del 1974). Resta da capire perché abbia scritto in italiano e non in spagnolo. Qui ci aiuta una sua intervista rilasciata per la serie Incontri per la Rai: “Quando esiste un libro, si suppone che la gente legga quel libro. Se poi lo traducono, si sa che è un altro libro, una merce avariata, che si vende solo perché l’altro, l’originale, ha successo. E chi si vuole accontentare di questo surrogato, beh, si accontenti… Quando viene qualcuno a raccontarmi che ha letto Proust tradotto, so benissimo che sa un mucchio di cose sulla società di quei tempi, perché anche tradotto Proust parla di quelle cose. Però che sappia cos’è il mondo assolutamente intelligente di Proust… questo non lo può dedurre da una traduzione... Ha preso tutto del libro, ma la poesia no. E gli autori valgono quando sono poeti”.