Io l’università del futuro me la immagino così: scritte su tutti i muri, numeri di telefono di individui queer sulle porte di legno, strisciate di feci sulle mattonelle e pavimenti in linoleum, vetri delle finestre opachi e luci al neon da sala operatoria. Poi mi immagino dei gommini su ogni spigolo di cattedra, panca, sedia o libreria, sulle parti intime di molti studenti e sulle mani dei professori. Gommini dello stesso materiale di quei cuscinetti che vengono usati per truccarsi, offerti gratuitamente da dei banchetti studenteschi di volontari e collettivi contro la violenza universale. Sacchetti trasparenti o blister con su scritto: “Trigger warning”. L’università del futuro me la immagino imballata e a prova di bambino, inaccessibile agli adulti e interamente dedicata a soddisfare le fantasie imbecilli dei nuovi settori disciplinari, una sorta di parco giochi a spese dello Stato, ma decadente, giallognolo, puzzolente. Un cesso pubblico di militanza politica.
Se ne sono sentite varie negli anni. Ma si era partiti con più moderazione. I primi libri a essere toccati dalla cancel culture o dal politico corretto sono romanzi effettivamente datati, da Agatha Christie, che in Assassinio sul Nilo condannò Mrs Allerton alla fama di razzista per via del suo commento su alcuni bambini ladruncoli in Egitto (Allerton, e quindi per molti Agatha Christie, dice: “… i loro occhi sono semplicemente disgustosi, e così anche i loro nasi”) e che in svariate occasioni ha usato espressioni apertamente suprematiste (per esempio “nativi” al posto di “locali”), a Roald Dahl, colpevole di aver definito ne La fabbrica di cioccolato un bambino grasso, be’, “grasso”. E poi Ian Fleming, George Orwell, Margaret Mitchell (l’autrice di Via col vento).
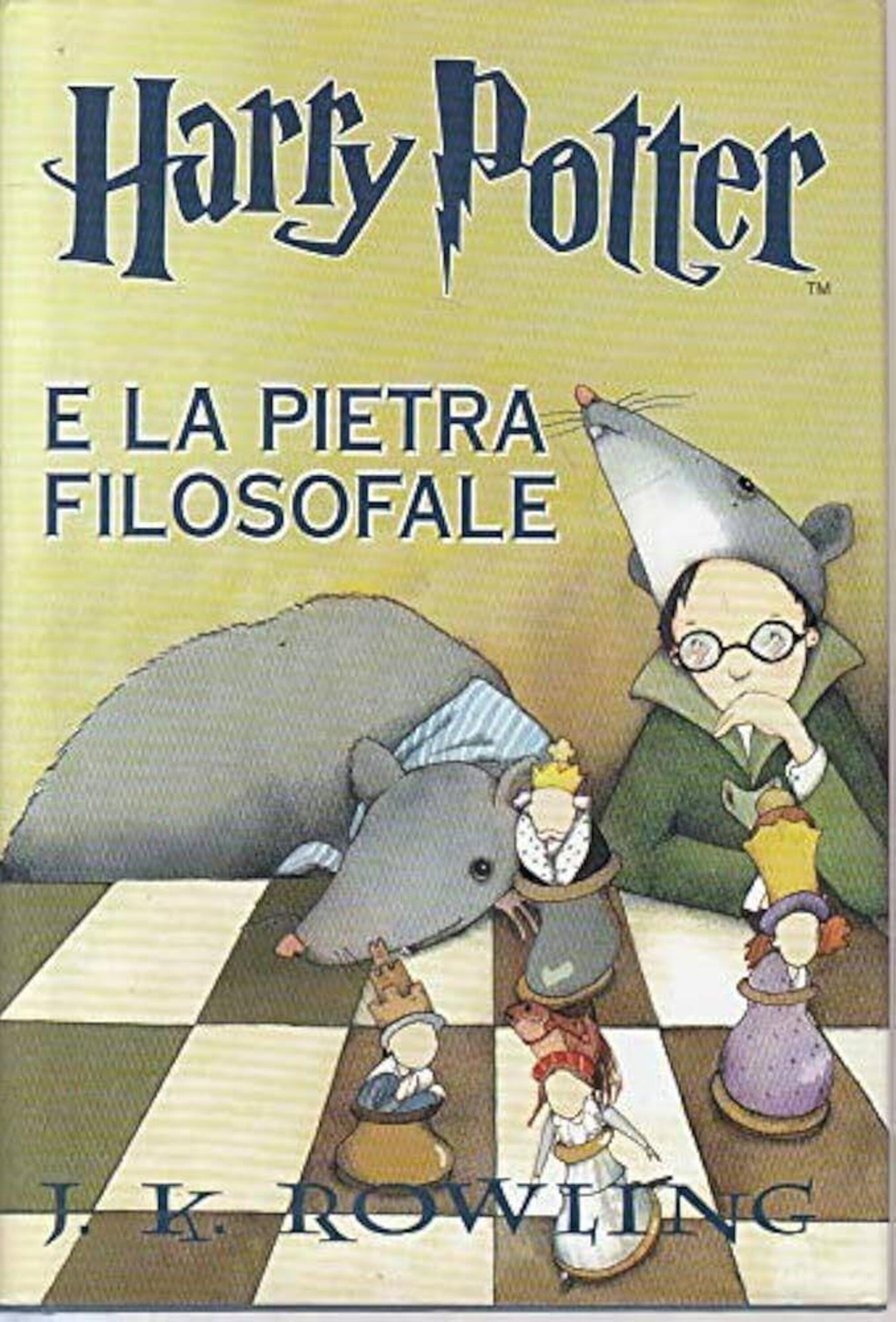
Ma nel mondo iperaccelerato del vittimismo politico anche autori viventi e relativamente giovani come J. K. Rowling (60 anni), già accusata di transfobia (ma è un’altra storia, forse), possono aver scritto libri considerati “antiquati” dagli studenti di un’importante università come quella di Glasgow. Harry Potter e la pietra filosofale, il primo di una serie di libri con un successo trentennale, conterrebbe “atteggiamenti, insulti e linguaggio obsoleti”. Un libro scritto nel 1998, non nel 1888. Giudicato, fino a qualche decennio fa, un libro progressista, in cui i buoni sconfiggevano i suprematisti Serpeverde che volevano sterminare o ridurre in schiavitù i babbani (un’immagine che dovrebbe ricordarvi qualcosa). Nel tempo la discussione si è ampliata: Gli Harry Potter divennero dei romanzi paternalisti, in cui i babbani, cioè le minoranze, i discriminati, i più deboli e così via, non potevano salvarsi da soli ma avevano bisogno dell’aiuto di maghi buoni e illuminati.
Ora Harry Potter, che non ha nemmeno trent’anni, è diventato vecchio, troppo. Ma soprattutto è diventato offensivo, troppo. Immagino qualcosa, nelle università del futuro, tipo una Stella di David o il disegno di un bersaglio stilizzato, e sotto: “Fuck Harry Potter” o “Morte a Harry”. Non mi sorprenderebbe nemmeno se i social justice warrior del futuro si iniziassero a identificare con i Serpeverde, per via del purismo e del rigore ideologico con cui conducono le loro battaglie. Per fortuna gli studenti universitari non sono così colti da aver letto la Trilogia dello spazio di C. S. Lewis, l’autore delle Cronache di Narnia, o chissà che fine avrebbero fatto fare a Lontano dal pianeta silenzioso, un romanzo che dà più di un’occasione alle donne, decisamente sottorappresentate, di offendersi.
Mentre si attende che in Germania si mettano dei trigger warning sulle edizioni di Thomas Mann (magari negli scritti Sul matrimonio e Brindisi a Katia), possiamo girarci verso gli Stati Uniti, autentica fucina di piagnoni con un posto nelle università. All’Università del Minnesota, per esempio, hanno appena concluso uno studio intitolato “Whiteness Pandemic Project”, una ricerca sulla “pandemia della bianchezza”. Con un’operazione perfettamente speculare a quella delineata da Susan Sontag, che rileva come nei discorsi medici si ricorra spesso a una terminologia bellica (per es. quando si dice che dobbiamo “vincere la battaglia contro un tumore”), ora sono le guerre culturali a fare uso di termini di natura medica, nella speranza che questo dia un’impressione di scientificità agli studi portati avanti nei dipartimenti di ricerca o, come in questo caso, in un Laboratorio di cultura e vita familiare dell’Istituto per lo sviluppo infantile. Per capire cosa sia la “pandemia della bianchezza” serve capire cos’è la bianchezza: intanto, non crederete alla novità, si tratta di una cultura, di un costrutto. “La cultura della bianchezza è un insieme di credenze, pratiche e leggi che favoriscono il gruppo razziale bianco”. È secolare e ancora presente nel mondo. Pardon, in Occidente.

E va combattuta fin da bambini, soprattutto grazie a una “genitorialità antirazzista”. Per diventare dei buoni genitori antirazzisti, suggerisce lo studio, serve superare la prima fase, quella del negazionismo, cioè quando si evita di riconoscere il proprio ruolo nel razzismo. È chiaro serva tempo, visto che nel mentre dovrete anche, per esempio, riconoscere il vostro ruolo nel patriarcato, il vostro ruolo nel sistema classista, neoliberale e così via. Dopodiché bisogna superare la fase in cui si agisce in modo superficiale e occasionale, per approdare, dopo un altro paio di step, all’ultimo stadio del cambiamento: “Impegnarsi umilmente nell'apprendimento antirazzista permanente attraverso azioni costanti e meno impegnative per prevenire le ricadute nei vecchi modelli razzisti.”
Sembrerebbe tutto positivo, eppure l’uso di un linguaggio quasi terapeutico, morbido nell’accusare, ha qualcosa di inquietante, di maligno. Forse l’idea che tutti potremmo essere peccatori, anche se non è chiaro quali siano i comandamenti che il Dio dell’intersezionalità ha scolpito sui tablet della pietra. Sembra che tutta la parte difficile sia stata affidata a professori, intellettuali e studenti che possono creare liberamente sempre nuove e curiose accuse. Questa costante disponibilità di peccatori da crocifiggere e bruciare, che siano libri “obsoleti”, scrittrici “TERF” o biologhe che fanno bene il proprio lavoro e ci ricordano che esistono due sessi (leggete la storia di Carole Hooven), è la benzina della nuova classe intellettuale allevata nelle università occidentali.
Il costruttivismo sociale è l’ingrediente fondamentale, quello che permette di usare l’etichetta “cultura” come un passepartout inquisitorio. Così anche una donna nera a capo della Dei del De Anza College in California, Tabia Lee, può essere accusata di “suprematismo bianco” per il modo in cui insegna ed essere cacciata per questo. Insomma, grazie al paradigma culturale puoi persino essere accusato di non essere abbastanza nero da avere qualche diritto nella battaglia che molti studenti (anche bianchi) conducono nelle università contro il razzismo. L’università del futuro somiglia pericolosamente all’università del presente, in cui l’avanguardia del dibattito culturale è il peggior bigottismo talebano.












