Il fattore Scurati come leitmotiv della cultura amichettista, come lo furono Saviano e Michela Murgia, come lo saranno, forse, Chiara Valerio – per ora ministra del club ma non ancora con ruoli onorari – entra nell’equazione augiasiana di La7, a La torre di Babele, dove la crème de la crème dell’intellighenzia pop (da Galimberti ad Aldo Cazzullo) si mischia talvolta con intellettuali libertari o più schivi, ma non per questo meno piacenti (su tutti Il grande Giordano Bruno Guerri). E che ai primi si affianchi uno scrittore premio Strega come Antonio Scurati, che dovrà parlarci del fascismo e della sua crisi, guarda caso il tema dell’ultimo dei cinque volumi di M, il mattone del secolo, non dovrà sorprendere. Non solo per via di logiche di mercato e di promozione (Bompiani da qualche parte dovrà pure mandarlo il povero Antonio; e poi in Rai si dice lo abbiamo censurato, per cui…); né per mera gratitudine (il novantenne Augias ha presentato qualche giorno fa il nuovo libro di Scurati insieme all’autore); ma per un discorso di episteme, di discorso dominante.
Detto altrimenti: chi vuoi far parlare di fascismo? Uno storico vero? Uno che ti potrebbe dire che oggi il fascismo in Italia non esiste? Non sarebbe meglio che a raccontarti il fascismo di oggi a partire dal fascismo di ieri sia un autore che di oggi conosce il successo premeditato, cioè quello che si ottiene scrivendo in un certo modo di Mussolini (e questo modo è, per sintetizzare l’analisi ben più autorevole di Walter Siti, scrivere male?).
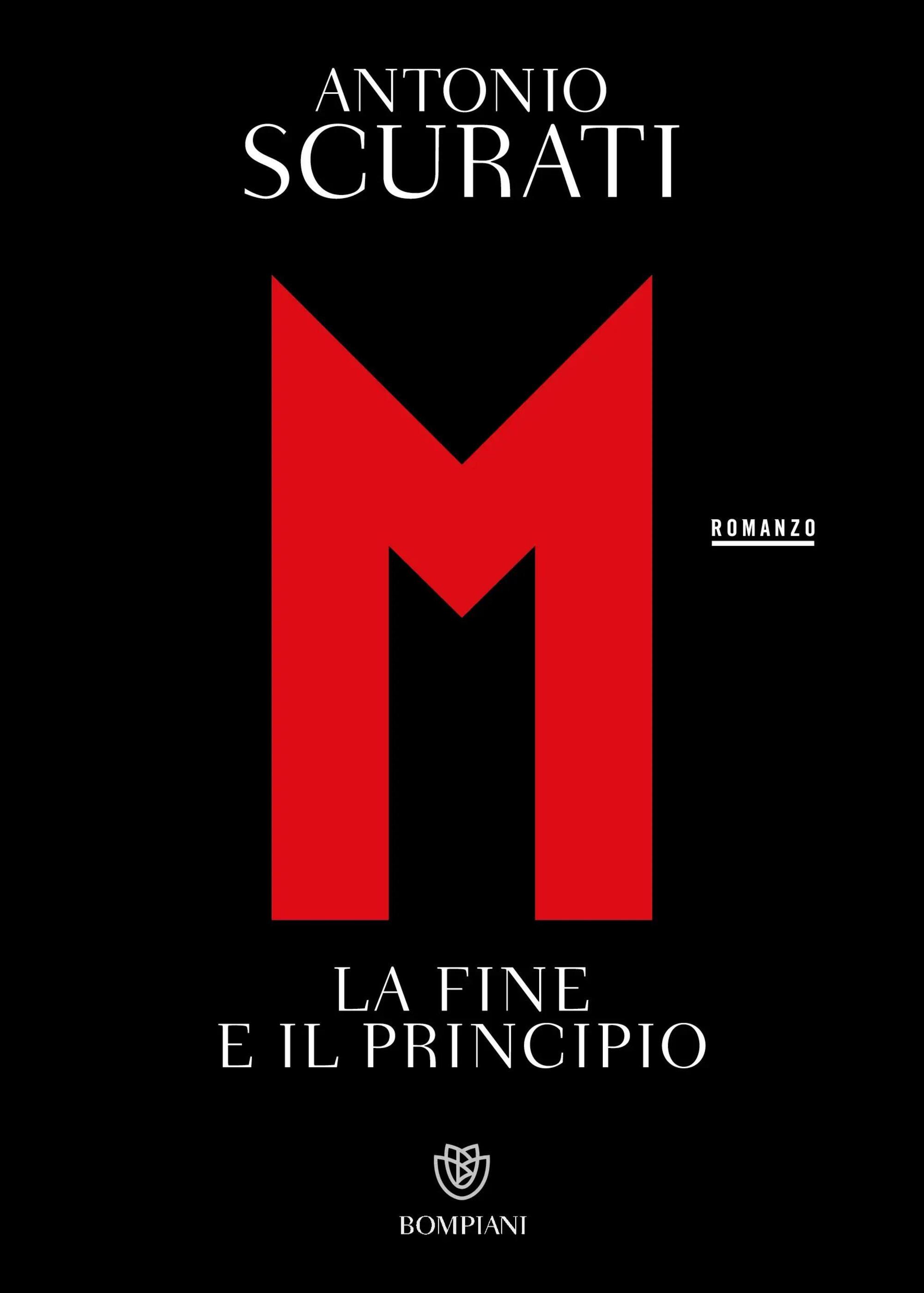
Eppure da Augias, seppur dalla fabulazione di un establishment culturale duro a morire (anche anagraficamente), qualcosa esce fuori: qualche stimolo, qualche giusta intuizione. E persino nella tesi dell’ur-fascismo, del fascismo redivivo, quella di Umberto Eco ma in fondo anche di Giorgio Bocca, qualcosa forse si salva. Una tendenza, un rischio da monitorare, ma non una realtà di fatto. È in questo che Scurati risulta, rispetto all’autore de Il fascismo eterno e quello de Il filo nero, grossolano, macchiettistico, una caricatura. Concentrandoci poi sulla tesi in sé e per sé, anche quella di Eco e Bocca, comunque, resta problematica. Quella di Eco perché finisce per rendere fascista qualsiasi corrente politica che non sia progressista, ma un progressismo sovietico però; e quella di Giorgio Bocca perché, sostanzialmente, nasce come tentativo di rientrare – dalla finestra – nell’area di influenza di Repubblica, come ricorda anche Marcello Veneziani. Sì, perché il primo Bocca, quello del Mussolini socialfascista, tutto avrebbe detto del fascismo eterno tranne che fosse una prerogativa, sostanzialmente, della destra di Fiuggi (cosa che invece sosterrà a più riprese, qui in accordo con Montanelli, negli anni a venire).
Perché, quindi, Augias non ha pensato di invitare uno storico ancora in attività, con alle spalle un recensissimo volumone sulla storia del fascismo edito da Laterza (non una casa editrice revisionista): Emilio Gentile. Forse perché, promozione a parte, avrebbe spiegato alla popolazione audiovisiva del dottor Cairo che no, il fascismo in Italia non è tornato? Anche Scurati scegliesse di non parlare specificatamente della nuova ondata nera (ne dubitiamo), la sua sola presenza sarebbe lì, nello studio, ad attestare proprio il pericolo di un ritorno al fascismo (che forse si avverte piuttosto oltreoceano, con Donald Trump ed Elon Musk). E si dica questo con tutta la simpatia che si può avere per lo Scurati che, recentemente, ha difeso l’idea sacrosanta e sensata di un riarmo europeo.













