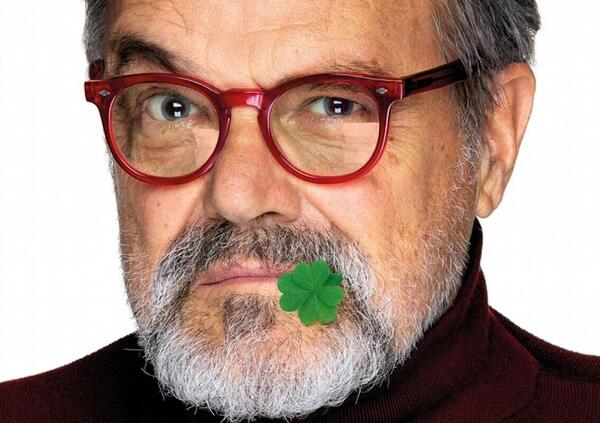Edizione di pregio, era il 2006. Il libro, tirato in 300 esemplari per “Josef Weiss Editore”, smobilitò la redazione. Ci fissammo, stupefatti. Il prefatore – Arsenio Cassirer – parlava di “un poeta che cerca nell’amore una giustificazione al vivere e nei versi una giustificazione all’amare”. Frase sibillina, palindroma al nulla. Nonostante la grazia della stampa, le poesie erano davvero brutte. Ne cito una:
Mare
Riflesso dell’anima
Flutti delle passioni
Inganno del viaggio
Colloquio celeste.
Appunti sonnambuli, vaghi gargarismi verbali e poco più. La silloge, Perdonare Dio – che, secondo il prefatore, “ricorda il Sono apparso alla Madonna di Carmelo Bene” –, era firmata da Agostino da Turlago. Un nome tanto improbabile da far supporre lo scudo dello pseudonimo. Il gioco a nascondino durò un anno. Le Edizioni della Meridiana, nel 2007, pubblicano lo stesso libro, con lievi modifiche nella composizione; dietro Agostino da Turlago si cela Sandro Bondi, già Sindaco comunista, poi Ministro dei beni e delle attività culturali del Governo Berlusconi, dal 2008 al 2011. L’introduzione di Davide Rondoni, poeta accreditato, esercizio di contorsionismo retorico – “Tra dediche e lievi epifanie queste parole si offrono in una nudità che disarma... Qui succede qualcosa, ed è questo che conta” –, non riuscì ad elevare le poesie di Bondi. Brutte erano, brutte restano. L’unico carisma di Bondi – il pudore – sacrificato sull’altare della vanità lirica. Emblematica la poesia A Walter Veltroni, “Tenero padre/ madre dei miei sogni”. Già che ci siamo: nella mitragliata di “romanzi” di Veltroni – di recente si è dato al giallo, l’ultimo s’intitola C’è un cadavere al Bioparco – ne ricordo un paio – L’isola e le rose, e Ciao –, effimeri.

Altra riva, storia analoga. Nichi Vendola – già deputato della Repubblica e Presidente della Regione Puglia – ha detto che si darà al palco, dando sfogo alla passione politico/poetica. A differenza di Bondi – che ha avuto il buon senso di non pubblicare più –, Vendola ha raccolto le poesie scritte & pubblicate negli anni in un volume complessivo, Patrie, stampato da il Saggiatore nel 2021. I versi non permettono esercizio critico: banali, spesso astrusi, propri di chi ha letto poco e deliberato troppo. Ne allego alcuni, per capirci:
La mia pazienza è di cenere e brace
prospettiva fallace
di petrosa santità
spezzata da una linea vorace
inspermata di caducità.
Silenzio ordinato
strato su strato
fino all’orlo pazzo
d’un gesto, cazzo!
Esercizi spermatici, seghe liriche, cazzate, insomma. La poesia elegge chi le pare, lo straccione o il re, il capo di governo o la capa ’e cazzo; ma se della poesia, in genere, frega a nessuno, del politico che fa versi parlano tutti. La rassegna stampa di Patrie è imbarazzante, del libro – davvero imbarazzante – si è parlato anche in tivù. Eppure, un poeta autentico come Alessandro Ceni non lo vedete nei talk, non lo leggete sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, non imbratta i social. Anche un illetterato – incorrotto dai sofismi e dalle ambizioni avvoltoie degli intellettuali –, però, capisce che Ceni è un poeta (esempio: “io non so se dormissero/ o fossero morti nella segatura;/ so che finalmente vedevo il buio/ e in esso nulla che fosse d’umano”), mentre Vendola è un insipiente. L’insistenza con cui il divo Nichi inghirlanda la cronaca di versi finisce, nonostante le intenzioni, per sputtanare i fatti, per annacquare la Storia nel bidet dei propri sentimenti vaghi, biechi, il lavatoio dell’ego. Così, la morte di Carlo Giuliani, a cui Vendola dedica un Lamento, è semplicemente vilipesa, oltraggiata (“quel carro viene addosso/ che rabbia allampanata”): il critico smaliziato noterà, semmai, sottili richiami all’opera di Bondi, forse i politici si passano i testi (“arca del mai partire/ arco del tuo finire/ freccia dentro uno scoglio/ fumogeni a morire”). Alcuni distici (“La notte preventiva di Baghdad/ doleva nella sfera dei bla-bla”) paiono un’arlecchinata, il deputato che si traveste da Uomo Ragno per arrampicarsi sui vetri del Parlamento, tra i cori di una falange di lacchè; fanno rimpiangere l’era in cui si facevano studiare a memoria le poesie di Pascoli alle elementari, per apprendere la postura del verso, una personalità nello stare al mondo, quanto meno il rispetto.

Una poesia – La sconfitta – è dedicata a Pietro Ingrao, già Presidente della camera, comunista, con il vezzo, pure lui, della lirica. Ha pubblicato Il dubbio dei vincitori nel 1986, per Mondadori, il vecchio Ingrao; di Variazioni serali, stampato da il Saggiatore, Enrico Testa disse, lapidario, che era un libro “importante”. Sarà; le poesie sono minime, misere, senza mistero (un esempio: “Tuo cuore, macchina,/ dove conduce/ stilla dopo stilla/ stiamo scoprendo. Né ci basta/ immaginazione/ d’universo”). Per carità, anche Filippo Turati è autore di poesie dimenticabili, dimenticate, intrise di bile politica, che palle, come questo inno Ad Epicuro:
Sì, leva il capo, o savio. È sfracellato
Geova dal maglio del pensier titano,
e il blando Cristo, il sognator malato,
nel chiuso avello si dibatte invano.
Il punto, appunto, non è estetico – manca la materia prima – ma psicologico, semmai, forse psichiatrico. Perché un politico sente la necessità di mutarsi in poeta? Se la poesia, di per sé, non porta alcun prestigio sociale al poeta – al contrario: lo confina in una specie di estatica abulia, nell’altro mondo dei reietti, degli irredimibili, degli sfigati –, sembra il sigillo che santifica la carriera del politico. Che paradosso lancinante: il politico che fa poesia – ma non fa nulla per la poesia – acquisisce un appeal elettorale, una profondità plastica, platonica, diventa perfino più bello. Per assolversi il potere ha bisogno della poesia, ma per giustificarsi ammazza il poeta. Il meccanismo è spiegato da Iosif Brodskij, poeta, apolide, fuggito dall’Unione Sovietica che lo aveva processato per “parassitismo sociale”, in un saggio intitolato Il figlio della civiltà, dedicato a Osip Mandel’štam, il grande poeta morto nei Gulag. “Un poeta”, scrive Brodskij, “si mette nei guai non tanto per le sue idee politiche quanto per la sua superiorità linguistica e, implicitamente, psicologica. Il canto è una forma di disobbedienza linguistica, e le sue note gettano un’ombra di dubbio su ben altro che un concreto sistema politico: mettono in discussione tutto l’ordine esistenziale”.
Che schifo di Paese questo, allora, in cui troviamo in libreria le poesie patetiche di Vendola – “la mia patria è il salto/ dei delfini/ che danzano a prua/ della nave Mare Jonio”, ma per pietà, un po’ di patria decenza... – ed è cronica l’assenza di Antimemorie, il memoriale bugiardo e prodigioso di André Malraux, romanziere di genio, politico di rango; che Italia becera quella che legge i romanzi di Walter Veltroni e di Dario Franceschini e ne discute perfino, ma non pubblica le poesie di Saint-John Perse, Nobel per la letteratura nel 1960, tra i rari poeti di ogni tempo. Alto diplomatico, durante il quindicennio in cui fu stretto collaboratore dei presidenti del consiglio francesi impedì che si pubblicassero le sue opere; letterato implacabile, uomo integrale, che coltivava l’alta virtù della sprezzatura, riteneva che l’attività politica non potesse conciliarsi con quella poetica. Svergognati, invece, i politici gareggiano nel mostrarci le proprie vergogne editoriali, manoscritti che, con garbo e destrezza etica, andrebbero riposti nell’armadio, insieme agli altri, alti scheletri. D’altronde, nei paesi anglofoni esiste la carica del “Poet Laureate”, che sancisce il ruolo ‘civile’ e morale del poeta, in quelli ispanici il poeta è omaggiato con premi considerevoli – il “Reina Sofía de Poesía” vale 42mila euro; il “Cervantes” 125mila –, in Francia, se va bene, li insediano nell’Académie française. In Italia, piuttosto, il poeta viene disintegrato e digerito negli apparati parlamentari, eletto “senatore a vita”; di fatto, ormai vecchio, ha un compito ornamentale, museale, iniquo. È come un canarino nella gabbia, sotto il controllo degli avvoltoi. Puoi dargli da mangiare qualche briciola: accorrerà, felice, sullo spartito della tua mano.