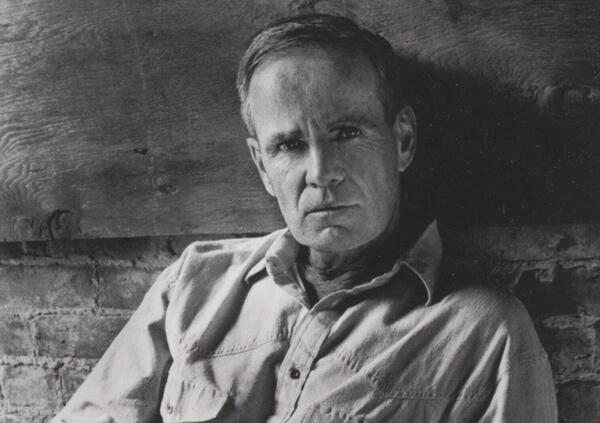«“Sbaglio o lei è...?” Yes, dottore. I am». È la fine del primo breve quadro intitolato Espressione intraducibile, con cui inizia l’ultima opera letteraria di Michela Murgia che recentemente ha annunciato di avere una neoplasia ai reni e che licenzia in pochissimo tempo questo libro definito da alcuni “urgente”, “necessario”, “coraggioso”. Il primo termine che mi piacerebbe sentire usare per un romanzo è “bello”. Se non bello, “sublime”, cioè dotato di quella bellezza terrificante dei grandi eventi naturali e della grande arte (dei romanzi di Cormac McCarthy per esempio, recentemente scomparso). Certo, nessuno di questi due attributi si addice a Tre ciotole (Mondadori 2023), che a definirlo “fatica letteraria” si direbbe una bugia. Per quello che potrebbe essere l’ultimo libro, o quasi, di un’autrice con tale diffusione (lei sostiene che le rimangano pochi mesi di vita), Michela Murgia chiede pochissimo, quasi nulla, alla sua penna. Ma soprattutto si smaschera.

L’atteggiamento paternalistico della Murgia, che bacchetta e fa la morale al prossimo perché non vuole sentirsela fare, si esprime in Tre ciotole in modo petulante, senza ispirazione. La Murgia è scrittrice ingombrante, sostanzialmente annoiata da quello che scrive. Per descrivere la luce nella prima pagina si scrive che «splende con quella forza solo su Roma». Per parlare del dramma di quel momento (che la Murgia ha vissuto) la scrittrice pesca la prima carta del mazzo, non la seconda o la terza o la decima, ma la prima, la più immediata, delle associazioni di idee. Avendo davanti un dottore l’immagine è questa: «Il medico fermò la traccia dell’ultima linea all’altezza delle altre e le cauterizzò tutte con un piccolo asterisco». Certo, la Murgia stessa si definisce “refrattaria alla scrittura letteraria” e potremmo (ma dovremmo?) perdonarlo l’uso dozzinale, infantile, persino scolastico, del genere narrativo. Ma la domanda sorge spontanea: perché? Perché non scrivere uno di quei trascurabilissimi saggi da opinionista senza nerbo? Una di quelle menate pubblicate da Einaudi (casa editrice berlusconiana) o da Mondadori (casa editrice berlusconiana) che entusiasmano le amiche femministe, gli amici comunisti e qualche telespettatore della politica (cioè di Fazio)? Perché proprio un romanzo (o collezione di racconti), la cui forma e la cui destinazione sono irrisolte, pericolose, violente e insaziabili? Tutti elementi di cui non è dotata.

Nonostante tenda a volersi descrivere come intellettuale engagé e “rompipalle”, vantando le offese dei politici italiani, clowneschi rispetto a quelli che in Francia l’hanno nominata Cavaliere delle Arti e delle Lettere, non è la donna di lettere antisistema che crede. Famiglia queer, scrittrice di sinistra, popolare, persino fotogenica. Amica di Chiara Valerio – pallone d’oro di riconoscimento pubblico nell’ambiente letterario, a partire dalla direzione di Più libri più liberi a Roma) – e di Roberto Saviano, personaggio televisivo e consumatore di inchiostro (e di tweet) onnipresente. Non esattamente la reietta, isolata, e ghettizzata che invece si sente di essere. La sua posizione, il suo ruolo, l’indice che punta sui meritevoli di biasimo, la rendono piuttosto la più patriarcale tra le compagne femministe. E questo per almeno due motivi. Il paternalismo di cui è impregnata è una delle caratteristiche principali del dominio dell’uomo eterosessuale e bianco sulle donne e gli altri gruppi assoggettati: dal mansplaining al modo di trattare vallette e co-conduttrici in TV, le Non una di meno della situazione hanno sempre accusato l’uomo di avere un atteggiamento condiscendente o ammonitore nei confronti dell’altro sesso, quasi come se vedessero le donne come infantili, non propriamente adulte, non propriamente intelligenti. Michela Murgia rende (sui giornali, nei suoi libri, in TV, in radio) proprio per la tendenza a voler fare la paternale a tutti. I machisti, i destrorsi, gli antipatici. Ma papà Murgia, secondo le sue stesse idee, diventa così padre padrone, cioè non solo moralista ma anche marchingegno di un sistema di dominio sugli altri.

Il secondo motivo, invece, è l’accoglienza. Mentre scrittori e critici come Massimiliano Parente e Davide Brullo sono stati braccati ed esclusi in diverse forme (Parente parla di una raccolta firme promossa dalla Murgia per impedire la pubblicazione di un suo romanzo; Brullo correlò il suo licenziamento da Linkiesta al trio Terranova, Ciabatti, Veronica Raimo), Michela Murgia gode di platee e di libertà di parola, non solo in questi mesi di gentilezza a volte forzata a volte no, ma da molti anni. Lei usufruisce, bene o male, di tutto ciò che questa società patriarcale ha da offrire. I palinsesti televisivi e i quotidiani diretti da uomini che, virtuosi o meno, saranno sempre in qualche modo complici (una volta scrisse: «Nascere maschi in un sistema maschilista è un po' come essere figli maschi di un boss mafioso»), non le negheranno mai un cantuccio per poter dire la sua. E sarebbe anche un bene, se solo questo ci evitasse i suoi libri promozionali, fatti per ricordare al mondo (e a se stessi?) quanto si sia nel giusto. E sapersene vantare, forse involontariamente. Proprio con quel “Yes, dottore. I am”, confinato in un inglese che tradisce anche un certo narcisismo, l’unica forza presente nel libro, fatto di dodici didascalici siparietti sulla precarietà della vita (manca solo una citazione di Ungaretti), scritti senza interesse per la lingua, per i propri lettori e per il messaggio. Basta leggere la scena di sesso fatta di “perineo”, “sesso” e un dubbio: ma la Murgia sa di cosa parla?