Mi sono imbattuta nel libro Gay Bar. Perché Uscivamo la Notte (edizioni Minimum Fax con eccelsa traduzione di Sara Reggiani) di Jeremy Atherton Lin, scrittore e giornalista asio-americano, mentre facevo incetta di alimenti per il cervello in una libreria. Altro che saldi, il mio è consumismo culturale. L’ho acquistato attratta dalla copertina, dal titolo e dalla sinossi che raccontava di come il bar fosse al tempo stesso rifugio, palcoscenico, spazio di incontri, di solidarietà e di espressione sessuale: “Il bar gay è stato a lungo il luogo in cui una comunità priva di diritti e rappresentazione, esclusa dal centro della scena e delle città, ha potuto riunirsi, sperimentare l’appartenenza, esistere davvero". L’incipit del libro è: “Comincia a esserci puzza di pisello… Ma che bel culetto abbiamo!” ma vi assicuro che la lettura integrale vi farà scoprire uno stupefacente esordiente – questo infatti è il primo libro di Atherton Lin – che spazia tra analisi politica, ricostruzione storica, aneddoti personali, memoir erotico, il tutto condito da esilarante ironia e da attenta ricerca, fatta in prima persona nei locali storici sparsi tra Los Angeles, San Francisco e Londra, con breve menzione del leggendario Stonewall Inn nel Greenwich Village di New York.
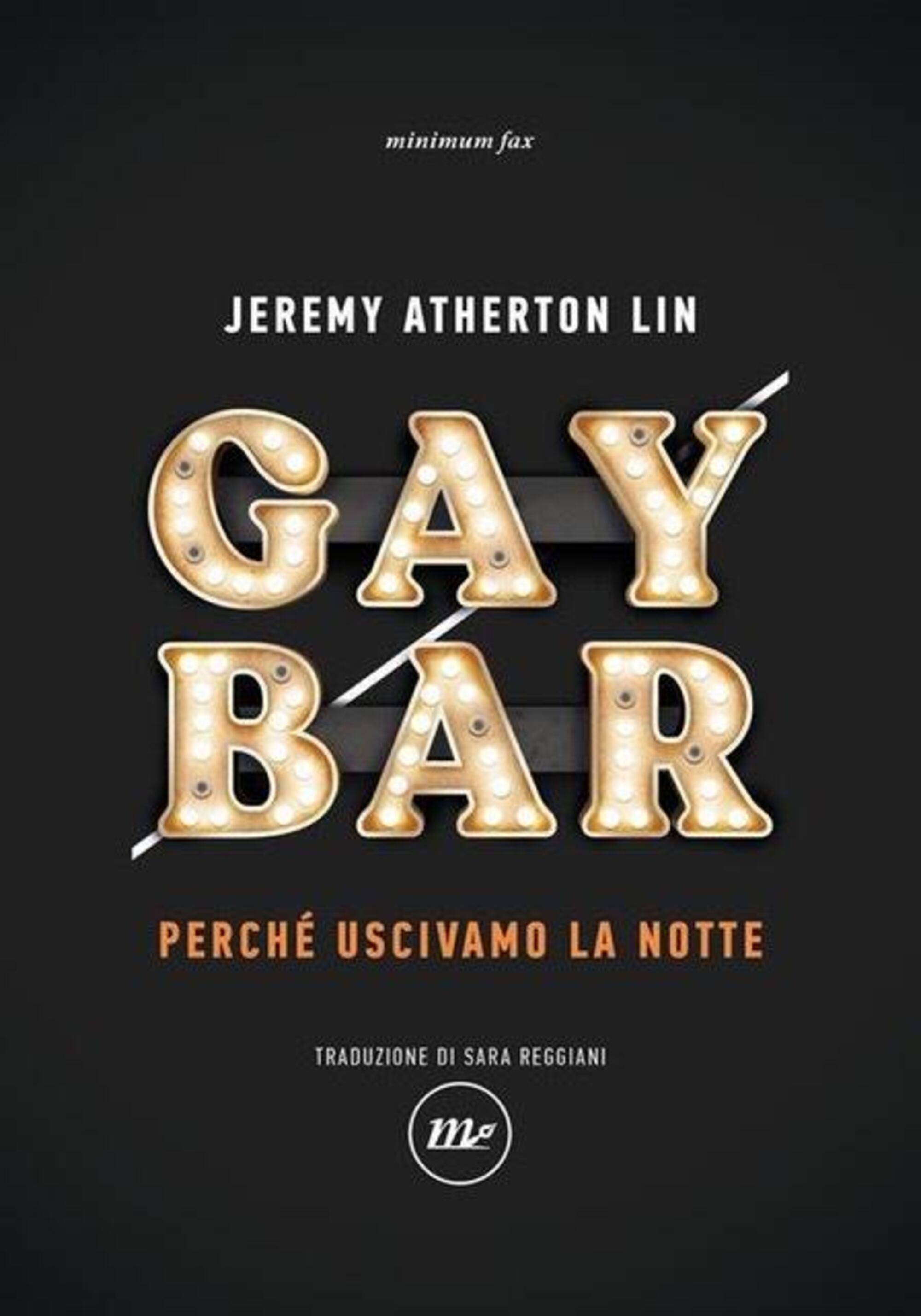
Negli anni Sessanta, lo Stonewall, dove ancora oggi si respira l’odore del seedy underbelly – quel ventre molle e poco raccomandabile della NY dei tempi passati – un misto di birra e cum, era l’unico locale a consentire a omosessuali, lesbiche, trans e “reietti” della puritana società americana di aggregarsi, ballare e bere alcolici. Di fare comune tra gli ousider. Il locale, che l’autore definisce un posto di merda, era gestito, come molti altri bar gay, dalla mafia e serviva drink annacquati. I famosi Moti di Stonewall ebbero luogo lì il 27 giugno 1969 contro i continui e omofobici raid della polizia. A scagliare la prima “pietra” fu Sylvia Rivera, transgender divenuta poi attivista dei diritti della comunità LGBTQIA+. Le 300 pagine si sfogliano e godono con leggerezza e curiosità, si evince il libidinoso desiderio notturno per gli incontri tra corpi sconosciuti quando si usciva per assaporare l’aroma, per ricercare guai, per ballare – Ci sono notti che hanno un battito udibile, e noi balliamo – per il cruising (l’atto del rimorchiare), per stordirsi, per fuggire convenzioni e privazioni, per mescolarsi in una lussuriosa ed erotica miscela di liquidi tra omo-satiri dall’aspetto virile in un sottobosco dove regnavano maschismo, loschezza e dissolutezza e l’amore per il rischio sembrava essersi sublimato in un’estetica del rischio. Atherton Lin racconta la scena queer tra West Coast e Inghilterra, dove si trasferisce quando s’innamora del suo attuale compagno, Famous, a cavallo tra tardi anni ’80, ’90 e gli anni 2000, quando l’autore sente il proprio territorio minacciato, non più dalla polizia, ma più dalla pulizia, con gentrificazione di massa e speculazioni immobiliari che hanno trasformato, quando non addirittura chiuso per sempre, alcuni storici locali gay.

Il primo capitolo – Viali Oscuri, Londra – si concentra sulla capitale inglese dove a spiccare è il Tavern, uno dei gay pub più antichi del paese, dichiaratamente tale dal 1950, ma anche il Vauxhall. L’autore ci informa che solo nel 1967 fu emanato il Sexual Offences Act, che aveva reso in parte legale il sesso fra uomini in Inghilterra e Galles. La legge riconosceva il diritto di due uomini – mai tre o più – di entrare in intimità entro i confini di spazi rigorosamente privati. Per questo, molti dei gay bar non avevano finestre sulla strada o erano ombreggiate da tende, proprio per permettere ai loro assidui e arrapati frequentatori di farsi letteralmente i cazzi loro. Ma non erano solo luoghi da rimorchio, erano rifugi sicuri e accoglienti per chiunque fosse “diverso” dalla etero-normativa imperante. Lì si stringevano, oltre che pacchi, anche amicizie, si conoscevano persone dal vivo, senza le tintinnanti notifiche di Grindr (principale app di gaio rimorchio), si trovava una comune di anime tra persone vittime di omofobia, reclusione ed esclusione: “Usciamo per essere gay. Lo desideriamo più che mai quando la noia del mondo etero torna ad assalirci”. Fu Gertrude Stein nel 1922 a usare forse per la prima volta il termine gay con il significato di “omosessuale” e la prima volta che sulla stampa fu usata l’espressione coming out nel senso di rivelare il proprio orientamento sessuale risale al 1971 in un articolo dell’Observer: “I enjoy my double life. I don’t want to come out.” Il critico Michael Warner scrisse: “Le scene queer sono i veri ‘salons des refusés’ dove le persone più eterogenee entrano in grande intimità tra loro, unite nella comune esperienza di essere disprezzate e rifiutate in un mondo di regole che oramai identificano come falsi moralismi.” Si usciva per sentire dentro qualcosa – sì dentro fisicamente ma anche metaforicamente – per cacciare e scacciare la paura, la timidezza, la repressione vissuta sulla pelle da tantissimi omosessuali, per sentirsi rilevanti per nessuno, per perdere inibizioni e reputazioni.

Nel secondo capitolo – Il Factory, Los Angeles – lo scenario vira sulla West Coast e su club quali il Probe – che compare nel film American Gigolo (1980) con Richard Gere – un luogo di depravazione dove il protagonista si ritrova faccia a faccia con lo spettro di un sé smarrito. Siamo negli anni ’90 e la piaga dell’AIDS, il “cancro dei gay”, diventa la principale causa di morte tra la popolazione giovanile a livello nazionale. Nel 1992 Calvin Klein sceglie Marky Mark come modello per la sua collezione di intimo. The show must go on e l’autore insieme al compagno frequenta locali dove si balla il posing, il punking, il voguing. Erano giovani, monelli e ribelli. La discoteca per i gay svolgeva una funzione sociale mentre per gli etero era un moda. Anche le canzoni erano esplicitamente sessuali con titoli quali A Deeper Love, Deeper and Deeper, Deep Inside … Come nota Atherton Lin: Era la profondità l’ossessione di tutti i testi di quelle canzoni? Profondo significava un enorme pene che si spinge fino a toccare gli organi interni mettendo a subbuglio l’intera baracca. Sono notti selvagge che profumano di popper e sperma, che sguazzano nel rischio e nel mistero, accoppiandosi frementi nelle saune, nei bagni, nei vicoli. Ecco spuntare il Factory, la Farm, anch’esso gestito da malavitosi, il Patch … la vita della notte celebrata nel brano All Tomorrow’s Parties dei Velvet Underground, inno esistenziale all’insaziabilità della vita notturna. Atherton Lin non solo ascoltava, ma viveva quella canzone.
Nel terzo capitolo – L’Adelphi, Londra – l’autore racconta di come il fascino decadente del mondo sotterraneo fu seppellito dall’AIDS e di come la parola gay divenne inestricabilmente legata alla malattia (Gay divenne l’acronimo di Got Aids Yet?). Anche i locali stavano mutando, gentrificandosi e infighettandosi, quasi a volersi ripulire dalla decadenza dei tempi frivoli pre-HIV. Nel quarto capitolo e quinto – Finestre, San Francisco e Il Quartiere, San Francisco – l’autore approda nella città più gaia (un unico grande peep show), la vera mecca del mondo queer: Ogni volta lasciavo la città non solo con un bagaglio di mie esperienze, ma con l’impressione di aver visto l’esperienza dipanarsi intorno a me. Le strade erano come calendari dell’avvento. Ed è in questo crogiolo di svariate e colorate identità, precisamente nel quartiere di Castro, enclave della comunità gay locale, che si dipanò l’epopea di Harvey Milk, , attivista indefesso per i diritti della comunità queer, primo consigliere comunale dichiaratamente gay, prematuramente assassinato nel 1978, insieme al sindaco della città, per mano di un altro consigliere, probabilmente gay “closeted”, ossia non dichiarato. Vi consiglio lo struggente film Milk dedicato alla sua breve vita e interpretato da uno strepitoso Sean Penn, ruolo che gli valse un Oscar. Simeon Wade, autore del libro Foucault in California (recensito per questa rivista dal direttore Moreno Pisto), cita il famoso filosofo francese quando disse: “A dire il vero mi piaceva la scena prima dell’emancipazione gay, quando tutto era più discreto. Era come far parte di una confraternita sotterranea, emozionante e un po’ pericolosa. L’amicizia voleva dire molto, voleva dire fiducia, ci proteggevamo l’un l’altro, ci relazionavamo fra noi tramite codici segreti.”

Era il brivido della clandestinità soppiantato oramai da una sovraesposizione fin troppo commerciale ed edonistica. Atherton Lin rievoca con malinconia l’età dorata di San Francisco, meta e rifugio di tanti avventurieri, poeti, hippie, scappati di casa e dal puritanesimo imperante negli altri stati americani. Qui il poeta della Beat Generation, Allen Ginsberg, recitò il suo poema Urlo, precisamente alla Six Gallery di Fillmore Street, per poi godersi grandi orge felici in un luogo dove aveva finalmente trovato una comunità di simili. Furono anni di reading, trip lisergici, incontri hard, una confluenza devota alla scopofilia, letteralmente una forma di perversione sessuale consistente nel provare piacere alla sola vista della nudità e dei rapporti sessuali altrui: Le nostre erano barbe pervertite, profumate di sudore di scroto. Nei gay bar della città erano totalmente aperti, bohémien, frequentati da tutti, eterosessuali, omosessuali, bisessuali, lesbiche, trans, poeti, curiosi, indecisi, dove vigeva libertà di parola, dove si potevano usare gerghi ed espressioni esplicitamente sessuali. Luoghi rigeneranti per chi aveva vissuto la discriminazione, la violenza, l’apartheid sessuale degli anni del conformismo americano/inglese. Quella fu “l’epoca d’oro gay” – periodo a cavallo tra i moti di Stonewall (1969) e l’avvento della piaga dell’AIDS (primi anni ‘80) – celebrata dalla musica, dalle discoteche, dal ballo e da brani indimenticabili che ancora oggi ci permettono di viaggiare con la fantasia, una sorta di macchina del tempo in grado di riportarci su quelle sudice e sudate piste da ballo, dove la danza era il preludio all’amore, al sesso, alla promiscuità, ad avere erezioni in compagnia e intrecciare sorrisi. San Francisco divenne SanFranDisco, dove la vita era sì rischiosa ma non si poteva rinunciare a viverla: “Il nightclub era un luogo di perdita – di inibizioni, di amici, di cose possedute, di te stesso – un luogo in cui l’abbandono era condizione essenziale per trovare qualcosa.” Gli ultimi due capitoli – L’Apprendista, Londra e Confini – riportano l’autore e il compagno, Famous, in Inghilterra a zonzo per loschi pub frequentati da gay, disadattati, puttane, spacciatori, prostituti, tassisti, criminali, senzatetto e curiosi, in una girandola di incontri e scontri. Ma era proprio questo che andavano cercando: volevano correre rischi, stare vicini ad altri corpi, non sentirsi al sicuro come i gay pantofolai…Si usciva per eccitarsi nella prossimità. Altro che Metaverso, realtà virtuale, social media, app di cucco … la vita vera è nelle notti selvagge. Parola di bestiaccia notturna appartenente alla Generazione X. Come in XXX-Rated!












