Annalena, edito da Einaudi, è quel genere di libro che non si riesce a definire con una parola. Tra romanzo e memoria si potrebbe tendere più alla seconda, e forse in definitiva potrebbe essere considerato una sorta di diario segreto, di quelli che si scrivono per non dimenticare riflessioni intime su noi stessi e sul mondo, ma a pagina aperta, da far leggere anche ad altri. Annalena viene raccontata da Annalena Benini. Le due sono parenti, cugine di terzo grado, e non si sono mai incontrate. È singolare leggere di questa donna che manifestamente voleva passare sotto silenzio. Dalle sue lettere emerge con forza la volontà di sparire, di non essere al centro dell’attenzione, nessun palcoscenico, nessun applauso. Semplicemente non le importava. Ha senso quindi parlarne? Parlare di chi è stata e di cosa ha vissuto in tutta la sua vita, pur sapendo della sua contrarietà? Ci sono vite che non sono più nostre, che una volta vissute non ci appartengono più. Sapere che c’è stato e che c’è nel mondo qualcuno come lei, che è sintesi di estrema e radicale libertà, è per me necessario. Il “romanzo” si chiama come lei e ha due protagoniste, la seconda delle quali è esattamente come noi e non si allontana dalla nostra necessaria quotidianità, ne capiamo i valori, i bisogni, le piccolezze e le debolezze. Perché sono esattamente quelle che viviamo noi. La vita dell’altra Annalena, invece, è insondabilmente un mistero.
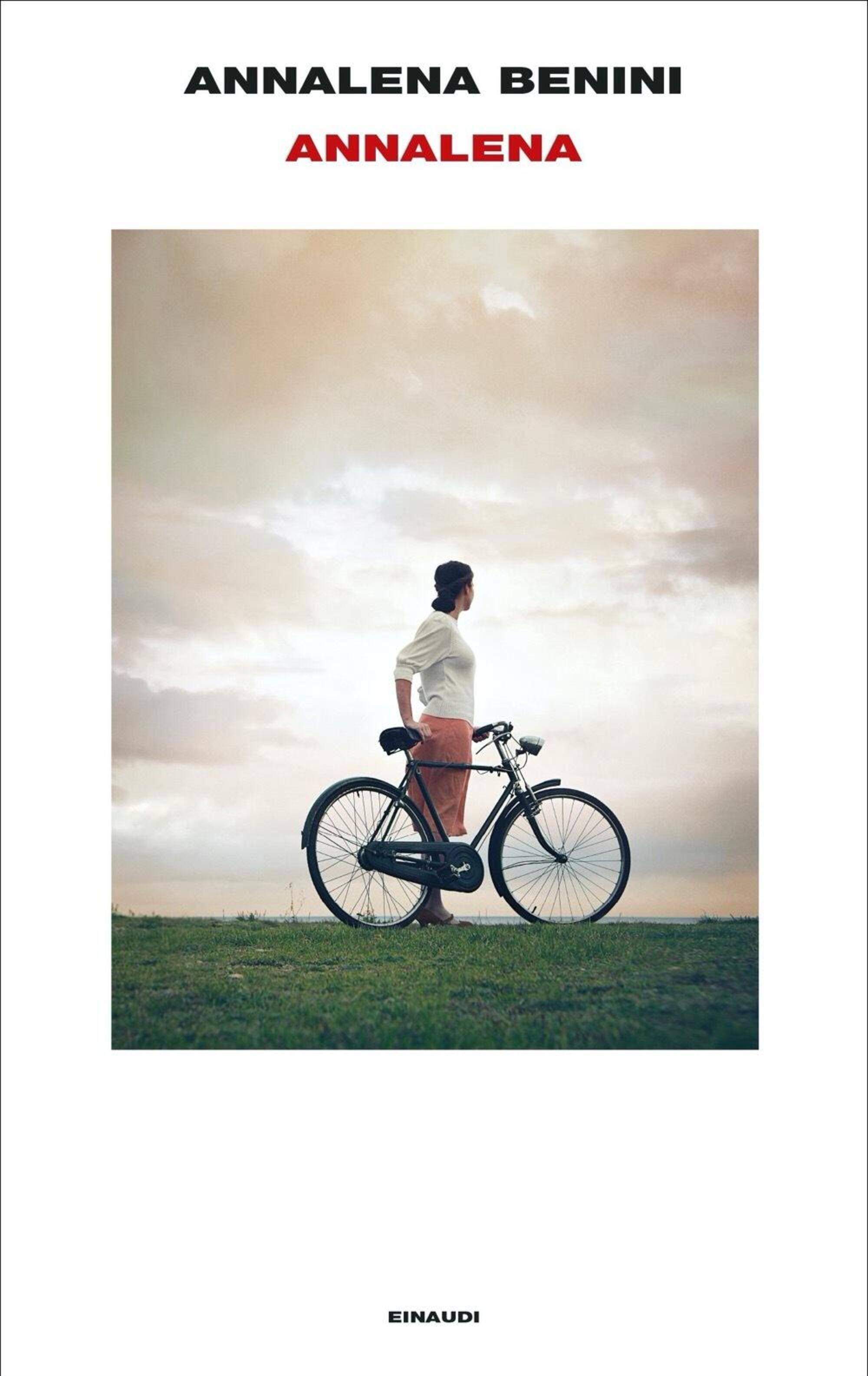
Annalena Tonelli nacque a Forlì nell’aprile 1943 e morì in Somalia nel giugno 2003. La sua intera vita, fin dall’adolescenza, fu per l’altro. L’emarginato la colpì già sotto casa, nella sua città natale, e la seguì fino in Africa. La sua ispirazione era evangelica, sì, ma non religiosa. Non diventò mai suora, non fece parte di associazioni religiose, andò semplicemente accompagnata da sé stessa e visse come vivevano coloro che voleva aiutare, in povertà. Ci sentiamo compresi dall’altra Annalena, alle prese con le sue disavventure quotidiane, con gli amori non corrisposti, con i figli da crescere, i genitori da accogliere, le banalità che costruiscono la nostra vita. Annalena Tonelli partì per l’Africa e lì vi morì, in un attacco codardo alla schiena che non verrà mai risolto. Morì, ma non dopo aver dato e fatto moltissimo: ideò un nuovo sistema di cura per la tubercolosi, così efficace che nel ’76 il governo kenyano le affidò ufficialmente la direzione di un progetto pilota; in Somalia si occupò dei sanatorio e degli ambulatori di Belet Waine e dopo la caduta del regime di Siad Barre, aprì a Merka una struttura ospedaliera con oltre 500 posti letto, una scuola e un centro riabilitativo per disabili, riattivando il porto per consentire l’arrivo degli aiuti internazionali. Garantendo per anni la sopravvivenza dei pazienti. Andò avanti nel proprio progetto di cura, come lo chiamava, tra eccidi e attentati, subendo sequestri e guerre civili. Per le sue denunce venne espulsa dal Kenya come persona non gradita. Ma non demorse e tornò in Africa, in Somalia, e dagli anni ‘90 affiancò alle cure per la tubercolosi dei corsi di alfabetizzazione e scuole, oltre che classi per bambini ciechi, sordomuti o disabili. Insieme ai locali avviò un progetto contro le mutilazioni genitali femminili. Affrontò pregiudizi razziali e di genere, organizzò incontri con gruppi di oculisti per aiutare pazienti nel recupero della vista, accolse i malati di Aids. L’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva riconosciuto la validità del metodo suo metodo di terapia e le affidò un progetto per l’ospedale di Borama nel Somaliland. Dopo il premio ricevuto a Ginevra dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che attirò notevole attenzione, la stampa iniziò a scrivere di lei, delle sue attività. Nell’ottobre 2003, mentre era in visita agli ammalati di Borama, venne uccisa con un colpo alla nuca. Il suo corpo fu trasportato in Kenya e le ceneri disperse a Wajir, nel deserto del Kenya, dove aveva iniziato la sua opera. Nella basilica romana di S. Bartolomeo all’Isola Tiberina, al memoriale dei nuovi martiri, è stato deposta un’agenda di Annalena, con le sue annotazioni e pensieri.

In realtà, se non fosse per un corposo epistolario che testimonia i fitti rapporti che tenne per tutta la vita con amici e parenti, di questa donna sapremmo ben poco. E non a caso: il suo fu un percorso tenuto volutamente nascosto al mondo. “I am nobody”, ecco come si definiva.
“Non sono né posso né voglio essere un maestro. Prendete di me ciò che vi aggrada e costruite il vostro personale edificio. Non ambisco che d’essere gettata nelle fondamenta di qualcosa che cresce perché il seme deve morire. Un giorno fiorirà- io non ho il desiderio di vedere il fiore. Altri lo vedranno”. Questa visione della vita che per essere vissuta a pieno deve implicare il liberarsi da sé stessi, spendendosi fino alla fine per divenire altro, è il filo conduttore che la lega ad altre grandi pensatrici della storia. Parlava apertamente di Etty Hillesum, di quanto le sue lettere appassionate e struggenti la facessero sentire compresa negli stessi termini di vita vissuta, e anche Etty, come Annalena, visse per gli altri, sacrificandosi poi nei campi di sterminio nazisti. Il mistero di queste vite di donne mistiche, che appaiono così lontane da noi, così vicine alla grandezza, sono accomunate da una violenta spinta passionale verso gli esseri umani, verso quelli che Annalena definiva “brandelli di umanità ferita”.
Durante la lettura di queste memorie si può pensare a un concetto caro ad Aristotele, quello di entelechia. Per il filosofo, essere in atto ed essere in potenza sono cose diverse. Dentro a ogni essere c’è un qualcosa che lo rende unico, e questa è la sua causa: entelechia significa raggiungere il pieno sviluppo secondo le proprie regole interne. Solo in questo modo si giunge all’essere come potenzialmente può essere. Questo, nella pratica, risulta pressoché impossibile ma rende l’idea che ognuno abbia un percorso unico, definibile solo da sé stesso. Dalla lettura di questo libro emerge un dettaglio fondamentale, che ci viene svelato anche dalle parole della stessa Annalena: io ho vissuto una vita piena, al mio massimo. “Nella mia vita non c'è rinuncia, non c'è sacrificio. Rido di chi la pensa così. La mia felicità è pura. Chi altro al mondo ha una vita così bella?”. Forse l’espressione definitiva di quel concetto aristotelico della vita e dell’essere che ha raggiunto il suo pieno sviluppo e la sua definitiva causa. Sapere che si vive del dono e del motivo che ci spinge diventa così atto di puro coraggio: “Io non ho il desiderio di vedere il fiore. Altri lo vedranno”.













