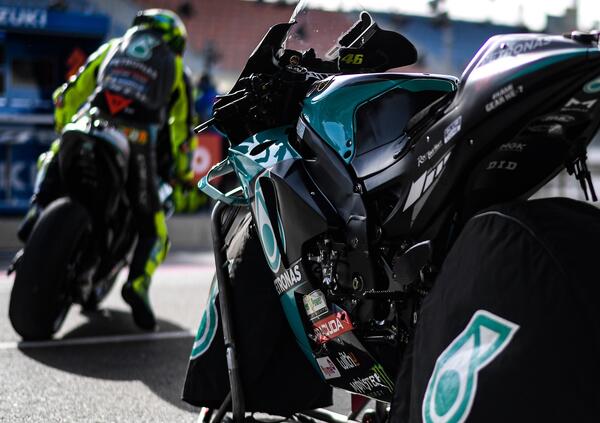Questo articolo necessita di una breve premessa. A scriverlo è un autore che è stato convintamente anti-sacchiano, al punto da inventare una figura letteraria della resistenza all'avvento della sacchizzazione del calcio italiano (Nedo Ludi, stopper dell'Empoli protagonista di due romanzi). Poi il tempo ha stemperato questa predisposizione. Non tanto perché siano cambiate le idee e i motivi di dialettica (quelli rimangono saldi), quanto perché arriva un momento in cui tutto quanto va storicizzato. Salvo che si parli di crimini contro l'umanità, ovviamente. E non mi pare sia questo il caso. L'articolo vuol essere un dovuto riconoscimento al personaggio che comunque ha lasciato un segno nella storia del calcio italiano e internazionale. Scritto con ragionato affetto e nel rispetto di una distanza che deve rimanere.
Settantacinque e sentirli tutti. Arrigo Sacchi giunge a una tappa cruciale della vita, i tre quarti di secolo, e se si guarda intorno scorge tutte le tracce della stratificazione storica. Si chiama “peso degli anniversari”. Un gravame complicato da sostenere, denso di un'ambivalenza che rende impossibile separare il bello dell'aura di storicizzazione dal brutto del tempo che non torna. O che magari torna col timbro sbagliato.

I settantacinque anni dell'uomo di Fusignano sono comunque una ricorrenza che tutto il calcio italiano ha il dovere di celebrare. Anche coloro che con questo romagnolo testardo, ferocemente convinto di possedere il fuoco dell'Idea, hanno litigato senza far sconti. Perché in fondo litigare è vivere. E ce ne fossero ovunque di nemici cristallini, onestamente e convintamente schierati dall'altra parte della linea, come l'Arrigo. Sicché scopriamo che è proprio questo a mancarci, nell'epoca del Consociativismo 4.0 che è il codice morale corrente della nazione. Quell'assembrarsi nell'ipertrofica terra di mezzo che permette di passare in un amen dal governo gialloverde al governo giallorosso capitanati dall'avvocato del popolo, per scivolare infine dentro il governo dell'euro-tecnocrate senza popolo. E scoprire che in questa traiettoria possono starci tutti o quasi, a meno di essere portabandiera dell'irriducibilismo “à la Melonì”: schifare tutti e tutti distanziare per garantirsi una rendita di posizione. Rispetto a questa zuppa immonda, l'Arrigo è davvero l'uomo di un'altra epoca. Padre e figlio al tempo stesso di uno Zeitgeist che viaggiava veloce verso il bipolarismo. E che alla stessa velocità avrebbe visto quel bipolarismo schiantarsi contro il muro.
Ma lui non poteva saperlo.
Diversamente italiano – A Arrigo il calcio all'italiana non piaceva. Né gli piaceva quel certo modo di rappresentare l'italianità che il calcio è sempre stato. A suo dire una mentalità speculativa, furbesca, troppo concentrata sui qui e ora e senza la minima ambizione per l'ampio respiro. Sbagliava analisi, e anche in modo clamoroso. Perché l'arte di arrangiarsi è parte del genio italiano, non la sua zavorra. Il carattere nazionale si forgia attraverso prove che un popolo quasi mai si sceglie e a cui dà le risposte che gli riesce. Ma infine questo insieme di evenemenzialità assortite forgia un modo di essere, di cui lo stile nazionale nel giocare il gioco del calcio è espressione. Con quel genio il calcio italiano ha conquistato una grandezza prima di Sacchi, l'ha confermata nell'epoca del sacchismo, ha stentato a mantenerla e infine l'ha vista decadere dopo lo spegnersi del sacchismo.

E tuttavia, detto dell'analisi sbagliata, su un altro aspetto l'Arrigo aveva ragione e se l'è vista dare dalla storia. C'è stato un momento in cui questo paese è parso stanco di essere sé stesso e ha bramato il cambiamento. Ha bramato di essere altro da sé. E il calcio, che di questo paese è la più profonda autobiografia della nazione, è stato il fronte più nitido della contraddizione. Già attraversato da una caricaturale contrapposizione ideologica fra gioco a uomo e gioco a zona (ma di tanta caricaturalità avremmo preso coscienza soltanto negli anni a venire), il nostro mondo del pallone agognava una svolta. Forse un giorno bisognerà indagare sul perché si sia diffusa tanta ansia di essere diversamente italiani, nel calcio come altrove. Sta di fatto che in un contesto storico-sociale marcato a questo modo, un diversamente italiano per vocazione come l'Arrigo ha incarnato la parabola dell'innovazione. E retrospettivamente ci racconta non già il “come eravamo”, quanto il “come volevamo essere”.
L'Italia che si voleva bipolare (e lo era in senso clinico) – Arrigo è stato un rivoluzionario? Assolutamente sì. Arrigo è stato egli stesso la rivoluzione? Ma assolutamente no. E farebbe bene a rendersene conto lui per primo, che ancora cade nella tentazione di egotizzare il cambiamento del calcio italiano e stagliare intorno al proprio profilo i contorni della vocazione messianica. Stay human, Arrigo. Che magari risulti anche più simpatico.
La verità è che l'uomo di Fusignano ha avuto una fortuna sfacciata. E lo si dice senza alcuna intenzione di sminuire, ma anzi guardando all'etimo del termine. Fortuna come “fors”, cioè sorte, un termine che ha la medesima radice del latino “ferre”, portare. Dunque, ciò che porta la sorte. L'imperscrutabile combinazione degli eventi che bacia qualcuno e disdegna i più. Sicché il vero “cul de Sac” è stato l'essere lì dove passava la Storia e mostrare una sintonia perfetta col suo codice misterioso.
Spiegare? Razionalizzare? Tutto tempo perso. L'Arrigo ha saputo cogliere il momento – la fortuna, appunto – per farsi rivoluzionario. E il momento era quello giusto. Il calcio italiano che voleva cambiare nel paese che voleva cambiare, con una classe politica che invece si arroccava nella conservazione e perciò sarebbe stata cambiata in modo traumatico di lì a poco. E quella rivoluzione sui campi da gioco, in un'Italia dove il calcio è sempre stato la politica proseguita con altri mezzi, si trasformava nella politica anticipata con altri mezzi. Fino a arrivare al rovesciamento di senso, con la politica trasformata nel calcio proseguito con altri mezzi. La mitica discesa in campo doveva ancora arrivare e è indimostrabile fosse già in via di pianificazione, ma intanto il terreno veniva ridisegnato in modo da renderla possibile. Il campo da gioco come uno straordinario palcoscenico della semplificazione, per l'Italia che in quella fase storica aveva orecchie soltanto per la parabola del Nuovismo. Che era innanzitutto estrema riduzione di complessità. La fabbrica dei bipolarismi. Ché invero questo desiderio di semplificazione lo abbiamo sempre portato dentro, noi italiani. È stato anche per questo che abbiamo inventato la via italiana al western. Perché il western, col suo schema ultimo del duello fra il buono e il cattivo, fra le idee di Bene e Male, è l'estrema semplificazione dei dilemmi morali del quotidiano, il placebo del nostro irrisolvibile bizantinismo. Il bipolarismo come sindrome psichiatrica ma declinata come se fosse formula politica.

Il (mancato) talento da surfista – E allora avanti con uomo vs zona, vecchio vs nuovo, e Trapattoni vs Sacchi. Schemi della semplificazione che avrebbero trovato il culmine nella mistica del bipolarismo uninominale e nel suo successivo naufragio fra meschinità e sbadiglio. Ma l'Italia di allora ci credeva, a questo sogno d'essere diversamente italiani. Per questo, nel campo che è stata la perfetta rappresentazione della propria autobiografia, un diversamente italiano come l'Arrigo ha trovato l'eccelsa fortuna. E lì si è fatto rivoluzionario.
Ma un rivoluzionario imperfetto, tuttavia. Perché in massima buona fede ha creduto che la rivoluzione fosse l'Idea. E invece la rivoluzione è soprattutto tattica. Volgare compromesso fra sogno di rovesciare un ordine e adattamento alle cose possibili. Gioco di rimessa, esattamente ciò che lui disdegna. Essere rivoluzionari è cavalcare l'onda, con talento da surfisti come spiego Eric Hobsbawm. Non sei tu a generare l'onda impetuosa della rivoluzione, né sei tu a governarla o a darle potenza e direzione. Puoi solo avere la somma fortuna si trovarti sulla sua cresta quanto è all'apice. E a quel punto devi assecondarne ogni respiro, senza mai dimenticare che l'onda ha una dinamica sua e tu mostrarti capace soltanto di starci su in equilibrio. Il grande equivoco di Arrigo è stato questo: ha avuto la fortuna di trovarsi sulla cresta dell'onda, ha avuto la cecità di credere che l'onda fosse lui. E forse lo crede tuttora, perciò non si capacita di certe fragorose cadute. Nel giorno dei suoi settantacinque anni, e dopo averne storicizzato la figura, glielo si può anche perdonare.
Tanti auguri Arrigo. Ci si rivede fra un altro quarto di secolo.