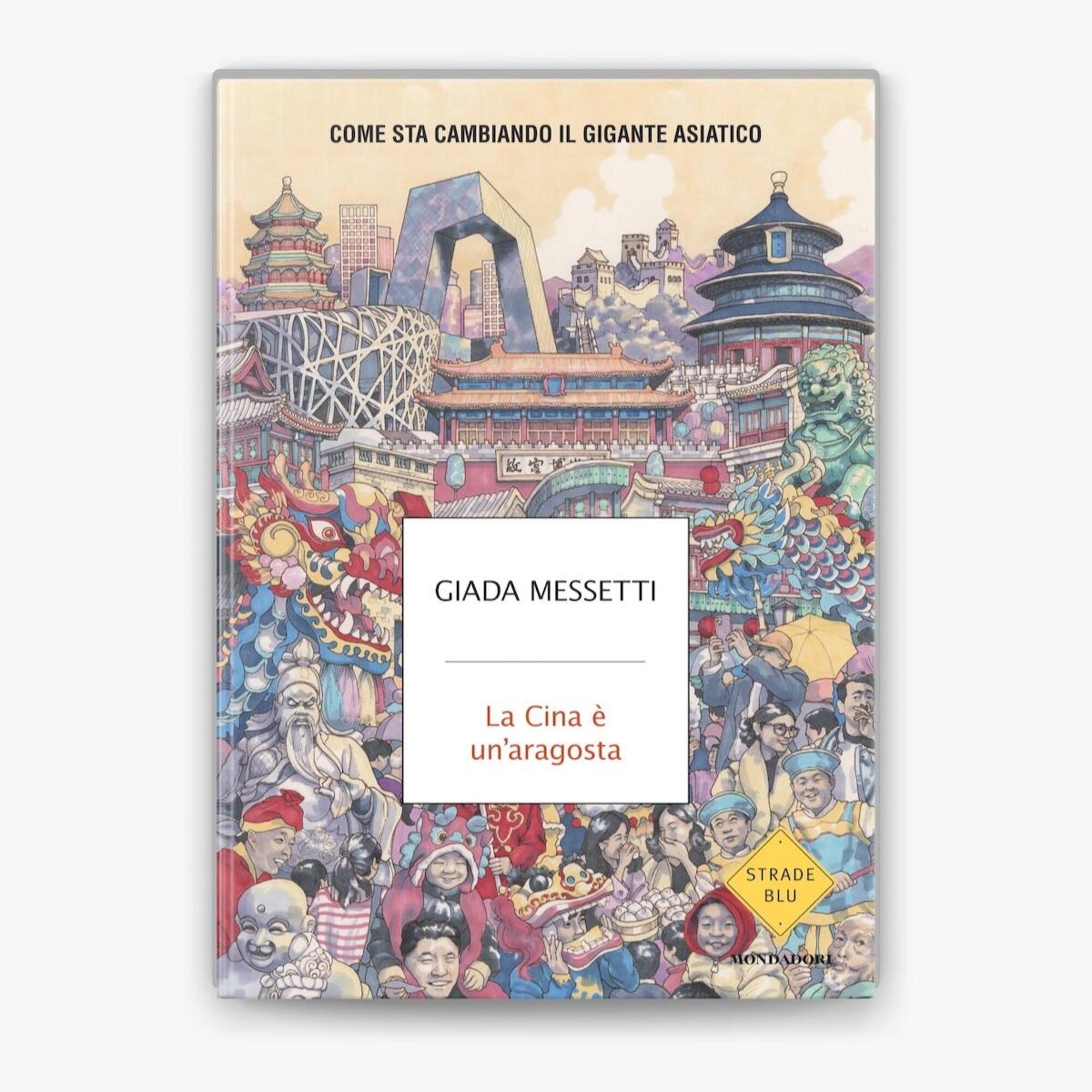“La guerra non è mai inevitabile, le armi possono e devono tacere, perché non risolvono i problemi ma li aumentano”. Chissà se Donald Trump e Xi Jinping la pensano allo stesso modo di Papa Leone XVI. Chissà se i presidentissimi di Stati Uniti e Cina si rendono conto di quanto siano diventate pericolose le tensioni tra le superpotenze globali che amministrano. Ripetono che prima o poi Washington e Pechino troveranno un accordo. Sono però, appunto, parole perché la realtà, come spesso succede in casi del genere, sembra muoversi in un'altra direzione. Ok, le delegazioni dei due Paesi si sono incontrate in Svizzera e in qualche modo sono riuscite a congelare i dazi che avrebbero minato il commercio internazionale. C'è però molto altro dietro il confronto Usa-Cina, e non tutto passa attraverso l'import-export. Certo, gli Stati Uniti si sentono “derubati” da Pechino. O meglio: dal suo sistema economico che in passato sfornava prodotti a basso costo ma che adesso produce oggetti di qualità. E che ha ormai messo in crisi il tessuto economico dell'Occidente capitalista, a partire dai profitti delle sue enormi multinazionali. Il re è nudo e si vergogna di mostrarsi senza corona, senza vestiti, senza scettro. Da qui la scelta statunitense di avviare un'escalation commerciale contro il Dragone nel tentativo (abbastanza velleitario) di stoppare lo sviluppo cinese e richiamare in patria le aziende ingannate dal miraggio della delocalizzazione. Già, perché la delocalizzazione in Cina avrà pure portato vantaggi immediati ai Cei - grazie in primis a una manodopera low cost - ma nel lungo periodo ha spolpato le società (e lo vediamo oggi) costringendole a condividere segreti industriali, know how, tecnologie con le rivali locali. Che ora dettano legge e dominano il mercato cinese e pure quello mondiale (che beffa!).

La guerra commerciale che Donald Trump ha scatenato contro la Cina di Xi Jinping è una risposta semplice a un problema complesso. Pensare di fermare l'avanzata geopolitica di Pechino con tariffe a tappeto sul Made in China esportato negli Usa serve a poco, oggi, in un mondo globalizzato. Intanto perché lo scheletro del sistema statunitense – la merce sugli scaffali di Walmart, tanto per fare un esempio – vive, prospera, campa del Made in China. E poi perché i cinesi non sono mica stupidi. Hanno iniziato da almeno un decennio a diversificare i loro rapporti economici con quanti più Paesi possibili, proprio per evitare di finire sotto ricatto da Washington. In più Pechino ha fatto un'altra cosa: ha scelto di camminare con le proprie gambe nei settori chiave dell'economia. Detto altrimenti, ha smesso di affidarsi alla tecnologia straniera per dare spazio alla propria. Il processo è stato lungo e ancora non è terminato ma intanto la Cina può sfoggiare i propri smartphone, le proprie auto elettriche, i propri computer, modelli di intelligenza artificiale, chip e via dicendo. Il modello cinese è però difficile da spiegare perché la “pelle” del Dragone cambia in continuazione adattandosi al contesto. Più che a un Dragone ha senso però paragonare la Cina a un'aragosta, come fa la sinologa Giada Messetti nel suo ultimo libro “La Cina è un'aragosta” (Mondadori). Cosa vuol dire? Come l'aragosta, che crescendo deve abbandonare il vecchio carapace e aspettare, vulnerabile, che se ne formi un altro, anche la Cina sta vivendo una fase di muta faticosa e complicata. D'accordo: l'hi-tech rappresenta una parte del successo cinese ma l'altra è piena di incognite dettate da numerosi cambiamenti che hanno toccato la quotidianità degli stessi cittadini: dall'atteggiamento dei giovani verso il futuro alla nuova consapevolezza delle donne riguardo la famiglia e il loro ruolo tradizionale, fino alla voglia degli anziani di godersi gli anni della pensione.
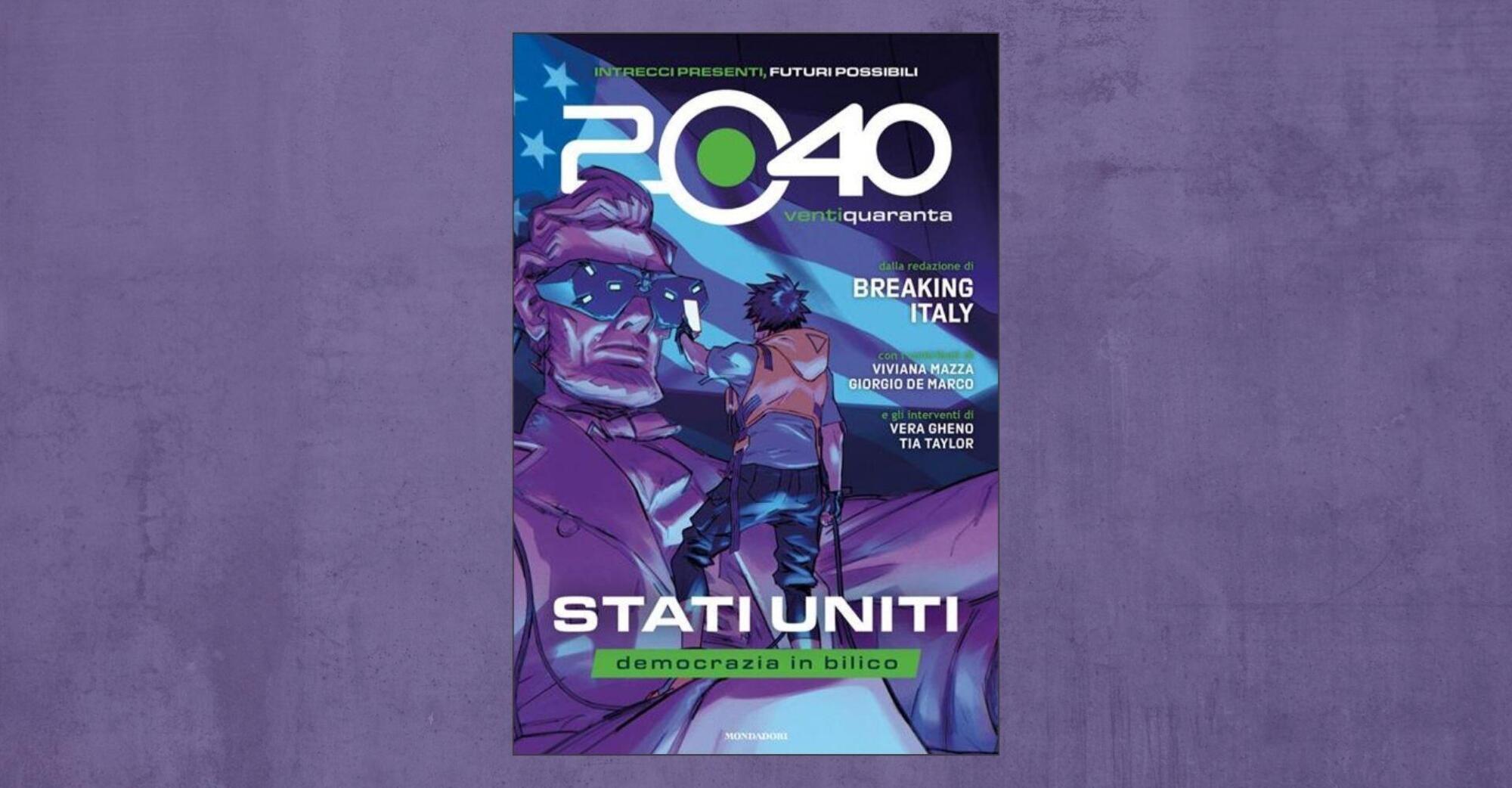
Se è vero che la Cina deve fare i conti con l'invecchiamento della sua popolazione, il rallentamento della crescita, la disoccupazione giovanile e la crisi immobiliare, questo resta comunque pur sempre un Paese in ascesa e in grado di ridefinire le dinamiche economiche e geopolitiche del mondo. Lo stesso vale per gli Stati Uniti? Per rispondere alla domanda si rimanda a “2040. Stati Uniti. Democrazia in bilico” (Mondadori), volume a cura della redazione di Breaking Italy. Al suo interno vengono sollevate diverse domande (come verrà affrontato lo scontro razziale? E il politically correct? E i rapporti con i Paesi arabi) e fornite risposte interessanti. Gli Usa, grazie a ingenti risorse di soft power, ai nostri occhi hanno a lungo simboleggiato il paradigma democratico che ha guidato il mondo moderno. Adesso qualcosa ha smesso di funzionare. Non solo all'esterno - dove non sono più Hollywood e McDonald's a fare proseliti tra i Paesi in via di sviluppo ma il modello cinese - ma anche e soprattutto all'interno, dove c'è una società sempre più lacerata e dove i meccanismi di controllo (e i famosi checks and balances democratici) danno la sensazione di essersi guastati. Trump, che sa bene che in questa fase storica il modus operandi cinese è in vantaggio, non può risolvere i problemi con i dazi. Potrebbe farlo, semmai, affrontando militarmente la Cina ma a costi pesantissimi. Attenzione bene: tra la penisola coreana e Taiwan gli epicentri dai quali potrebbero diffondersi i venti di guerra tra Usa e Cina non mancano...