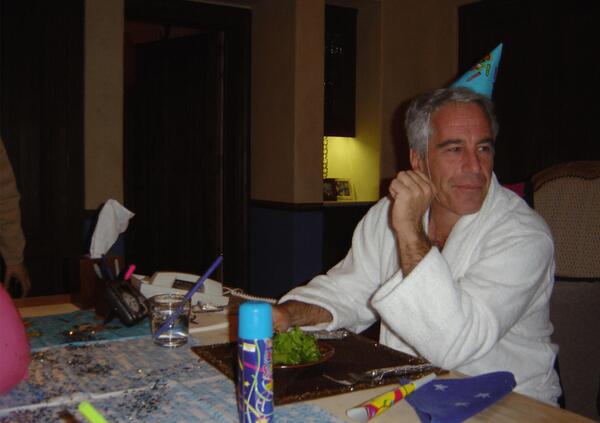La guerra è molto più complicata di come la raccontano i media. Certo, ci sono le strategie militari che tanto appassionano il pubblico; i nomi complicati delle armi, dei missili, dei caccia e dei carri armati utilizzati dagli eserciti sul campo; le sigle di gruppi e gruppuscoli di combattenti coinvolti negli scontri; i sistemi di alleanze utili per capire perché qualcuno vuole eliminare qualcun altro; i leader che dirigono le danze; le testimonianze di chi è sul campo; gli orrori, i feriti, le vittime, la devastazione. Ebbene, sappiate che questa è soltanto la punta dell'iceberg perché una parte altrettanto delicata delle guerre si combatte dietro le quinte. Dimenticate jet e tank perché qui c'entrano le parole, la comunicazione, l'immagine che un Paese in guerra riesce a trasmettere di sé, il taglio che assume la narrazione ufficiale degli eventi, il funzionamento delle camere d'eco della cultura, dei media e delle personalità pubbliche. Basta vedere cosa sta succedendo in Medio Oriente, dove Israele è impegnato su molteplici fronti in un'operazione sempre più delicata e i fatti sono vittima di almeno due propagande incrociate: quella israeliana e quella di Hamas. Il braccio di ferro sulle parole sta premiando il governo Netanyahu ancor più di quanto lo stiano facendo le Forze di difesa Israeliane.

L'esercito israeliano non si chiama, appunto, “esercito israeliano” ma “Forze di difesa israeliane”. Fin dalla sua nascita Israele si è percepito (e ha voluto essere percepito) come una nazione minacciata da nemici esterni. Il termine "difesa" ha quindi una forte valenza simbolica e politica: comunica l'idea che Israele non sia un aggressore, ma agisca solo per proteggersi. E rafforza la narrazione della sopravvivenza: uno Stato piccolo, circondato da minacce. È veramente così? Ognuno avrà il proprio pensiero in merito. Quello che ci interessa far notare qui è che la narrazione israeliana sul tema è quella adottata dall'opinione pubblica mondiale. E questo vale più di qualsiasi altro pensiero. Lo stesso vale per l'offensiva militare che Tel Aviv nella Striscia di Gaza in risposta al raid di Hamas del 7 ottobre 2023, oltre che per gli attacchi israeliani contro Libano, Siria, Iran, Yemen: sono stati attacchi, seppur strategici, ma sempre attacchi. Eppure pochi addetti ai lavori hanno fatto notare le criticità insite nel modus operandi israeliano, prendendo per buona la narrazione offerta da Tel Aviv. Soltanto da pochi mesi l'opinione pubblica globale ha messo in discussione la visuale israeliana, tanto sulle operazioni sul campo quanto sull'esito delle stesse. Per quale motivo? E, soprattutto, perché critiche del genere non sembrano minimamente impensierire Israele?

Qualsiasi altro Paese accusato – a torto o a ragione – di genocidio, attacchi indiscriminati contro i civili, massacri, carestie e chi più ne ha più ne metta, sarebbe stato probabilmente invaso da mezzo Occidente a guida statunitense in nome della salvaguardia dei valori democratici. In questo caso non succede niente di simile. Il governo Netanyahu ha infatti plasmato i gangli culturali dell'opinione pubblica globale con la propria (legittima) narrazione. In tutta risposta i media hanno passato gli ultimi anni a presentare al pubblico l'immagine di “Israele sotto assedio”, un'immagine ufficializzata dal mainstream che ha così giustificato qualsiasi reazione di Tel Aviv. I marxisti furono i primi a capire che per vincere una guerra era necessario prima di tutto dominare il consenso delle masse. Un consenso da ottenere influenzando la rete culturale e dei media, previa trasformazione dell'ideologia in narrazione. Se la propria parte diventa il “bene” e l'altra rispecchia il “male”, significa che la strategia ha avuto successo. E infatti, oggi, il governo israeliano ha ridotto il conflitto in Medio Oriente in una semplice scelta tra il “bene” e il “male”. Inutile far finta di niente: tralasciando idee morali e opinioni personali, il grande successo del “marxista” Netanyahu è stato proprio questo.