Chissà chi ha suggerito al Capo dello Stato Sergio Mattarella di venirsene fuori con il “diritto alla felicità” in occasione della festa della Repubblica. Scorrendo un’intervista a postenews (di questi tempi, una testata giornalistica non si nega a nessuno, neanche alle Poste) ci è caduto l’occhio su questo passaggio: “Il costituzionalismo ispirato dall'illuminismo inseriva nelle Carte il diritto alla ricerca della felicità. Il preambolo alla dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti reca questo inciso, peraltro suggerito da un grande pensatore italiano,Gaetano Filangieri. Da quel bellissimo richiamo - presente in qualche Costituzione ai giorni nostri - la nostra Carta indica il diritto al lavoro che, a ben vedere, è un altro modo di declinare la dignità umana, fatta di realizzazione personale e di strumenti di sostentamento, sulla strada della felicità”. Mattarella è di antica schiatta democristiana, nella Dc era di corrente morotea, cioè della sinistra interna (il non plus ultra della seriosità), non privo di una insospettabile vis polemica (una volta definì il filo-berlusconiano Rocco Buttiglione “el general golpista Roquito Butillone”), uno preciso che, al di là dell’obbligata retorica istituzionale, non è mai scivolato in eccessi pindarici, e inoltre è laureato e docente in giurisprudenza, avendo anche pubblicato vari testi di diritto costituzionale. Come ha potuto farsi così ingenuamente del male da solo, andando a riesumare il miraggio della felicità per tutti? Probabilmente, solo per variare sui soliti temi e dare un tocco di ottimismo, che tanto piace allo storytelling mediatico e ai titolisti dei giornali.

Il diritto alla felicità non c’è, nella nostra Costituzione. E pour cause. Per quanto sia vero che le Carte moderne sono figlie dell’Illuminismo, se i padri costituenti non ce l’hanno piazzato, un motivo ci sarà stato. E il motivo è culturale: negli Stati Uniti il diritto alla “ricerca della felicità”, che è cosa diversa, è stato poi tradotto dall’edonismo di massa in diritto alla felicità tout court, in modo del tutto fisiologico, perché derivava dal retroterra profondamente individualista del “nuovo mondo”, sorto su un impianto ideologico inglese (e cioè utilitarista, “la felicità per i più”, e protestante, “sono solo io responsabile della mia salvezza”). L’Italia repubblicana del ’48 metteva nella prima riga della propria legge fondamentale il lavoro, concepito come opera non solo individuale, ma sociale. Un diritto sì, ma anche un dovere per contribuire alla tenuta, allo sviluppo e alla prosperità della Nazione (articolo 4: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”). Va bene che siamo comunque nell’ambito di tutta “un’aspirazione poetica e sentimentale”, come liquidò Francesco Saverio Nitti l’insieme di immani aspirazioni contenute nella suprema Carta, però appaiare la felicità e il lavoro, come fa Mattarella, sotto il profilo rigorosamente storico-giuridico è mischiare le pere con le mele. Anche perché il lavoro può sì essere la via dell’autorealizzazione, ma non è detto che lo sia. Ci sono lavori infami, lavori subìti, lavori alienanti, e in ogni caso il lavoro è anzitutto “sudore della fronte”. È da sempre privilegio anti-democratico di una minoranza il godere dell’obbligo di sostentarsi.

Ma questo è anche il meno. Andando alla sostanza, non c’è forse trovata più infelice di elevare a diritto costituzionalmente prescritto la felicità, che è la più evanescente, soggettiva e indefinibile cosa che ci sia. Per gli americani non è così, dal momento che nella loro cultura essere felici è qualcosa di misurabile, di quantificabile, sostanzialmente corrispondente a quanto ognuno possiede, a quanti gradini nella scala riesce a salire, a quanto successo il singolo, l’everyman, ottiene inseguendo il mito fondativo, l’american way of life: la corsa all’oro. I giacobini francesi, statalisti ante-litteram, nel primo articolo della loro estremista Dichiarazione dei diritti del 1793 consideravano invece la felicità addirittura lo “scopo della società”. Ma la felicità “comune”, non individuale. In ogni caso, pretendere che sia un diritto, quindi da garantire a tutti, è un autogoal clamoroso: chi non la raggiunge, infatti, e a non raggiungerla per un’intera vita sono in parecchi, a quel punto cosa dovrebbe fare, sentirsi meno cittadino? Far causa allo Stato? Siamo alle iperboli, ovviamente. Negli Usa non succede nulla di tutto questo, anche perché questa somaraggine l’hanno, con residua prudenza, posta nel vestibolo della loro Dichiarazione d’indipendenza, e non direttamente in Costituzione. Ma resta un’americanata, ottimale per la pericolosa ingenuità di fondo che ispira gli yankee (e purtroppo anche noi, che degli yankee siamo le scimmie). Che cos’è la felicità? Forse è un attimo sempre fuggente, forse è il nome a buon mercato della gioia. Ma tutto è, fuorchè un Truman Show. Scrive il giornalista e scrittore francese Sylvain Tesson, nel suo splendido “Nelle foreste siberiane”: “L’essere felici è un intralcio alla serenità. Quando ero felice temevo il momento in cui non lo sarei stato più”.
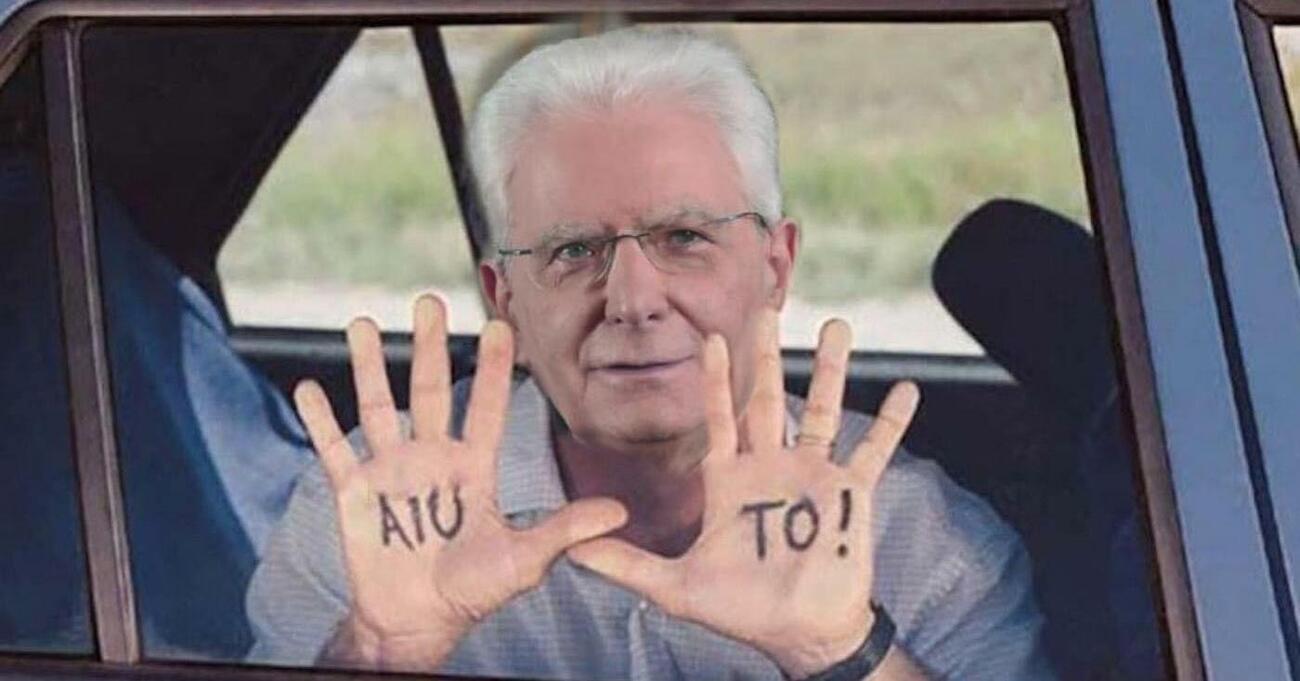








![Delitto di Garlasco: Bugalalla come Fabrizio Corona? Vogliono farle chiudere tutto! Ma spara altre intercettazioni di Ermanno Cappa, la moglie Maria Rosa e le gemelle Paola e Stefania [VIDEO]](https://crm-img.stcrm.it/images/49268027/HOR_STD/600x/photo-2025-01-22-23-44-12.jpg)



