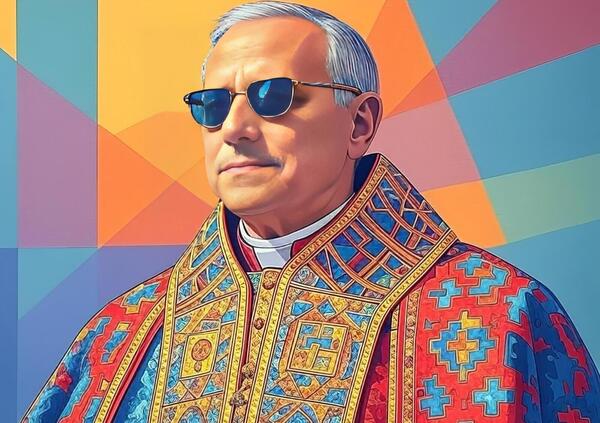Che cosa accomuna papa Leone XIV, Miss Universo e vostra figlia alla recita delle elementari? Che tutti parlano di pace nel mondo, con la più assoluta vaghezza. E cosa li differenzia? Che mentre vostra figlia è costretta a farlo (ed è anche l’unica a cui vengono fatte domande vere, nonché l’unica con un abbigliamento che non comporti un’immediata convocazione dal preside) e la Miss è presa per scema, il Papa viene chiamato “Sua Santità”, e per quelle parole – le stesse, le solite di tutti e di sempre – finisce sulle prime pagine di giornali e in apertura di tutti i telegiornali come se avesse svelato il trucco della moltiplicazione dei pani e dei pesci o della camminata sull’acqua. Ma il punto è questo: che un Papa dica “mai più la guerra” non è una notizia. È una frase da calendario motivazionale, da biscotto della fortuna, da cioccolatini di San Valentino (oltre che, appunto, da selezioni di concorso di bellezza e da saggio scolastico con i cartelloni arcobaleno).
Nel suo primo Regina Caeli da titolare dopo Francesco, Leone XIV ha chiesto che “si liberino gli ostaggi”, che “cessi il fuoco”. “Cessi”, come se il fuoco, commosso, potesse autolimitarsi per deferenza papale, come se bastasse un comando vocale con voce ferma come con Alexa. Come se la guerra potesse essere educata a parole, e la colpa, quella, evaporasse col fumo. Ha detto anche “si faccia il possibile”, senza indicare cosa sia “il possibile”, chi debba farlo, come e quando. Il Papa, come Miss Universo, pare si accontenti dell’impersonale. Non “Putin cessi”, non “Hamas liberi”, non “Netanyahu si fermi”, non “Zelensky negozi”. No: cessi il fuoco. Si faccia il possibile. Mai più guerra. L’armonia come wishful thinking globale.

Il problema non è che Prevost, come i suoi predecessori, parli di pace. Il problema è che non parli di niente che sia utile alla pace. La retorica dell’elevatezza, il registro della supplica spirituale, l'ermetismo da comunicato celeste. Tutto così liscio, così smussato, così educatamente ininfluente. Non si capisce se il nuovo Papa, che pure pare sincero e appassionato (per il poco che ne possiamo sapere), creda davvero che le guerre finiscano per compostezza morale, o se semplicemente sappia che dire certe cose (pur badando bene di non citare nessuno) gli garantisce una copertura mediatica più lusinghiera di Taylor Swift quando lancia un nuovo album.
Il guaio di questi discorsi, così generici da sembrare preghiere da frigo Onu, non è che siano sbagliati. È che non servono a nulla. Nessuno li ascolta davvero, tranne chi è già d’accordo, cioè non ha bisogno di convincersi. Non c’è un solo leader, tra quelli che le guerre le fanno o le armano o le finanziano, che si senta nemmeno sfiorato da un appello in cui non viene nominato.
Eppure: titoloni trionfali, servizi commossi. Ma dov’è la notizia? A meno che non si consideri clamorosa la riapertura dell’appartamento papale (gli affitti a Roma, si sa, non perdonano), tutto il resto era atteso, previsto, istituzionale, scontato, già sentito, già risentito, già derubricato, già infinite volte inefficace. Un Papa che dice “mai più guerra” è come il medico che suggerisce ai vecchi di evitare le ore più calde in estate. Lo sanno, e se non lo fanno, è inutile ripeterglielo. Non salva nessuno.
Ma la stampa lo riprende e lo rilancia, con reverenza quasi comica: “Il Papa ha detto”, “Il Papa ha chiesto”. Come se la guerra fosse un sottile turbamento che un’autorità morale può curare con lo sguardo, la parola, la benedizione. Ma se bastasse dire “cessi il fuoco” per ottenere un cessate il fuoco, saremmo già in pace mondiale da quando al posto dei droni da battaglia c’erano le alabarde. E invece no. Perché la guerra non si nutre di parole, ma di interessi. Il Papa sarebbe da prima pagina se dicesse chi sono i responsabili degli attacchi missilistici, delle invasioni, degli attentati. Se chiedesse a chi vende le armi di fermarsi. Se richiamasse il patriarca russo Kirill. Se denunciasse l’ipocrisia dei governi e dei politici. Se dicesse che la pace si ottiene col coraggio e se serve con la coercizione, non con le paroline e le liturgie. E invece eccoci, con il solito copione: il Papa auspica, i giornali incensano, le bombe cadono, i bambini muoiono.
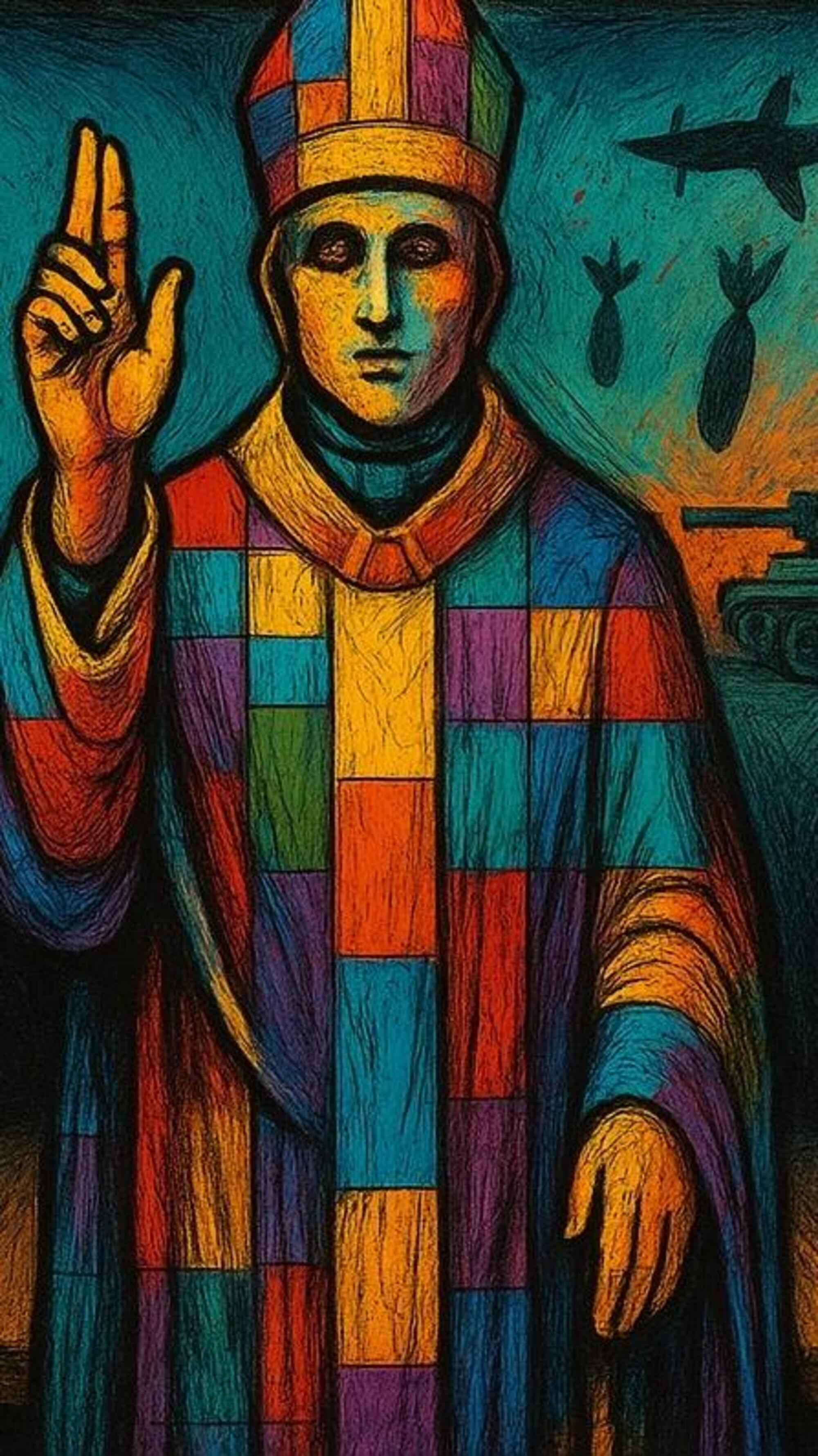
Possiamo capirlo, Prevost è nuovo, e magari ambisce a restare Papa (e vivo) più dei 33 giorni di Giovanni Paolo I. Forse in Vaticano esiste un protocollo che consiglia prudenza, equilibrio, omissioni strategiche. Ma viene da chiedersi se sentiremo mai un giorno un Papa che faccia nomi e cognomi, anche solo per sbaglio. Che non invochi, ma scomunichi (per quel che conta). Che non supplichi, ma denunci. Che non ripeta “pace giusta” come un salmo, ma che la declini nella realtà e spieghi come ottenerla. Ma non accadrà. Perché limitarsi a dire pace non costa nulla, non disturba nessuno. È una formuletta che si recita, si canta, si pubblica. Ma non la si mette pratica. E soprattutto, non la si impone.
E pensare che poi Leone XIV ha pure invitato i giornalisti a “cercare la verità con amore”, a “disarmare le parole”, a “essere operatori di pace”. Ora, chiunque abbia mai messo piede in una redazione sa che se chiedi a un cronista di essere operatore di qualcosa, quello ti risponde: “Quanto mi date?”. Ma da quando in qua il giornalismo è un monastero? Quando mai l'informazione ha cambiato qualcosa usando il tono giusto? Quando mai un regime si è ritirato perché un editoriale lo ha segnalato “con stile sobrio”? Il giornalismo serio la verità non la coccola: la trova tra le macerie, la stana nei bunker, la strappa a morsi ai silenzi. I giornalisti dovrebbero raccontare la realtà, e non sostituirla con una versione edulcorata dove la verità è solo quella che non turba nessuno. I giornalisti sono quelli che, quando fanno bene il loro lavoro, danno fastidio. E il problema è proprio questo: oggi non si vuole più che i giornalisti siano scomodi, ma che siano garbati. Si pretende che non disturbino il manovratore, sia esso Papa, capo di Stato o influencer. Leone XIV ringrazia la stampa per essere riuscita “a cogliere l’essenziale di ciò che siamo”, ma l’essenziale, se lo cogli bene, spesso non è pubblicabile senza una querela.
E poi che vuol dire “disarmare le parole”? E la verità? La si può amare la verità, certo. Ma solo dopo averla scovata sotto il fango, il sangue, la merda, le bugie, le omissioni e i comunicati stampa. E a volte, per amarla davvero, bisogna prima odiarla, perché è scomoda, perché puzza, perché fa male, perché rompe le amicizie e spezza le carriere. Il mestiere del giornalista, se preso sul serio, richiede ben altro: non amore ma ossessione, non pace ma sospetto, non carezze ma frustate verbali. Altro che "disarmare le parole": in un’epoca in cui quasi tutti i cronisti anziché essere cani da guardia del potere sono chihuahua da borsetta sdentati, azzoppati e con le corde vocali tagliate, l’urgenza non è certo disarmare, ma rianimare.
La “guerra delle parole” – che il Papa invita a sospendere – è l’unica guerra che i giornalisti dovrebbero ancora saper combattere. Non con l’odio, ma con la precisione. Non con l’ideologia, ma con l’insistenza. Con la fame. Di nomi, di prove, di fatti. E invece no: si chiede ai giornalisti di essere monaci tibetani col tesserino, di cercare “la verità con amore” come se stessero scrivendo dediche e bigliettini ai compagni di banco, e non denunciando crimini. Si chiede loro di “disarmare le parole” proprio mentre quelle dei potenti diventano sempre più armate, più chirurgiche, più tossiche. L’unica cosa davvero disarmante è questa retorica della pace e del volemose bene. Disarmante nel senso clinico del termine. Nel senso che fa cascare le braccia. E tutto il resto. Bombe, indisturbate, comprese. Ed è una retorica eterna, tanto quanto la guerra che finge di combattere.

Nel frattempo, ci sono più conflitti che fedeli in piazza San Pietro, i giornalisti veri marciscono in prigione, i giornalisti falsi applaudono e si fanno selfie col Papa e gli fanno firmare palle da baseball. Nessuno che gli chieda: “E come facciamo la pace, Santità? Chi dovrebbe fare cosa? In nome di chi e contro chi?” Nessuno si azzarda a domandare perché, se davvero vogliamo che finiscano le guerre, non iniziamo a fare la cosa più ovvia: dire i nomi di chi le guerre le vuole, le comande, le finanzia, le fa durare, le fa ricominciare. E l’unico fuoco che cessa è quello dell’indignazione. Ma in fondo, a ben vedere, la colpa non è del Papa. Lui fa il Papa. È il mondo che continua ad aspettarsi miracoli da chi non li promette neanche. Il Papa, come ogni figura simbolica e ogni autorità disinnescata, dice solo “mai più la guerra”, come la nonna che dice “non prendere freddo”, solo che la nonna almeno te lo dice guardandoti negli occhi, e se non ti copri almeno ha un mattarello da brandire per convincerti. Questa Chiesa, invece, si limita a distribuire ammonimenti al buio e carezze universali, pur essendo il Vaticano l’unico Stato al mondo che, se volesse, potrebbe permettersi di dire le cose come stanno e di fare qualcosa di concreto per cambiarle senza avere motivo di temere sanzioni o ritorsioni. Ma se non si fanno nomi, se non si portano avanti azioni, si fa solo scena. Perché in fondo tutti, anche i celibi per statuto, tengono famiglia. Ed è vero che a tutti importa della pace. Sì, ma della propria.