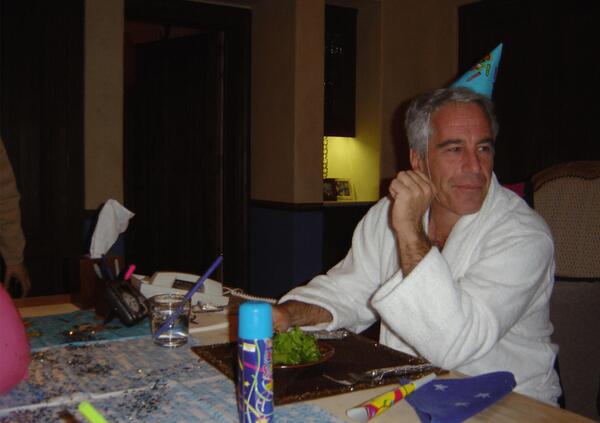Ci troviamo nel mezzo di una nuova strategia della tensione? Forse non è esattamente così, ma poco ci manca. Da quando le auto di Sigfrido Ranucci sono saltate in aria, il clima si è fatto molto pesante. Il caso Ranucci pare uno spartiacque, il preludio violento ad una nuova fase della nostra storia. Gli equilibri internazionali cambiano e con essi quelli criminali ed è in questi momenti che tornano a galla frammenti archiviati di delitti eccellenti mai risolti. Si veda il caso di Filippo Piritore, l’ex prefetto oggi accusato di depistaggio a proposito delle indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella. Nel contempo si torna a parlare di Berlusconi e Cosa Nostra, e di Giusva Fioravanti, che la moglie del “Moro siciliano” riconobbe quale esecutore dell’omicidio del marito. Settimana scorsa, poi, lo studio di produzione cinematografica 42esimo Parallelo è andato in fiamme pochi giorni prima della messa in onda del suo documentario diretto da Giorgia Furlan, “Magma” relativo al delitto Mattarella. Un incidente, certo, ma l’aria che si respira evoca il clima degli anni di piombo e della cosiddetta trattativa stato-mafia. Abbiamo allora chiamato Antonio Ingroia, ex magistrato, già sostituto procuratore della Repubblica a Palermo negli anni delle stragi e stretto collaboratore di Paolo Borsellino, nonché allievo di Giovanni Falcone. Ingroia, nella sua storia ha lavorato sulle pagine più oscure della storia italiana ed è stato uno dei protagonisti del processo sulla cosiddetta trattativa stato-mafia. Abbiamo domandato all’ex Pm come mai tutti questi piccoli frammenti di verità stiano emergendo tutti insieme proprio ora, e diciamo che il quadro presentatoci non è dei più rassicuranti.

Cosa ne pensa dell'accusa di depistaggio a Filippo Piritore nelle indagini sull'omicidio di Piersanti Mattarella?
Io devo avere fiducia nelle valutazioni che ha fatto l’autorità giudiziaria di Palermo. Da quello che leggo - chiaramente non conosco gli atti posso commentare solo ciò che emerge dalle notizie di stampa - mi sembra ci sia un comportamento, un atteggiamento processuale quantomeno ambiguo da parte del dottor Piritore. Si è contraddetto più volte, ed è stato poi contraddetto da altri testimoni e protagonisti della vicenda, quindi ha tutta l’aria di essere una cosa che ha un suo fondamento. Mi pongo una sola domanda, date la pesantezza delle accuse, delle risultanze e la giusta attenzione nei confronti di questo guanto dimenticato e poi scomparso. Nel 2025, quindi a quasi mezzo secolo di distanza dai fatti mi domando, perché nessuno, tra tutti i titolari delle indagini in tutto questo tempo, si è mai concentrato su questo elemento?
Se Piritore avesse davvero depistato, per ora non c’è ancora sentenza, a beneficio di chi avrebbe potuto farlo?
Non è facile rispondere a questa domanda. Però, sul piano razionale se dovessi fare un’ipotesi, tale rimane. In un primo momento il guanto potrebbe essere stato evidenziato, segnalato e annotato. Poi, se Piritore o altri hanno fatto sparire questo elemento, certamente non l’hanno fatto nel loro personale interesse, ma perché c’è stato qualche superiore che ha dato ordine in questo senso. Noi abbiamo una sequenza di sparizioni di elementi fondamentali in tanti delitti eccellenti, quasi infinita nella storia palermitana, dagli anni ’60-’70 in poi, dalla sparizione dal cassetto del giornale “L’Ora” di Mauro De Mauro degli articoli che aveva scritto, a Lea Garofalo, saltando in avanti all’agenda rossa di Paolo Borsellino, tornando indietro alla cassaforte nella prefettura di Palermo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e tornando di nuovo in avanti all’agenda elettronica semi cancellata di Giovanni Falcone. Purtroppo c’è sempre una manina che interviene al momento giusto, e quella “manina” interviene perché dietro di essa c’è qualche “manona” che dà questi ordini e queste disposizioni. Perché si tratta sempre di delitti in cui non c’entra solo la mafia, perché politicamente sensibili. Ci sono interessi che vanno ben al di là della mafia, a coprire le responsabilità e spesso le collusioni con la mafia.
A Piritore non è contestato l’aggravante di mafia proprio perché i Pm non hanno scartato la pista nera, tra l’altro…
Sicuramente la pista nera è valida. Secondo Falcone pareva ci fosse una convergenza di interessi a proposito. Siamo nel 1980, ci sarà qualche mese dopo la strage di Bologna, è un momento in cui organizzazioni criminali di natura diversa si trovano ad avere interessi in comune. Quindi, mentre viene decapitata una certa classe dirigente in Sicilia - un certo tipo, però, di classe dirigente - nel resto d’Italia si semina il terrore, si pongono in atto atti eversivi che hanno ovviamente la finalità di arrestare quello che tra gli anni ’70 e gli anni ’80, e poi in avanti, era un processo di rinnovamento politico e sociale del Paese.

Dopo la morte di Borsellino in via d’Amelio l’allora Comitato antimafia del Csm, oltre a Scarpinato, ascoltò anche lei insieme con Vittorio Teresi e Ignazio De Francisci. Avevate presentato polemicamente le dimissioni per la mancanza di sicurezza e per la gestione della Procura di Palermo da parte di Pietro Giammanco. I verbali furono secretati. In occasione del 25esimo anniversario dall’attentato il Csm ha desecretato tutti gli atti che riguardavano i due magistrati uccisi tranne i vostri verbali. Perché?
Bisognerebbe chiedere, diciamo, agli uomini del Consiglio Superiore della Magistratura, che hanno cercato di tenere nascosta la polvere sotto il tappeto. Io, per la verità, poi, questa cosa l’ho scoperta in anni più recenti. È un’operazione di disinformazione, di dissimulazione delle verità più scomode, che è andata avanti per decenni e che va avanti tutt'ora nel nostro Paese. Si tengono nascoste le opacità interne dello Stato, delle istituzioni giudiziarie, politiche, negli apparati investigativi spesso complici dell’organizzazione criminale. Bisogna portare avanti una rappresentazione della realtà, come dire, addomesticata, addolcita. E’ il racconto in cui si scontra l’esercito dei buoni con quello dei cattivi, dove i cattivi sono i mafiosi - brutti, sporchi, cattivi e sanguinari - Totò Riina capro espiatorio per tutti, e dall’altra parte uno Stato, l’esercito dei buoni, tutti uguali e tutti dalla stessa parte. Senza voler fare sconti naturalmente in alcun modo ai mafiosi, la realtà è ben diversa. La mafia non sarebbe mai diventata così potente se non avesse avuto sostegno e supporto interni allo Stato.
Ma senta, secondo lei, perché proprio ora torna a emergere la questione del guanto?
Va dato merito senza troppe dietrologie, all’indagine della Procura di Palermo. Hanno riaperto l’indagine, e riaprendola l’hanno rivisitata nel suo complesso e si sono imbattuti in questo particolare stranamente sfuggito prima.
Sì, tra l’altro, a proposito dell’omicidio Mattarella, è stato realizzato un documentario molto interessante, “Magma”, diretto da Giorgia Furlan. E’ stato trasmesso domenica sera su La7, e tre giorni prima della messa in onda, lo studio che lo ha prodotto, 42esimo parallelo, ha preso fuoco. Naturalmente non si sa perché, però è un tempismo particolare…
Questo non lo sapevo. È uno dei tanti misteri. Stiamo attraversando una fase molto delicata, credo. Al di là delle polemiche politiche attorno all’attentato. più o meno dimostrativo, nei confronti di Sigfrido Ranucci, il fatto che si torni a usare l’esplosivo anche a fini meramente intimidatori è il segnale che nel Paese stiamo tornando a vivere un clima pesante, che ci impone di alzare la guardia.
Dopo le bombe alle auto di Ranucci, insomma, anche sui giornali iniziano a uscire notizie un po’ particolari, ad esempio su Domani la lettera anonima sulla pista albanese, e poi ad orologeria la sentenza su Berlusconi e la mafia…
Non c’è dubbio. La verità è che da almeno un decennio sembra che ci sia più inquietudine attorno alla questione della trattativa Stato-mafia, con una paura inedita, che la verità venga a galla. Se ne facciano una ragione i disinformatori di professione, che naturalmente sono tornati pienamente in campo, con la falsità gridata per di più senza tema di essere facilmente smentiti. Questi dicono che è tutta una fake-news, quella dei collegamenti lungo l’asse Cosa Nostra-Dell’Utri-Berlusconi. Con buona pace dei falsificatori di professione, invece, è una realtà consacrata, definitiva, con sentenze definitive, e sono quelle che hanno condannato Dell’Utri come tramite di questi rapporti. Dopodiché, la Procura di Palermo su quella specifica vicenda, probabilmente - mi assumo la responsabilità delle mie affermazioni nei confronti del mio ex ufficio - forse ha sbagliato andando per semplificazioni, quindi giungendo a una proposta di misura di prevenzione nei confronti di Dell’Utri forse non adeguatamente supportata. Ma questo non significa che si possa mai rimettere in discussione ciò che è consacrato in sentenza, ovvero che Dell’Utri era un uomo di Cosa Nostra, che era stato mandato alla corte di Berlusconi proponendogli una sorta di patto di protezione, perché Berlusconi era intimorito e intimidito dalle minacce di Cosa Nostra - c’erano stati progetti di sequestro anche nei confronti dei suoi familiari - e come accadde nella prima metà degli anni ’70-’80, scese a patti, di fatto, con Cosa Nostra, accettando la sua protezione mediante Dell’Utri e Vittorio Mangano. E quello è il motivo per il quale lo definii - ero io il Pm nel processo Dell’Utri - Berlusconi come “vittima compiacente”. Vittima di Cosa Nostra, perché vittima delle sue pressioni, che però scelse il compromesso con i mafiosi stessi. Accordo che poi si è riproposto negli anni ’90, dopo l’attentato a Santa Tecla di Catania, quando Dell’Utri venne mandato da Berlusconi per trattare con Cosa Nostra e raggiungere un nuovo accordo pacificatorio, che portò Berlusconi a rimpinguare le casse di Cosa Nostra con quello che - in una sentenza definitiva ormai intangibile, consacrata dalla Cassazione - viene definito il prezzo di un’estorsione continuativa e ripetuta che Berlusconi subì. Poi c’erano le accuse di alcuni collaboratori secondo le quali quelle somme che Berlusconi versava a Cosa Nostra non erano frutto di estorsione, ma erano in realtà il continuativo rimborso di un debito che Berlusconi aveva assunto alle origini del suo patrimonio, di versamenti che da Cosa Nostra erano arrivati a Berlusconi. È una cosa su cui io ho indagato, su cui hanno indagato altri magistrati, e fino ad oggi si è rivelata infondata o comunque non adeguatamente provata. Ma ciò non toglie che sia provata l’esistenza di quei rapporti, nei quali Dell’Utri venne condannato perché aveva aiutato Cosa Nostra a rimpinguare le proprie casse grazie a questo patto di protezione stipulato con Berlusconi. Questa è una verità che non si può cancellare, e non si dovrebbe cercare neppure di cancellare per rispetto alla verità e alle sentenze definitive.
Giusva Fioravanti è un nome che sta tornando a circolare nei giornali come collegamento tra i vari delitti eccellenti di cui abbiamo parlato. E la moglie di Piersanti Mattarella ha sempre sostenuto che il killer di suo marito fosse Giusva Fioravanti. Lei che ne pensa? Perché proprio adesso?
Non ho indagato a sufficienza per farmene un’idea personale e diretta, diciamo, ma ho indagato sui singoli fatti di reato collegati, e credo che la trama sia comunque unica e unitaria. È una trama che si sviluppa in quegli anni con un obiettivo ben preciso, rimettere in equilibrio il sistema politico-istituzionali che aveva garantito sino a quel momento l’esistenza di Cosa nostra. Il parallelismo in particolare tra la fine di Moro e la fine di Mattarella non è una semplificazione, ma anzi, l’omicidio di Mattarella è forse la versione siciliana del tentativo di Moro di aprire il governo del Paese a un pezzo d’Italia che era stato tenuto ai margini fino a quel momento. Due vittime apparentemente di mani diverse, ma che si iscrivono all’interno della medesima strategia. Ed è quella che poi, dieci anni dopo, negli anni ’90, è di nuovo riesplosa e ristrutturata in modo diverso, con un epilogo che è stato l’abbattimento della Prima Repubblica e la costruzione della cosiddetta Seconda Repubblica.