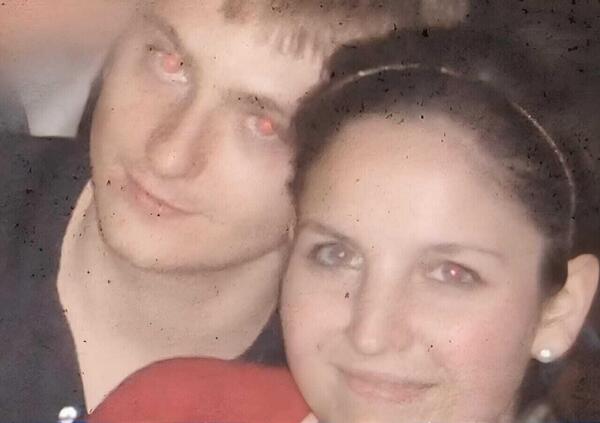Alessandro Barbero non era fisicamente presente, ma umanamente (e in video) sì, nella piazza del 5 aprile a Roma, piazza pacifista, contiana, ritadecrescenziana. Un breve intervento, ovviamente, a partire dalla sua materia: “A noi storici spesso chiedono ma l'epoca nostra che stiamo vivendo, a quale periodo del passato assomiglia? Proprio negli ultimi tempi comincio ad avere sempre più l'impressione che l'epoca nostra assomigli paurosamente agli anni che hanno preceduto lo scoppio della Prima guerra mondiale nel 1914”. Come già avrete intuito, del Medioevo, area in cui Barbero è specializzato, i pacifisti hanno preso soprattutto l’appello all’autorità (il prof Barbero!). Molto meno interessati agli argomenti e molto più a chi si schiera con loro, non si sono accorti, però, di alcuni errori nel discorso dello storico, errori invece individuati, tra gli altri, dal giornalista del Corriere della Sera Antonio Carioti e dall’esperto Andrea Gilli, senior researcher in Military Affairs al Nato Defense College di Rome.
Ma prima l’intervento di Barbero: “Nel 1914, l'Europa usciva da un lungo periodo di pace, se uno non guarda le guerre nei Balcani e le guerre coloniali in cui tutti i paesi europei si erano imbarcati. E anche adesso usciamo da un lungo periodo di pace, se dimentichiamo i Balcani, tuttavia i grandi paesi dell'Occidente non si sono più fatti la guerra per anni”. Barbero punta anche su un parallelismo riguardo al riarmo: prima della Prima guerra mondiale, “tutte le potenze, Italia compresa, aumentarono le spese militari del 50% in pochi anni nell'illusione di essere più sicuri”. Il problema di questi parallelismi, chiaramente, è la suggestione. La gente non sente “1914” ma “guerra mondiale, distruzione e morte imminente”. E su questo che si ferma la prima obiezione di Gilli: “C'era cambiamento tecnologico, globalizzazione, e fermento sociale, come oggi. Ma c'erano anche enormi differenze: la popolazione stava per iniziare una poderosa crescita mentre oggi è in fase discendente, l'aspettativa di vita di allora era l'età media di oggi, non c'era democrazia, stato sociale, e la conservazione e il trasporto del cibo erano ancora estremamente ridotti. Poi in quell'epoca l'Impero Britannico era in declino mentre stavano emergendo potenze emergenti: Usa, Giappone, Italia, Germania e Russia. Oggi gli Stati Uniti osservano al massimo un declino relativo, ma tecnologicamente e industrialmente rimangono il Paese leader al mondo, mentre l'ascesa della Cina crea al massimo un sistema bipolare, non multipolare”.

C’è poi della questione riarmo uguale guerra, ovvero: se ti armi tirerai il tuo Paese e i tuoi alleati in una guerra. Gilli risponde così: “Il problema è che Barbero dovrebbe citare le fonti e spiegare che c'è anche il rischio alternativo, ovvero che non correndo in soccorso dei propri alleati, questi vengano attaccati: ecco perché si creavano alleanze più rigide. E se non si corre in soccorso dei propri alleati, cosa succede? Che la sicurezza collettiva viene meno, dato che Barbero si guarda bene dal menzionare. In altre parole, per lanciare un attacco alla NATO, senza citarla, Barbero taglia e cuce un ragionamento parziale che al giorno d'oggi non mi pare si applichi: salvo a Il Fatto Quotidiano, nessuno crede che ci sia il rischio di essere tirati dentro una guerra mondiale dagli Estoni o dai polacchi. D'altronde, la letteratura sulle alleanze nota come il primo rischio sia più elevato in ere multipolari (inizio '900) mentre il rischio di abbandono è più alto in ere bipolari (l'epoca recente)”. Full stop.
Che dire invece degli interessi dei poteri forti e della lobby delle armi che da decenni avremmo foraggiato giocando sulla pelle dei cittadini? “Barbero aggiunge che la nostra epoca sarebbe simile a quella che precede la Prima Guerra Mondiale per via della crescita della spesa militare. Problema: non è vero. Nel corso degli ultimi 3 decenni, l'Europa ha speso sempre meno e sempre peggio in difesa. Ecco perché i Paesi Europei non sarebbero in grado di mandare più di 30-60.000 soldati in Ucraina al giorno d'oggi, mentre mandarono milioni di persone al fronte dal 1914”. Lasciamo agli appassionati l’ultimo punto sul dilemma della sicurezza e l’esempio della Germania e della Gran Bretagna (lo trovate nel posto di Gilli pubblicato su Facebook).