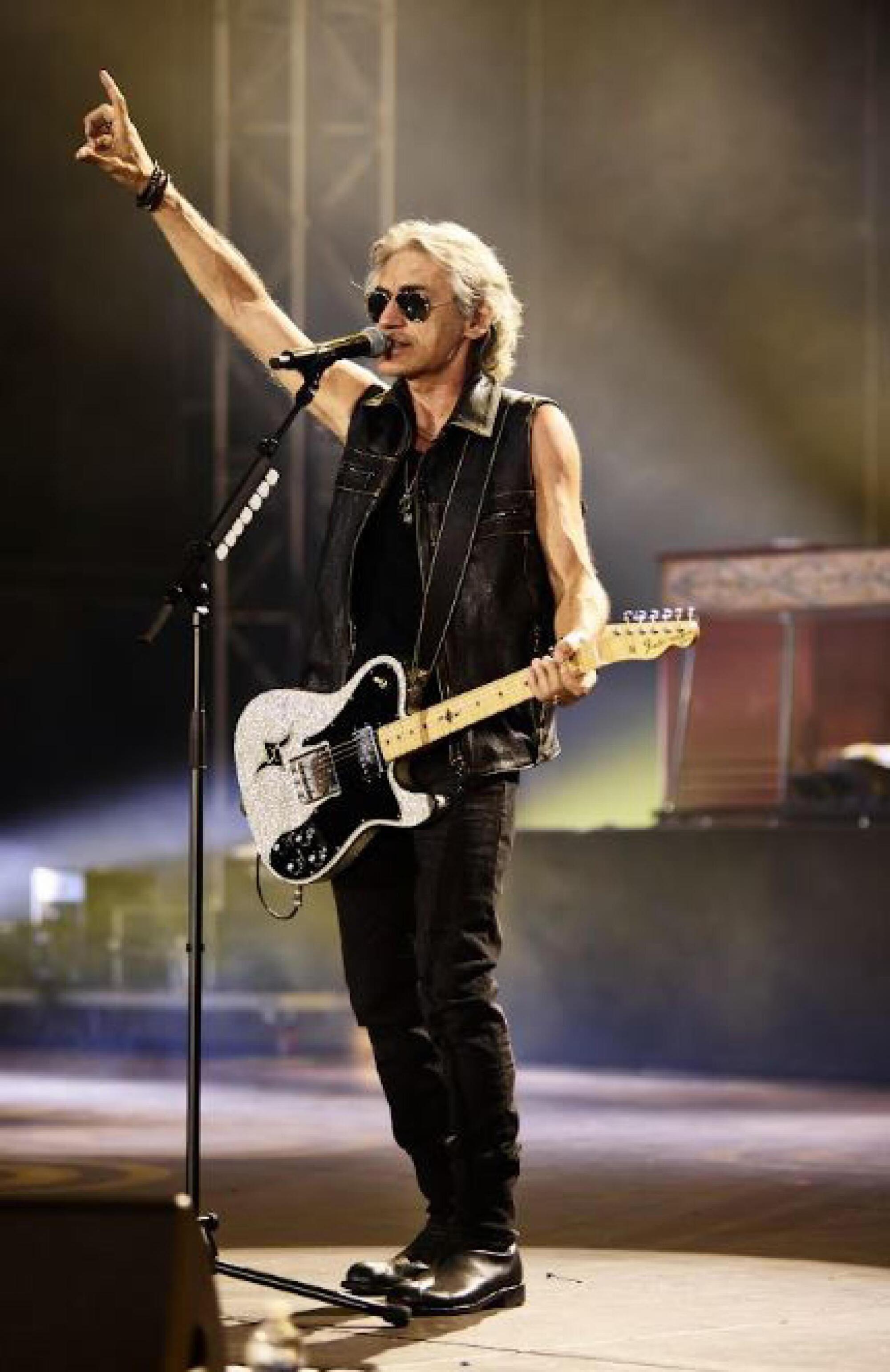Tutti gli artisti nascono dipendenti, ma muoiono convinti di essere liberi
È la parabola più vecchia e più triste delle arti: l’attore che si crede regista, l’interprete che si crede cantautore, il content creator che si crede attore e impresario. Appena arrivano gli applausi, scompare la memoria. L’ego sale sul palco al posto loro, e inizia la recita più ipocrita di tutte: quella dell’autosufficienza.
L’ego come malattia professionale
Nessuno nasce artista da solo. Dietro ogni voce, ogni scena, ogni successo ci sono mani invisibili che organizzano, coordinano, difendono e curano interessi. Ma nel momento in cui la luce dei riflettori diventa calda, molti cominciano a credere che quella luce provenga da loro stessi. È il momento in cui un talento si ammala.
La frase più pericolosa?
“Tanto sarebbe accaduto lo stesso.” No. Non sarebbe accaduto. Non esistono carriere spontanee, solo lavori ben fatti che qualcuno, avendone visione, ha costruito nell’ombra. E chi cancella la professionalità altrui per riscrivere la propria leggenda non è un genio: è un ingrato con buona memoria selettiva.

Dal filtro al palcoscenico
Negli ultimi anni il mondo dell’arte ha assistito a una mutazione genetica: il passaggio da TiKTok a Sanremo, la migrazione dai social ai teatri, dal contenuto istintivo al contenitore organizzato, dal video di pochi secondi alla tournée nazionale. È l’epoca in cui si diventa “artisti” rendendo spettacolari materie scolastiche o di episodi quotidiani, senza nulla di davvero originale, se non l’intuizione — quella sì geniale — di un manager che riesce a trasformare il nulla in spettacolo. Temi comuni, linguaggi elementari, osservazioni che chiunque potrebbe fare: ma con la giusta regia, la giusta promozione e il giusto investimento, diventano improvvisamente “fenomeno”. Eppure, dietro quella metamorfosi c’è un lavoro preciso, silenzioso, professionale. Qualcuno che studia, struttura, impone prove, scrive copioni, crea un percorso. Senza quella regia invisibile, il fenomeno rimarrebbe dov’è nato: nel feed di un telefono. Ma poi, puntualmente, arriva il momento in cui il performer si guarda allo specchio e pensa: “Ce l’ho fatta da solo.” E subito dopo pronuncia la frase più vile e autoassolutoria di tutte: “Tanto sarebbe accaduto lo stesso.” Eppure, quante volte quella stessa persona aveva paura di non essere in grado, di non voler salire sul palco, di temere il pubblico vero — quello presente in sala —quando non era più nascosto dietro lo schermo di uno smartphone o di un computer? Quante volte quell’insicurezza è diventata, di colpo, mania di protagonismo assoluto? E quante volte, solo dopo, ha scoperto che chi lo aveva preso per mano e portato fin lassù aveva avuto semplicemente ragione? No. Non sarebbe accaduto da solo. Perché i miracoli artistici non accadono da soli: si costruiscono. E chi cancella la professionalità altrui per riscrivere la propria leggenda non è un artista emancipato: è solo un ingrato nemmeno ben vestito.
L’offesa della superficialità
Il disprezzo verso la professionalità altrui è la forma più meschina di arroganza artistica. È l’idea che il successo sia un dono, non il frutto di competenze, reti, sacrifici condivisi. Ogni volta che un artista sminuisce il lavoro del suo team — manager, fonici, tecnici, ufficio stampa, produzione — l’arte intera perde credibilità. Dietro ogni data c’è un contratto, dietro ogni applauso c’è un accordo, dietro ogni immagine “spontanea” c’è qualcuno che ha previsto ogni dettaglio. Credere di poter fare tutto da soli è come pensare di poter suonare un’orchestra con una sola mano. Ma c’è un punto che pochi comprendono davvero: chi gestisce un artista investe, rischia, anticipa, e spesso garantisce un compenso all’artista a prescindere dai propri incassi real. Il management è l’unica parte che, in ogni progetto, non ha un salario certo ma un rischio costante. È colui che deve far quadrare conti, contratti, cachet, logistica e comunicazione — mentre l’artista riceve, puntualmente, il suo compenso, anche quando il bilancio va in perdita. Eppure, paradossalmente, è proprio il management a essere accusato di “guadagnare sulle spalle” di chi in realtà protegge. Il “tanto sarebbe accaduto lo stesso” è l’insulto più vile che un artista possa rivolgere a chi lo ha aiutato a diventare tale. È il modo in cui l’ego giustifica l’ingratitudine.
Quando il vento gira
Il performer, una volta stabilizzato il successo, smette di ascoltare chi lo ha costruito e comincia a credersi indistruttibile. Ma l’arte non è una vetta: è un equilibrio. E quando l’equilibrio si rompe, l’artista si trasforma in una bandiera esposta ai venti — venti che soffiano in direzioni sempre diverse, senza logica né progettualità. Un giorno verso l’ego, un giorno verso l’adulazione, un giorno verso il silenzio. Non segue più un percorso, ma le correnti del momento. E il vento, si sa, non costruisce mai nulla: sposta, consuma, disperde. Le carriere costruite sull’orgoglio si sbriciolano appena cambia l’algoritmo, appena il pubblico si stanca, appena la macchina si ferma. Il successo è fragile: senza gestione, diventa evaporazione. E quando poi — cosa che ha dell’assurdo — ti convinci che tutte le tue date debbano essere sold-out, diventi incosciente di offendere anche quei pochi spettatori che sono lì per te, a prescindere dal numero che li rappresenta. La tua mente, offuscata dalla brama di successo, ti fa perdere il senso stesso del pubblico, che va curato a prescindere dalla quantità. Perché la semina, se fatta bene, produce sempre un futuro raccolto. E forse la più grande trappola dell’artista moderno è il continuo guardare agli altri, senza capire che esistono differenze, compromessi, opportunità, e soprattutto empatie e capacità differenti. Il paragone è la forma più lenta di autodistruzione: ti fa inseguire carriere che non ti appartengono, ti spinge a desiderzre vite che non sapresti sostenere, e ti allontana dall’unica cosa che conta davvero: il tuo percorso. Molti artisti oggi, soprattutto nel mondo del web e del teatro popolare, hanno confuso la libertà con l’abbandono. Ma un artista libero non è quello che si stacca da chi lo ha aiutato, è quello che sa restare se stesso nonostante chi lo ha aiutato.

Il tempo e la visione
C’è un’altra verità che pochi vogliono accettare: il tempo passa. E qualcuno, nel team, deve avere la visione di ciò che sarà — soprattutto per chi ha iniziato tardi la propria carriera. Perché ogni progetto artistico ha una curva, e senza pianificazione si trasforma in parabola discendente. L’arte non può vivere di improvvisazione. Serve chi sappia vedere oltre l’istante, chi comprenda il mercato, la maturità del pubblico, la realtà anagrafica. Come ricordava Julia Roberts, che rifiutò una parte offertale da Mel Gibson perché la giudicava “vecchia” per il ruolo: il tempo cambia tutto — anche gli occhi di chi ti guarda. E quanti comici italiani, arrivati a una certa età, sono scomparsi senza un perché? Risparmiamo i nomi: basta guardarci intorno. La differenza, come sempre, è nella visione. Ci sono fenomeni irripetibili come Lino Banfi, Renato Pozzetto e pochi altri, appartenenti a un’epoca diversa, forgiati da anni di sacrifici e palchi veri. Hanno resistito perché hanno cominciato presto e non hanno mai smesso di costruire. E nella musica, la domanda resta la stessa: “Perché artisti come Vasco, Ligabue, Zucchero non hanno mai cambiato manager?” La risposta è semplice: perché hanno capito che la fedeltà alla visione vale più di mille reinvenzioni improvvisate.
La verità semplice
Dietro ogni carriera vera c’è un architetto invisibile. Chi non lo riconosce, non ha rispetto né per l’arte né per se stesso. Perché la professionalità non è una gabbia: è la differenza tra un talento e un capriccio. E se un giorno, davanti allo specchio, vi verrà da dire “tanto sarebbe accaduto lo stesso”, fermatevi un secondo a pensare. Senza qualcuno che vi ha creduto prima di voi, non sarebbe accaduto proprio niente. Nella vita, devi decidere se vuoi fare l’artista o l’imprenditore di te stesso. Perché l’irrazionalità artistica non può vivere nello stesso corpo della razionalità imprenditoriale. E chi prova a essere entrambe le cose, finisce spesso per perdere entrambe.
Il genio libero non esiste. Esiste solo l’artista che sa di non bastarsi.