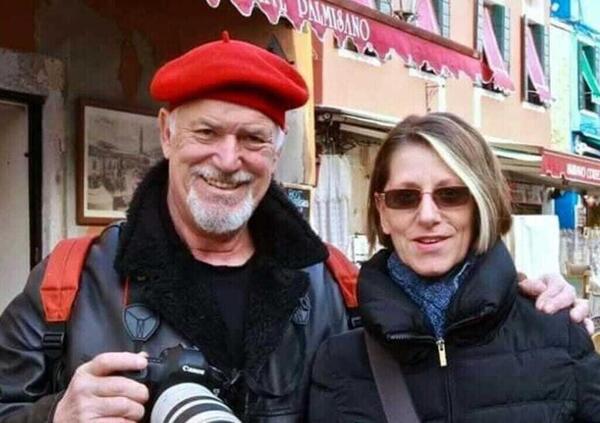Tra le innumerevoli cospirazioni che stanno caratterizzando la morte di Papa Francesco, quella più accreditata è la possibilità che sia stato davvero un Papa illegittimo: un Antipapa. Nel febbraio 2013, la Chiesa cattolica ha vissuto uno dei momenti più straordinari della sua storia recente, assistendo alla “rinuncia” di Papa Benedetto XVI, al secolo Joseph Ratzinger. Una scelta che ha letteralmente spiazzato i fedeli, forse un po' meno il Clero: ma che certamente ha alimentato negli anni numerose discussioni ed indagini. Ancora in tanti si chiedono cosa sia successo davvero. È stata un’autentica abdicazione quella di Papa Benedetto XVI? E se non fosse andata così? Papa Francesco potrebbe essere davvero un Papa illegittimo? Per capire tutto questo, dobbiamo partire da un concetto fondamentale del diritto canonico: la distinzione tra munus e ministerium. Il munus è il "dono", ovvero l’ufficio spirituale del papato, la carica stessa che proviene da Dio e dalla quale non esisterebbero dimissioni. Il ministerium, invece, è l’esercizio pratico di quel ruolo: governare, parlare, agire. Nel suo discorso di rinuncia, Benedetto non usa la parola "munus" ma solo "ministerium". Questo ha portato alcuni interpreti, anche specialisti di diritto canonico, a sostenere che Ratzinger abbia volutamente rinunciato solo all'esercizio pratico del papato, ma non alla carica in sé. Un modo elegante e giuridicamente legittimo per denunciare i numerosi tentativi interni di mobbing. Secondo questa lettura, Benedetto sarebbe rimasto Papa "in sede impedita", cioè impossibilitato a esercitare pubblicamente il suo ruolo ma ancora in possesso dell'autorità spirituale. In questo scenario, l'elezione di Jorge Mario Bergoglio sarebbe invalida, perché non si può eleggere un nuovo papa se il precedente non sia morto o abbia realmente abdicato.

Va anche ricordato che Benedetto XVI veniva considerato l’erede naturale di Giovanni Paolo II. Durante il suo pontificato, esattamente nel 1981, Wojtyla lo nominò Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, l'organo della Santa Sede che si occupa di vigilare sulla correttezza della dottrina cattolica. Ratzinger avrebbe certamente proseguito sul cammino del suo predecessore, Giovanni Paolo II, che, sebbene abbia avuto un importante ruolo politico, aveva rispettato e portato a termine la sua missione di Papa: cioè quella di guidare e proteggere la Chiesa spiritualmente. Jorge Mario Bergoglio era un personaggio ambiguo già nella sua traiettoria pre-papale, quando vescovo di Buenos Aires fu al centro di numerose controversie per i suoi rapporti ambigui con il regime e per il suo silenzio o la sua presunta passività riguardo ai “desaparecidos”, tra cui anche membri del clero. Il conclave post-Wojtyla fu caratterizzato dai due unici contendenti: Ratzinger e Bergoglio. Sebbene il primo avesse più consensi in termini di voti, fu così che la cosiddetta "Mafia San Gallo", di estrazione socialista/globalista e favorevole a Bergoglio, non potendo sconfiggere Ratzinger nei termini elettorali, decise di eleggerlo per poi “mobbizzarlo”, annientarlo e metterlo all’angolo, impedendogli di guidare la Chiesa come avrebbe voluto. Le “dimissioni” – o, per meglio intenderci, la denuncia – di Benedetto XVI arrivano dopo un episodio sconcertante: durante il viaggio a Cuba il pontefice subì una sorta di intossicazione da barbiturici. Ai sonniferi che utilizzava quotidianamente venne aggiunta una dose massiccia. L’episodio venne interpretato dai suoi segretari come un possibile tentativo di eliminazione.

Tuttavia, la posizione ufficiale della Chiesa sembra chiara: la rinuncia di Papa Benedetto XVI è valida. Il Codice di Diritto Canonico, al canone 332 §2, stabilisce che per la validità della rinuncia non è richiesta una forma specifica, ma che sia libera e manifestata chiaramente. Secondo molti canonisti e il Vaticano, la dichiarazione di Benedetto risponderebbe a questi requisiti. Così Benedetto lascia il ministerium per l’hora vigesima del 28 febbraio 2013, che corrisponde alle ore 13 del 1° marzo 2013, momento in cui viene convocato il Conclave, ritenuto da alcuni illegittimo. All’interno del Vaticano qualcuno parla di un’entità che sarebbe stata arbitro fin dal primo momento di questo antipapato: colui che ha regolamentato e stabilito cosa Bergoglio potesse “avere” e cosa no. No all’appartamento apostolico, no alla mozzetta rossa, niente scarpe rosse, niente stemma sulla fascia, niente "P.P." dopo la firma, niente numerale dopo il nome, niente stipendio. Via via, nel tempo, gli è stato tolto il titolo di Vicario di Cristo, poi quello di Primate d’Italia, e nel 2022 pare gli sia stato tolto anche il diritto di celebrare messa. Bergoglio non celebrava messa da tre anni. Anche l’anello piscatorio gli è stato sottratto, così come i sette candelabri sull’altare, prerogativa del Papa; da ultimo, gli è stata tolta anche la fascia alla vita, simbolo del suo grado e del suo ministero.
E Benedetto XVI? Nonostante ci sia chi sostiene che abbia riconosciuto in Francesco il suo successore, in fondo ha sempre parlato dell’esistenza di un Papa, ma senza specificare chi fosse. Ha scelto di continuare a indossare la talare bianca, firmarsi ancora "Papa emerito" e vivere in Vaticano, creando ambiguità simboliche e lasciando spazio a interpretazioni alternative, soprattutto tra i più tradizionalisti. Ma in questi lunghi 12 anni Bergoglio ha nominato oltre 100 cardinali. Stando a questa teoria della “sede impedita”, se questi prelati saranno chiamati a votare, avremo un altro antipapa… In definitiva, la teoria dell'antipapa resta una visione possibile, sebbene minoritaria e non riconosciuta ufficialmente. Ma il fascino dell'enigma resta vivo, anche perché tocca temi profondi: l'identità della Chiesa, il senso del potere spirituale e la lotta tra verità e apparenza. In una Chiesa sempre più sotto i riflettori e meno immune ai dubbi del mondo moderno, anche una rinuncia può diventare un enigma teologico.












![[VIDEO] Delitto di Garlasco: “un avvocato è propenso a far confessare” Stasi e “Marco sapeva di un filmato”. Ok la guerra dei “poveri” scontrini di Sempio, ma le “nuove” intercettazioni?](https://crm-img.stcrm.it/images/49138193/HOR_STD/600x/img-4939.jpg)