Immaginate la persona con cui dividete il letto che, ogni 14 febbraio, vi guarda negli occhi, abbassa la voce con tono grave e vi sussurra con quella faccia da fiction in prima serata: “Dobbiamo fare più sesso. È troppo importante, è il fondamento del nostro rapporto”. E poi, appena finita la cena, con la candela comprata dai cinesi ancora fumante, va a letto, si gira dall’altra parte e si mette a russare. Per dodici mesi esatti. Ecco, il primo maggio italiano è questa cosa qui: l’estasi verbale, la solennità delle intenzioni, l’indignazione civica e condivisa, l’erezione retorica, seguita da un intero anno di un cazzo di niente, un’astinenza feroce e metodica nel fare qualcosa di concreto per i salari da fame, i turni massacranti, i diritti ignorati, i contratti-fantasma e una precarietà non fa più nemmeno notizia. È solo rumore di fondo, inascoltato.
Ogni anno, a ogni primo maggio, si rispolverano gli stessi costumi di scena per i soliti ruoli del teatrino italiano: chi è Presidente della Repubblica nobilita, chi è premier annuncia, chi è all’opposizione promette. I sindacati sfilano in diretta Rai, gli editorialisti fanno gli editorialisti impegnatissimi e noi, poveri fessi, dovremmo crederci. A cosa, esattamente? Al fatto che a qualcuno – tra i palazzi romani, le redazioni paludate e soprattutto tra le aziende dove “risorse umane” vuol dire “roba consumabile” – interessi davvero che i salari italiani siano più bassi di quelli del 2008 o che si muoia di lavoro più che di vecchiaia? Ci crediamo quanto alla fedeltà coniugale delle rockstar, ma senza la contropartita di musica figa.
Sergio Mattarella ha parlato, come sempre, con la solennità di un maestro che ci sgrida perché non abbiamo fatto i compiti: “Il lavoro è radice di libertà, ha prodotto eguaglianza, coesione sociale”. Tutto vero, tutto giusto, tutto scritto nella Costituzione. Ma forse, con tutto il rispetto per il garante supremo, il momento di indignarsi per i salari da fame e per i morti sul lavoro non è oggi, né era ieri: era vent’anni fa, dieci, cinque, ogni lunedì, ogni venerdì. Ogni volta che uno muore su un’impalcatura per mille euro al mese. Ogni volta che si prende di meno lavorando di più.
Giorgia Meloni, da parte sua, ci regala il solito numero di prestidigitazione: un Consiglio dei ministri in cui fuori dall’ordine del giorno viene piazzato qualcosa di non meglio precisato sul lavoro. Soldi per la sicurezza? Forse. Nessuno ha capito bene cosa ci sia, nemmeno i sindacati, che non sono stati neanche convocati, come da tradizione (e come da tradizione nessuno comunque capisce realmente cosa farebbero realmente i sindacati per i lavoratori e non per garantirsi la sussistenza). E non è la prima volta che il Governo si convoca per “provvedere” al tema in trend per la festa dei lavoratori, come se l’1 maggio piovesse inaspettato, una data imprevedibile estratta a caso nella tombola del calendario. Ogni volta una bella confezione, il compitino imbonitore, ma nessuna sostanza. Un po’ come quei regali che ricevi e dentro ci trovi un buono sconto scaduto. E il risultato è sempre come negli spot degli shampoo: promessa di brillantezza, poi ti guardi allo specchio e fai cagare (quando non sei calvo).
Poi c’è Elly Schlein, la regina del se fossimo noi al governo. Salario minimo, bollette leggere, equità e sostenibilità. Tutto pronto. L’opposizione perfetta: non avendo responsabilità, può permettersi di dire tutto e illudere tutti, almeno quelli che ancora ci credono. Peccato che il partito che guida Schlein, il Pd, è quello che ha governato più di tutti negli ultimi decenni, e che mentre era al potere i salari non solo non sono cresciuti, ma sono scivolati sotto la linea di galleggiamento. Ma i loro lauti stipendi e quelli dei loro portaborse arrivavano, grassi, puntualissimi, garantitissimi (immeritatissimi?).

La verità è che parlare di lavoro il primo maggio (e solo il primo maggio o alla vigilia del primo maggio) è ipocrita e performativo. È una scusa per sentirsi buoni, civili, democratici. È una commemorazione laica ma sempre più maleodorantemente liturgica che serve solo a coprire con parole alte una realtà bassa, sporca, dimenticata. Un Paese in cui si lavora troppo e male per guadagnare troppo poco. Dove il merito e i diritti li vedi solo come prese in giro tragicomiche sui meme. Dove lo stipendio medio è un’offesa e quello minimo una chimera.
Così, ogni primo maggio, la nazione che vanta la più lunga e ininterrotta tradizione di promesse sul lavoro mai mantenute si presenta puntuale all’appuntamento con la retorica. Fiori virtuali sulla tomba della dignità salariale. Commemorazioni accorate. E poi via, niente fino al prossimo giro.
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto ciò che fa sempre: ha parlato bene, con quella grammatica limpida e insieme scolpita nella pietra tombale delle nostre istituzioni. Ha ricordato che “la Repubblica è fondata sul lavoro” e che “non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione”. Ma la domanda che dovrebbe sorgere spontanea e che invece nessuno fa è: caro Presidente, a chi lo dice? Agli stessi partiti e agli stessi politici che da trent’anni, a turno, hanno lasciato il mercato del lavoro in balia della precarietà, della stagnazione salariale, dei morti in cantiere e della presa in giro dei tirocini non retribuiti?
Il teatrino si ripete ogni anno. Gli stessi moniti quirinalizi, le stesse denunce sindacali, gli stessi provvedimenti mediaticamente strategici ma sostanzialmente nulli (ma buttandoci comunque tanti incomprensibili soldi), le stesse promesse che non saranno mantenute. E i media? Compunti, moralisti, emozionati. Come d’obbligo, come sempre. Ritagliano spazio tra un servizio su Chiara Ferragni e uno sull’oroscopo per riportare le parole del Capo dello Stato e le dichiarazioni fumose dei ministri e degli oppositori che subito gli spernacchiando (gli stessi oppositori che da ministri venivano spernacchiati). Nessuno che abbia l’ardire di chiedere: “Scusate, ma dopo l’ennesimo primo maggio di parole, possiamo vedere una fattura? Una busta paga che non sia un insulto all’intelligenza? Una norma applicata davvero?”. I giornaloni fingono che sia tutto nuovo, che ogni parola del Presidente sia un’epifania, che ogni promessa della Premier sia un piano Marshall (quelli di centrodestra), che quando tornerà il Pd allora sì, signora mia, che tutto andrà bene (quelli di centrosinistra). Intanto fuori, nel mondo reale, tutto costa di più, le buste paga della gente normale (ammesso che esistano) restano le stesse mentre l’inflazione cresce (e con lei gli adeguamenti salariali dei privilegiati), i lavoratori muoiono al lavoro o muoiono dentro.
Il lavoro, così com’è, non è una cosa da celebrare. È una fatica quotidiana, un dovere che non viene adeguatamente ricompensato (oltre che spesso, diciamolo, fatto alla cazzo, perché non valorizzato da nessuno e perché siamo sempre e comunque nella Repubblica dei furbastri). È quella cosa che ci definisce mentre ci uccide, lentamente o di colpo, nell’indifferenza delle aziende e nel disinteresse dei governi. Chi se ne ricorda il 2 maggio? Nessuno. Tranne i familiari delle vittime e i precari che non arrivano a fine mese, Per molti, troppi, il primo maggio non è una festa. È solo l’ennesima presa per il culo.
Perché il vero problema è questo: in Italia il diritto al lavoro è diventato una categoria spirituale. Se ne parla come si parla di Dio: con rispetto, con ardore, con fede cieca. Ma nessuno lo vede. Nessuno lo sente. Nessuno ci crede veramente. E quando ti viene somministrato in forma di liturgia terrena, spesso puzza di sfruttamento, di rischio, di povertà dignitosa, cioè l’ossimoro con cui cerchiamo di non impazzire.

Allora basta. Basta con i cortei finto-sovversivi, le bandiere stirate per l’occasione, i discorsi pieni di “dobbiamo”, “servirebbe”, “è urgente”. Se il lavoro è davvero sacro, allora iniziamo a smettere di parlarne solo il primo maggio, o, per coerenza, smettiamo di parlarne del tutto. È una questione di onestà intellettuale e di rispetto per chi, ogni giorno, porta a casa uno stipendio da fame e sa che prima delle riforme promesse arriverà la sua fine, reale o simbolica.
Il primo maggio non è la festa del lavoro. È la giornata della coscienza sporadica. Un giorno di parole ipocrite, di atti mancati, di riti vuoti. E il messaggio che arriva ai lavoratori è chiaro: vi pensiamo, per qualche ora all’anno, ma non vi salviamo. Vi celebriamo, ma non vi paghiamo. Vi piangiamo, ma solo a turno.
E torniamo a immaginare di vivere con una persona che a ogni San Valentino vi guarda negli occhi e vi proclama con ardore che “bisogna scopare di più”. Poi niente. Nemmeno una carezza. Solo la faccia seria, l’intenzione evocata, la promessa incastonata nella formalina dell’indifferenza. E non scopa per tutto il resto dell’anno. Quanto ci mettereste a mandarla affanculo, questa persona appassionata delle dichiarazioni e allergica ai fatti? E allora perché non facciamo lo stesso con la politica, che si presenta puntuale ogni primo maggio con la rosa rossa dei buoni propositi, ma ci incula (ma rigorosamente senza piacere, senza consenso, senza lubrificante) per tutti gli altri trecentosessantaquattro giorni?





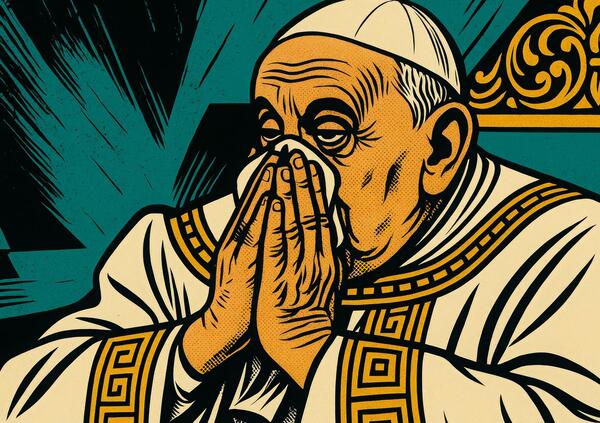


![Delitto di Garlasco: Bugalalla come Fabrizio Corona? Vogliono farle chiudere tutto! Ma spara altre intercettazioni di Ermanno Cappa, la moglie Maria Rosa e le gemelle Paola e Stefania [VIDEO]](https://crm-img.stcrm.it/images/49268027/HOR_STD/600x/photo-2025-01-22-23-44-12.jpg)



