Pisa. Un manipolo di manifestanti si avvicina a piazza dei Cavalieri. Svolta in via San Frediano, ma alla fine della strada una camionetta della celere blocca l’ingresso nella piazza. Davanti a loro dei poliziotti in tenuta antisommossa. Chi protesta si avvicina, continua a urlare, alza le mani, dicono, per segnalare che non li stanno attaccando. Che stanno solo avanzando, che vogliono sfondare il cordone di agenti, superare quanto è possibile superare e continuare una marcia altrimenti pacifica. Il problema è che i poliziotti son lì per impedirlo e hanno dei manganelli. Li hanno in mano, mentre le persone si avvicinano e forzano lo spazio di sicurezza e di inazione tra loro e i caschi, gli scudi, le armi delle forze dell’ordine. Lo scelgono loro, fin quando la polizia non carica e le prime file finiscono sotto i colpi violenti. Condannare quanto accaduto è troppo facile, ma non per questo sbagliato. Non bisogna fare l’errore di credere che quegli uomini in divisa stessero cercando di reprimere il dissenso. In modo più astratto, e per questo molto più efficace, stavano reprimendo una protesta, l’azione di una folla. Con il “kettling”, la tecnica di contenimento, e con delle cariche di pochi secondi utili a ripristinare la fascia di ossigeno che separa i manifestanti e il limite difeso. Alcuni video ritraggono l’inizio delle manganellate a ridosso della piazza, quando i manifestanti erano già attaccati alle facce dei poliziotti. In altri video si sentono gli insulti contro gli agenti: infame, sbirro di merda. Si vedono le persone avvicinarsi quanto più possibile alla barriera di agenti. Non c’è nulla di strano poiché, in questa situazione, lo scontro lo cercano tutti. Forse anche gli agenti. Questo dato di fatto non è una giustificazione per la reazione degli agenti. Si può condannare qualcosa e pretendere di capirla senza star dietro ai propri giudizi. Quelle manganellate restano sbagliate, ma fanno parte dell’economia della rabbia prima ancora che dell’economia della violenza.

Basterebbe recuperare quel piccolo capolavoro che è ACAB. All Cops Are Bastards, di Stefano Sollima. I tre celerini Negro, Cobra e Mazinga (interpretati magistralmente da Filippo Nigro, Pierfrancesco Favino e Marco Giallini) hanno perso qualsiasi senso del discrimine, qualsiasi filtro che permette di distinguere il bene dal male. La violenza è l’unica arma, la fratellanza l’unica forma di giustizia. Non c’entrano il senso dello Stato, la volontà politica o altro. Ci sono dei gladiatori che non vogliono farsi sbranare dai leoni: i tifoni allo stadio, i manifestanti, gli estremisti di destra e di sinistra. Se uno viene colpito gli altri lo difendono: non si abbandona un fratello, ripete Cobra; lo dice a se stesso prima che agli altri, lascia che rimbombi in testa, nel vuoto morale che lo spinge ad agire senza pietà. Neanche i manifestanti sono buoni. Chi cerca lo scontro fine a se stesso, chi forza la mano degli agenti, chi è avvelenato dalla frustrazione per il lavoro perso, per il migrante nella casa popolare dove abitava sua madre, per un furto di troppo da parte di un rumeno. Parlando del film, gli attori dissero che – pur non giustificando la violenza della polizia – capiscono la tensione, capiscono la storia. Perché anche quella è una storia, un intreccio, un gioco di rimpalli, provocazioni, adrenalina a mille. Sei un uomo addestrato, ma resti un uomo con in mano qualcosa di pericoloso di fronte a delle persone che ti insultano, che non si fermano, che vengono verso di te, che tu hai l’ordine di non lasciar passare, di dissuadere, ma sai che loro, almeno all’inizio, non si arrenderanno, non torneranno a casa. Verranno verso di te, dov’è inevitabile sbagliare. Ogni giorno è una guerra civile e ogni scontro non è solo quello, nella sua specificità – talvolta pacifica, talvolta violenta – e nella sua natura di evento unico, con persone diverse davanti a te. Alle spalle hai gli eccessi dei manifestanti e i tuoi, un lavoro violento in contesti che possono trasformarsi senza grandi previsioni in violenti.
Pisa non è il G8, da cui il film prende spunto (pur riferendosi, successivamente, agli anni 2006-2009 a Roma), ma pretendere che la testa di persone armate non abbia memoria sarebbe assurdo. Mentre noi ci indigniamo per quanto accaduto e le piazze si riempiono giustamente, gridano slogan che nulla c’entrano con quanto accaduto (“Palestina libera”, “Ceasefire now”, “Gaza libera”), in questo esercizio di amnesia collettiva che ci porta a leggere ogni evento come un caso di violenza eccezionale e spropositata, loro segnano le tacche sul manganello di quante volte lo hanno usato e non sanno quante volte dovranno usarlo. Condannare sì, capire anche. Se si condanna quanto accaduto non si può fingere di non voler capire che un manipolo di persone pacifiche che forzano una catena umana di celerini non rappresentino solo quella fila di sedicenni disarmati e impotenti, ma anche l’impotenza delle forze dell’ordine, disarmate moralmente dagli scontri, dal tempo che passa con logiche tribali, o noi o loro; è sempre così. Lo sa chi spinge verso lo scontro e lo sanno loro, che sono più forti, più organizzati. E magari altrettanto arrabbiati.

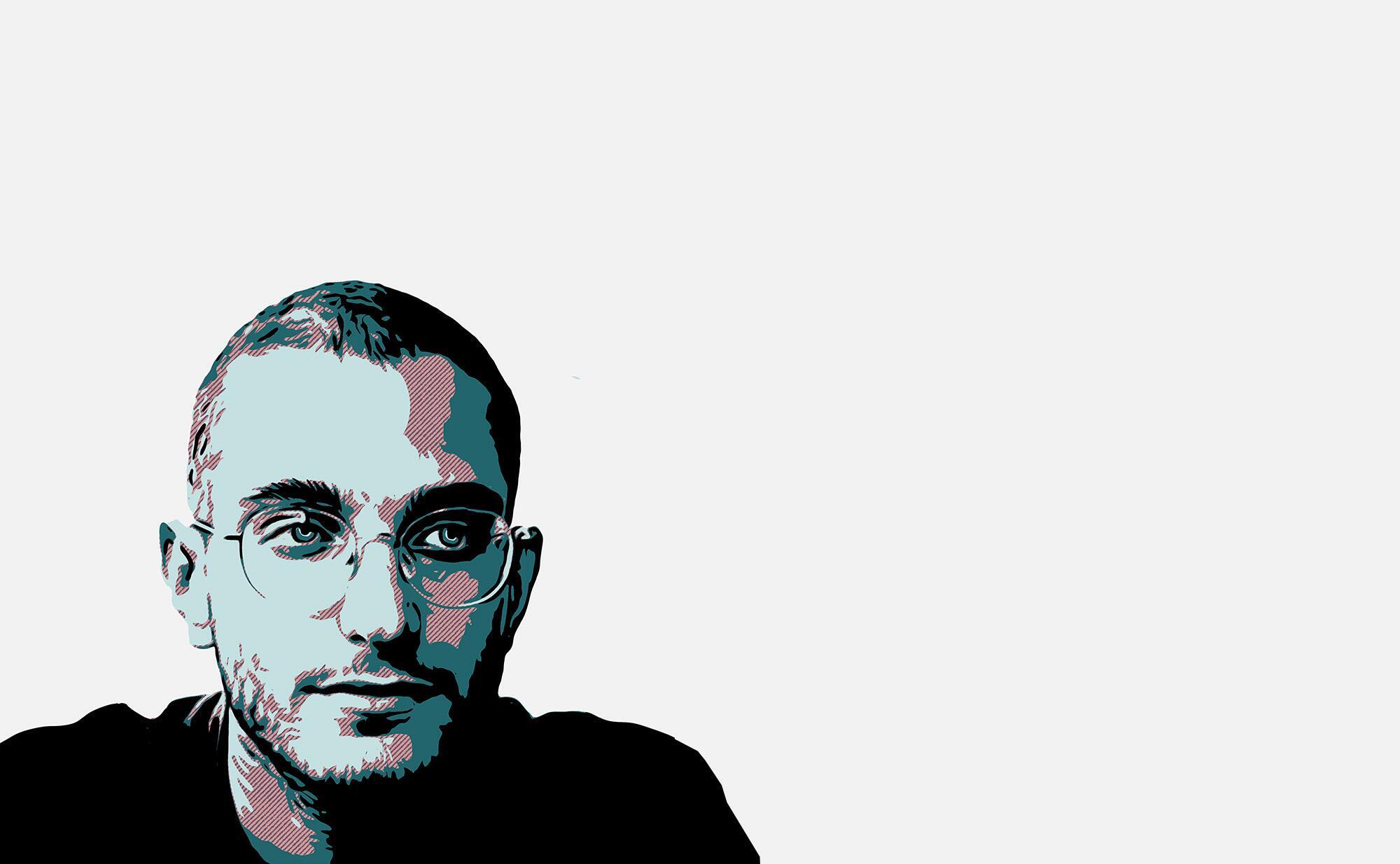


![Perché Flavia Carlini in lacrime denuncia di essere stata manganellata a Napoli? E parla di fascismo e genocidio durante la protesta sotto la Rai “pro-Israele”... [VIDEO]](https://crm-img.stcrm.it/images/35949757/HOR_STD/600x/20221103-080934634-3282.jpg)







